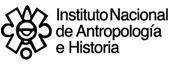

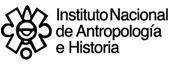

Artículos
Françoise Choay e l’Italia: urbanistica, architettura e restauro da Alberti a Giovannoni
Conversaciones…
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México
ISSN: 2594-0813
ISSN-e: 2395-9479
Periodicity: Bianual
no. 10, 2020

Sommario: l contributo indaga lo sviluppo del pensiero di Françoise Choay in materia di urbanistica, architettura e restauro attraverso la lente della cross-fertilization tra cultura italiana e francese, muovendo dalla sua stessa formazione e dalla precoce attenzione che in Italia si svilupp sui suoi primi scritti, a partire dal celebre L’urbanisme. Utopie et réalités (1965). Figure chiave di questo percorso sono Leon Battista Alberti – la cui opera, approfonditamente studiata dalla Choay, è stata diffusa in Francia anche grazie al suo contributo – e Gustavo Giovannoni, scoperto dalla studiosa negli anni 1980 e da lei identificato come antesignano della nozione di “patrimonio urbano”. Non meno rilevante è l’analisi del contributo più recente della Choay, rivolto ai temi del patrimonio e della globalizzazione, letto anche in questo caso dalla prospettiva dell’intenso rapporto della studiosa con l’Italia[1].
Parole: Françoise Choay, Italia, urbanistica, architettura, restauro.
Françoise Choay e l’Italia: urbanistica, architettura e restauro da Alberti a Giovannoni
È indubbio che Françoise Choay abbia contribuito in maniera determinante a definire la semantica e le contraddizioni del patrimonio culturale, attraverso una consistente mole di scritti pubblicati tra la fine del XX e gli inizi del XXI secolo. Il patrimonio – indagato tra “allégorie” e “questions”, per citare i titoli di due suoi celebri volumi – costituisce tuttavia solo uno dei molteplici campi nei quali la grande studiosa francese ha esplicato la sua vasta opera. Potremmo infatti dire, semplificando, che gli interessi della Choay – filosofa di formazione, con una particolare attenzione al pensiero di Martin Heidegger – abbiano spaziato in tutti gli ambiti del Costruire, abitare, pensare Heideggeriano[2], muovendosi dal campo delle arti visive per arrivare all’architettura, alla città e al territorio, fino a soffermarsi, negli anni della sua maturità, sul tema del patrimonio culturale, con una particolare predilezione per quello urbano.
Già celebre in Italia fin dai primi anni Settanta – grazie al successo del suo L’urbanisme. Utopie et réalités, pubblicato per la prima volta in Francia nel 1965 e tradotto in Italia col titolo La città. Utopie e realtà per i tipi di Einaudi nel 1973 – la Choay ha costituito innanzitutto un riferimento imprescindibile per la cultura urbanistica italiana per almeno un trentennio, dal principio degli anni Settanta alla fine del secolo. A partire dagli inizi degli anni Novanta, poi, il suo nome è entrato a giusto titolo tra i più autorevoli studiosi delle questioni storiche e teoriche relative al patrimonio culturale, grazie al suo L’Allégorie du patrimoine, pubblicato in prima edizione francese nel 1992 e di lì a poco tradotto in italiano (Choay, 1995a).
Parallelamente alla diffusione della sua opera nella penisola, la studiosa francese ha orientato i suoi interessi verso la cultura architettonica e urbanistica italiana, al punto che i suoi stessi argomenti di ricerca hanno beneficiato di una progressiva contaminazione con l’opera di studiosi passati e presenti dei fenomeni urbani. Tra questi spiccano senza dubbio due figure apparentemente piuttosto distanti tra loro, non solo cronologicamente: Leon Battista Alberti e Gustavo Giovannoni, ai quali la studiosa ha dedicato importanti approfondimenti. Se nel primo caso la Choay ha notevolmente favorito la conoscenza e la diffusione in Francia dell’opera albertiana – arrivando anche a curare con Pierre Caye, nel 2004, una traduzione e un’edizione critica del De re aedificatoria – nel secondo il suo contributo pu dirsi davvero determinante per la riscoperta della figura di Giovannoni, con riflessi persino nel nostro paese. Offuscata in Italia da una decennale damnatio memoriae, avviata già a partire dagli anni della sua scomparsa[3], la figura dell’ingegnere romano è stata infatti completamente riabilitata anche grazie al contributo della Choay, che vi ha attribuito un ruolo fondamentale nella definizione del concetto di “patrimonio urbano”. Lungo questo cammino i contatti e gli scambi tra la studiosa francese e la cultura architettonica italiana si sono via via intensificati, al punto che già a partire dagli anni Novanta la sua presenza in Italia è divenuta sempre più assidua, spesso in veste di visiting professor presso diversi atenei.
Del resto, la Choay – cresciuta alla scuola di André Chastel nel culto del Rinascimento italiano – non ha mai nascosto la sua “italianità” e la sua spiccata predilezione per la cultura del Bel Paese, tanto da intitolare la sua lectio per il conferimento della laurea honoris causa presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Genova, nel novembre 2001, Partire per l’Italia. Con questa espressione ella intende la necessità ineludibile, per ogni studioso francese che si rispetti, di immergersi profondamente nella cultura italiana, alla ricerca delle radici, consce e inconsce, della sua stessa identità culturale (Choay, 2008c). Appare pertanto evidente come la figura della Choay costituisca un caso emblematico di cross-fertilization tra cultura italiana e francese – ovvero di circolazione delle idee tra gli intellettuali dei due paesi – nel campo dell’urbanistica, dell’architettura e del restauro, che merita di essere indagato più approfonditamente, come di seguito si tenterà di fare.
La formazione e le prime esperienze tra filosofia, arti visive e architettura, 1954-1964
Discendente da un’antica famiglia protestante di origine alsaziana, Françoise Choay, nata Weiss il 25 marzo 1925[4], cresce in un milieu culturale e sociale di alto livello, nel quale, come ha osservato Thierry Paquot, “il protestantesimo alsaziano e l’ebraismo repubblicano si mescolano e si aprono al progresso sociale”[5] (Paquot, 2019: 275). Giovanissima, partecipa alla Resistenza francese, seguendo la madre nel dipartimento di Corrèze, dove svolge compiti di staffetta porta messaggi nell’ambito di un gruppo di resistenza di ispirazione stalinista, mentre studia filosofia per corrispondenza all’Università di Tolosa. Dopo il 1945 la famiglia si sposta nel dipartimento di Hérault per seguire il lavoro del padre, che vi è intanto stato nominato prefetto, e Françoise ottiene così la laurea in Filosofia presso l’Università di Montpellier. Nel frattempo, avendo acquisito notevole consuetudine con l’inglese e con il tedesco, trova lavoro a Bruxelles in un’associazione internazionale finalizzata a compensare le vittime della guerra (Paquot, 2019: 275-276). Decide tuttavia di proseguire i suoi studi alla Sorbonne, dove segue i corsi di Jean Hyppolite e Gaston Bachelard, ma anche di Claude Lévi-Strauss, al quale rimarrà fortemente legata.
Come da lei stessa ricordato in più occasioni, l’Italia non sembra svolgere un ruolo di grande rilievo negli anni della sua giovinezza e delle sue prime esperienze di studiosa. Al contrario, la Choay manifesta una spiccata consuetudine con il mondo anglosassone e soprattutto con quello germanico, di cui apprezza non soltanto la tradizione del pensiero, ma anche le arti figurative[6]. Il suo avvicinamento all’architettura muove innanzitutto dal campo fecondo dell’arte contemporanea, di cui la Choay è critica militante fin dal 1954 per diverse testate francesi come France-Observateur, L’Œil e La Quinzaine Littéraire. È in particolare attraverso la rivista d’arte franco-svizzera L’Œil, fondata nel 1955 e destinata al grande pubblico, che la Choay si interessa progressivamente di critica d’arte, senza tuttavia manifestare ancora particolari inclinazioni verso l’ambiente italiano. Se si eccettuano infatti le lunghe recensioni dedicate alla 29a e alla 30a Biennale di Venezia (Choay, 1958a; 1960a), il contesto culturale della penisola non costituisce oggetto di specifica attenzione.
È invece all’incontro personale con Jean Prouvé che si deve il primo contatto della studiosa con il campo della produzione architettonica, maturato in rapporto al tema del progetto contemporaneo dell’abitare. Alla metà degli anni Cinquanta Prouvé si era infatti distinto per aver realizzato la “Maison des jours meilleurs”, un’architettura di emergenza per la quale era stato impegnato anche l’attivista sociale Abbé Pierre, destinata a ospitare i più poveri a seguito del rigido inverno del 1954, che era costato la vita a molti senzatetto. Visitata dalla Choay, questa realizzazione dà luogo al suo primo scritto rivolto all’architettura, apparso su France-Observateur nel marzo 1956[7], mentre due anni dopo la studiosa dedica all’opera di Prouvé un ulteriore articolo per L’Œil, pubblicato nel 1958 (Choay, 1958d). Nello stesso anno, inoltre, la Choay esalta le virtù plastiche del cemento armato, firmando un’entusiastica introduzione al volume Le siège de l’Unesco à Paris[8], dedicato all’illustrazione della nuova sede parigina dell’UNESCO, realizzata su progetto di Marcel Breuer, Pier Luigi Nervi e Bernard Zehrfuss, inaugurata il 3 novembre 1958. A partire da questo momento gli articoli dedicati all’architettura crescono sensibilmente e la studiosa raggiunge presto una notevole celebrità: sempre su L’Œil la Choay si sofferma prima sul padiglione brasiliano realizzato da Le Corbusier per la Cité Universitaire parigina (Choay, 1959b), per poi ampliare il proprio orizzonte verso la città e il territorio, interrogandosi sul tema delle espansioni urbane. Nascono così approfondimenti sulle città di fondazione, tanto alla grande scala (Brasilia) (Choay, 1959d) che alla piccola (la ville nouvelle di Bagnolssur-Cèze e il suo rapporto con la città storica) (Choay, 1959a), ma anche precoci riflessioni sul tema delle città-giardino (Choay, 1959c).
In sostanza, già agli albori degli anni Sessanta, la Choay dimostra di padroneggiare con disinvoltura il vasto campo della critica architettonica, cimentandosi anche in commenti sulle questioni più attuali che coinvolgono il dibattito sulle trasformazioni urbane di Parigi, come il concorso per la Gare d’Orsay e, qualche anno più tardi, il problema scottante delle Halles (Choay, 1962)[9]. Suoi articoli su temi architettonici e urbani appaiono con intensità crescente anche in altre riviste, come Connaissance des arts, Art de France, Revue d’esthétique, dove spazia dal disegno industriale ai grands ensembles parigini, fino a proporre un bilancio sui vent’anni di architettura a partire dal dopoguerra (Choay, 1964a; 1964b; 1967a). In questo contesto, la sua posizione nei confronti dell’architettura e dell’urbanistica razionalista propugnata dai CIAM non è ancora netta, e lo dimostra la sua apertura verso Le Corbusier, al quale la Choay dedica la sua prima monografia, scritta direttamente in inglese, che nasce dal suo incontro con il fotografo Lucien Hervé, mediato ancora una volta da Jean Prouvé (Choay, 1994a: 3).
Pubblicato nel 1960 a New York dall’editore George Braziller e contemporaneamente tradotto in Italia per i tipi de Il Saggiatore (Choay, 1960b; 1960c), il volume in questione segna inoltre – proprio attraverso questa precocissima edizione italiana – il primo contatto diretto tra gli scritti della Choay e il pubblico del nostro paese, che sorpassa persino la Francia: è significativo, in tal senso, che non esista ancora oggi un’edizione francese di tale opera[10]. Il testo giunge nel nostro paese in un momento particolarmente emblematico per gli studi su Le Corbusier, che hanno già raggiunto notevole estensione e appaiono concentrati sulla svolta stilistica che segna la produzione del maestro nel secondo dopoguerra e in particolare sulla cappella di Ronchamp[11].
La Choay affronta Le Corbusier, all’epoca ancora pienamente attivo, senza indulgere né in una incondizionata esaltazione del suo talento né in una sistematica contestazione delle sue idee e delle sue realizzazioni, cosa che invece avverrà, in modo sempre più intenso, nei suoi scritti degli anni successivi[12]. In questo testo del 1960, sintetico ma efficace, la studiosa ripercorre infatti l’intera attività dell’architetto svizzero evidenziandone il temperamento polemico e ponendo in stretta relazione la sua produzione architettonica con quella saggistica, intese “come due espressioni di un’unica concezione”, mirando in tal senso “alla ricerca del significato e dello spirito dell’opera di Le Corbusier”[13]. L’aspetto più interessante del volume consiste nella confutazione della visione esclusivamente funzionalista che la critica vorrebbe attribuire a Le Corbusier, nella quale la Choay individua una responsabilità anche italiana, dovuta in particolare all’opera di Bruno Zevi, che mostra di conoscere direttamente[14]. Per la Choay, al contrario, Le Corbusier è un architetto che pone sempre l’uomo al centro dei suoi progetti, dalla scala dimensionale all’impiego dei materiali. Per lui “costruire è essenzialmente un’attività sociale diretta all’uomo e alla soluzione dei suoi problemi. L’opera di Le Corbusier reca l’impronta sia del razionalismo sia dell’immagine dell’uomo. Ma questa immagine svolge un ruolo complesso” (Choay, 1960c: 18).

La città fra utopie e realtà, 1965-1973
A partire dagli inizi degli anni Sessanta la Choay si avvicina progressivamente al tema della città. Una prima testimonianza, in tal senso, è costituita dal già citato articolo sui “Grands ensembles et petites constructions”, pubblicato nel 1964, nel quale la studiosa critica duramente la prima fase della grande decentralizzazione parigina – avviata nel 1955 – intravedendo qualche speranza nel nuovo corso dell’urbanistica francese. La sua condanna nei confronti di questi primi esperimenti di grands ensembles – privi di “segni e simboli espressivi”, sognati “da un De Chirico miserabilista”, oppressi dalla “tirannia della strada”, dove “la presenza umana è evocata solamente da panchine e antenne televisive”[15] – segna dunque il momento di rottura con la fiducia nell’urbanistica dei CIAM.
È in questo contesto di riflessione che la Choay inizia a lavorare su quello che diventerà certamente il suo seminal book, destinato a conferirle una straordinaria notorietà internazionale, che attraverserà diverse generazioni di studiosi: L’urbanisme. Utopies et réalités, pubblicato per la prima volta a Parigi nel 1965. Il libro esce per le Éditions du Seuil – casa editrice a cui la Choay affiderà in seguito quasi tutti i suoi lavori – che proprio un anno prima aveva affrontato il tema della città traducendo un volume fondamentale per la cultura urbanistica del secondo Novecento come The city in history di Lewis Mumford (1961; 1964)[16].
Come da lei stessa ricordato in seguito, L’urbanisme. Utopies et réalités è un lavoro che parte da una domanda ineludibile e assillante per i tempi in cui il libro viene scritto: rintracciare i pretesi fondamenti scientifici dell’urbanistica e dimostrarne ambiguità e contraddizioni, alla luce della crisi della città industriale e della riconosciuta incapacità dei suoi attori di governarne i processi (Choay, 1996a: 15-16). La risposta viene ricercata nei testi fondativi della disciplina, selezionati a partire dagli inizi del XIX secolo, che vengono presentati in forma antologica per suggellare la tesi di una sostanziale assenza di statuto scientifico dell’urbanistica, denunciando “l’impostura di una disciplina che, in un periodo di costruzione febbrile, imponeva la sua autorità senza condizioni”[17] (Choay, 1996a: 16).
Abituata per formazione allo studio delle fonti primarie e fortemente versata alla didattica, la Choay fornisce dunque attraverso il volume un florilegio di testi sulla città e l’urbanistica, molti dei quali fino ad allora poco noti al pubblico francese anche per l’assenza di traduzioni[18]. L’insieme dei testi è suddiviso in categorie che la studiosa giustifica e motiva nel suo lungo saggio introduttivo, pur consapevole della provvisorietà e della fallacità di ogni distinzione troppo netta[19]. Ecco dunque raggruppati, innanzitutto, gli scritti che precedono la nascita della disciplina sul piano tecnico, ascrivibili a una fase di “preurbanistica”, ovvero quelli di teorici, storici ed economisti che intendono la crisi della città in stretta dipendenza con quella della società. A fronte del disordine sociale e urbano questi ultimi si rifugiano nell’utopia, dirigendosi verso due modelli opposti in funzione del vettore tempo: quello “progressista”, che crede ottimisticamente nel futuro (di cui fanno parte, tra gli altri, Owen, Fourier, Proudhon, Richardson) e quello “culturalista”, che guarda nostalgicamente al passato (Pugin, Ruskin, Morris). Ma vi sono anche preurbanisti “senza modello” e tra questi la Choay colloca due pensatori del calibro di Engels e Marx, insieme a Kropotkin.
Anche nel secondo gruppo di scritti – quelli corrispondenti alla fase della vera e propria “urbanistica”, quasi tutti provenienti da un orizzonte tecnico – è possibile, secondo la Choay, individuare i due modelli citati in precedenza, quello progressista e quello culturalista, ma non solo questi, come vedremo. Al primo modello ella ascrive innanzitutto le elaborazioni di Tony Garnier, ma soprattutto quelle di Le Corbusier, presto confluite nell’attività dei CIAM, sulle quali la studiosa esprime maggiori critiche rispetto a quanto aveva fatto nella monografia del 1960. Alla predicazione della Carta di Atene la Choay attribuisce infatti l’indifferenza alla topografia e al contesto propria dei piani di Le Corbusier e dei suoi epigoni: “Nasce così ‘l’architettura del bulldozer’, che livella montagne e colma le valli”[20]. Al secondo modello, quello culturalista, si possono invece riferire i contributi di Camillo Sitte, Ebenezer Howard, Raymond Unwin, che la Choay accomuna per la presenza sottile di un “modello nostalgico”. In aggiunta ai due insiemi precedenti, e in parallelo con le tendenze antiurbanistiche americane già evidenziate nella fase preurbanistica, la studiosa individua la nascita di un nuovo modello “naturalista” nella prima metà del Novecento, incarnato dalla figura di Frank Lloyd Wright e dalla sua Broadacre City, vera antitesi dell’urbanistica coercitiva dei CIAM[21].
“La risposta ai problemi urbani posti dalla società industriale – aggiunge tuttavia la Choay – non si esaurisce né nei modelli dell’urbanistica, né nelle realizzazioni concrete che questi hanno ispirato”: esiste infatti “una critica di secondo grado” (Choay, 1973: 51) che si è sviluppata nel corso del Novecento e che deve essere presa attentamente in considerazione. In quest’ambito la Choay attribuisce un ruolo fondamentale all’opera di Patrick Geddes e a quella del suo più fedele discepolo Lewis Mumford, entrambi fautori di una “urbanistica della continuità”. Quest’ultima deve mirare alla reintegrazione “dell’uomo concreto e completo nel processo di pianificazione urbana” (Choay, 1973: 57), attraverso un sistema di “inchieste” che comprendono le più vaste competenze, dalla sociologia alla storia. Ai contributi di Geddes e Mumford, conclude la studiosa, si deve la formazione di una coscienza critica che ha influenzato fortemente l’ambiente dei paesi anglosassoni, dando luogo alla nascita degli urban studies (Choay, 1973: 60). Infine, ancora nell’ambito della critica di secondo grado, la Choay individua due ulteriori filoni più attuali, quello della “igiene mentale” – inteso come un ulteriore approccio teso ad evidenziare i limiti dell’urbanistica progressista, proveniente da psichiatri, sociologi, attivisti, come nel caso di Jane Jacobs e del suo celebre volume The death and life of great American cities (1961) – e quello della “percezione urbana”, testimoniato dagli studi di Kevin Lynch. Da queste riflessioni la Choay trae la conclusione che “il macrolinguaggio dell’urbanistica è imperativo e coercitivo”, lasciando il cittadino al di fuori di ogni processo decisionale: “l’urbanista monologa o arringa, l’abitante è costretto ad ascoltare, talvolta senza capire” (Choay, 1973: 78).
Come il lettore avrà già notato, in questa articolata disamina dell’orizzonte teoretico dell’urbanistica l’Italia risulta completamente assente, ancorché compaia qualche riferimento bibliografico agli studi di Zevi e Argan. Ci conferma quanto già osservato in premessa, e cioè che il reale avvicinamento alla cultura italiana da parte della Choay sia da riferire ad anni successivi. È pur vero che, anche conoscendo meglio il contesto italiano, non sarebbero stati molti i teorici italiani citabili nell’antologia, ma è certo che una figura come quella di Gustavo Giovannoni, in seguito così apprezzata dalla Choay, avrebbe potuto ben meritare un posto. Com’è noto, tuttavia, alla metà degli anni Sessanta l’ingegnere romano scontava ancora un radicale ostracismo nel suo stesso paese, tale da rendere piuttosto difficile la conoscenza della sua opera al di fuori dei confini italiani. Questa sostanziale distanza della Choay dal contesto culturale della penisola sarebbe perdurata ancora fino ai primi anni Settanta, come testimoniano i successivi scritti della studiosa dedicati alla città.
Nel 1967, a soli due anni di distanza dalla pubblicazione de L’urbanisme. Utopies et réalités, la Choay affronta il tema del rapporto tra semiologia e urbanistica, inserendosi nel dibattito – allora molto fervido – che ruota attorno alla possibilità di applicare gli esiti della linguistica strutturale all’architettura e alla città. Con un articolo destinato a notevole successo – apparso prima su L’Architecture d’aujourd’hui (Choay, 1967b: 8-10) e poi tradotto in inglese per un volume collettaneo dal significativo titolo di Meaning in architecture, che ospita contributi di altri autorevoli studiosi, già allora piuttosto celebri[22] (poi a sua volta edito in Francia nel 1972 col titolo Le sens de la ville) (Jencks and Baird, 1969; Choay et al., 1972) – la Choay dimostra l’applicabilità della semiologia ai fenomeni urbani. La sua tesi si sviluppa attraverso il significativo esempio del villaggio Bororo, studiato dal suo maestro Lévi-Strauss in Tristes tropiques (1955) e ancor più diffusamente in Anthropologie structurale (1958), sul quale lei stessa tornerà più volte nei suoi successivi scritti. La pianta del villaggio evidenzia infatti una rigida ed esplicita organizzazione spaziale, specchio di molteplici significati che influenzano i rituali e la vita dei suoi abitanti: essa pertanto attesta la sua dimensione semiologica. Dalla conferma della possibilità di applicare la semiologia all’urbanistica consegue tuttavia, per converso, la constatazione dell’impoverimento di significati nella città moderna, che appare “ipo-significante” (Choay, 1972: 18) a confronto con quella del passato, anche a causa della veloce obsolescenza del suo spazio fisico in rapporto al progresso tecnologico. È un passaggio che si compie attraverso i secoli, nel quale gioca un ruolo importante anche la città rinascimentale italiana, prima tappa di un processo di rappresentazione dello spazio urbano che condurrà a una dimensione ludica della città, fenomeno tuttavia all’epoca ancora limitato a ristrette élites sociali. Citando brevemente Leon Battista Alberti e Francesco di Giorgio Martini come “primi antenati dei nostri urbanisti”[23] (Choay, 1972: 11), la Choay mostra quindi un primo avvicinamento alla vicenda italiana, che tuttavia appare ancora piuttosto limitato rispetto a quanto accadrà negli anni successivi.
A riprova di ci si pu citare il successivo volume The modern city: planning in the 19th century (Braziller, New York 1969), apparso nella collana Planning and cities diretta da George R. Collins, che traccia un profilo dell’urbanistica del XIX secolo nel quale la Choay dedica all’Italia soltanto poche parole, accennando ai piani regolatori di Alessandro Viviani per Roma (1873 e 1883) e alle realizzazioni di Corso Vittorio Emanuele e via Nazionale (quest’ultima, com’è noto, avviata già prima del 1870) come esempi solo in parte ispirati alle regolarizzazioni haussmaniane (Choay, 1969: 21).
Le ricerche della Choay sullo spazio urbano proseguono con una particolare focalizzazione sul contesto francese, come testimonia il bel volume fotografico Espacements, titolo che darà vita anche a una omonima collana diretta per lunghi anni dalla studiosa per le Éditions du Seuil. Apparso fuori commercio per un’impresa privata nel 1969 ed edito solo molti anni dopo in Italia[24], il volume è articolato in quattro capitoli, attraverso i quali la studiosa introduce altrettante “figure distintive” dello spazio urbano dal Medioevo ai nostri giorni, che avranno notevole fortuna nella letteratura successiva: Espace de contact, per il Medioevo; Espace de spectacle, per l’epoca classica; Espace de circulation per i secoli XIX e XX; Espace de connexion per i tempi attuali[25]. Questo lavoro coincide temporalmente anche con l’avvio della carriera universitaria della Choay: coinvolta già a partire dal 1966 dallo storico e critico d’arte Robert Louis Delevoy in alcuni corsi a Bruxelles presso l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre, la studiosa è infatti chiamata nel 1971 da Pierre Merlin a insegnare presso il Département d’urbanisme du Centre universitaire expérimental de Vincennes, fondato dallo stesso Merlin con il sociologo Hubert Tonka negli anni 1968-1969, che in seguito diverrà l’Institut Français d’Urbanisme dell’Université de Paris VIII, dove la Choay sarà nominata professore ordinario e infine emerito (Paquot, 2019: 279-280).
In questo quadro giunge finalmente la traduzione italiana de L’Urbanisme. Utopies et réalités, pubblicata da Einaudi in due tomi col titolo La città. Utopie e realtà nel 1973. L’approdo dell’opera nel contesto culturale della penisola pu certamente considerarsi la prima significativa tappa del fecondo rapporto di cross-fertilization che legherà la Choay all’Italia nei decenni a venire. Persino la genesi di questa traduzione ne è testimonianza: il buon esito si deve infatti al diretto interessamento di Italo Calvino[26], che da oltre un ventennio ricopre ruoli progressivamente più influenti presso le edizioni Einaudi, avendovi tra l’altro pubblicato, solo un anno prima, il suo fortunatissimo Le città invisibili (1972). La coincidenza non sembra casuale: ancorché non vi sia alcuna esplicita allusione al testo della Choay nel volume di Calvino, appare più che probabile che egli – già da tempo assiduo frequentatore dell’ambiente parigino, dove risiedeva stabilmente dal 1967 – possa aver trovato parziale ispirazione nel lavoro della studiosa francese.
Del resto, per quanto diversissimi nella genesi, nella struttura e negli esiti, i due testi muovono entrambi dalla constatazione di una profonda crisi della città industriale. L’uno, quello della Choay, ripercorre scientificamente la genesi delle idee e dei fondamenti teorici che hanno prodotto la situazione attuale. L’altro, quello di Calvino, si muove sul filo di un immaginario poetico, alla ricerca “delle ragioni segrete che hanno portato gli uomini a vivere nelle città” (Calvino, 1993). Entrambi, tuttavia, paventano il fallimento della vita urbana.
Scrive infatti la Choay nel suo saggio introduttivo:
Dalle quadras di Brasilia ai quadrilateri di Sarcelles, dal foro di Chandigarh al nuovo foro di Boston, dalle highways che sfasciano San Francisco alle autostrade che sventrano Bruxelles, ovunque nasce la stessa scontentezza, la stessa inquietudine. […] Questo libro non si propone di apportare un contributo addizionale alla critica dei fatti: non si tratta di denunciare una volta di più la monotonia architettonica delle nuove città o la segregazione sociale che vi regna. Abbiamo voluto ricercare il significato stesso dei fatti, mettere in evidenza le ragioni degli errori commessi, l’origine delle incertezze e dei dubbi che oggi suscita ogni nuova proposizione di ordinamento urbano (Choay, 1973: 3-4).
E Calvino, commentando il proprio testo poco dopo la pubblicazione: “Penso d’aver scritto qualcosa come un ultimo poema d’amore alle città, nel momento in cui diventa sempre più difficile viverle come città. Forse stiamo avvicinandoci a un momento di crisi della vita urbana, e Le città invisibili sono un sogno che nasce dal cuore delle città invivibili” (Calvino, 1993: IX).
Nel presentare l’edizione italiana della sua opera, la studiosa svolge anche un primo bilancio sugli otto anni trascorsi dal libro, chiarendo la maturazione del suo pensiero e la sua intenzione di considerarlo ormai una introduzione ad una prossima ricerca, finalizzata a rintracciare le origini più remote del discorso del XIX secolo. È l’annuncio, ancora in forma embrionale, del lavoro che sfocerà nel suo La règle et le modèle, dedicato principalmente al De re aedificatoria di Leon Battista Alberti, che apparirà nel 1980. Ma la prefazione all’edizione italiana è anche l’occasione per soffermarsi su altre figure, non trattate ne La città. Utopie e realtà, “che, senza mirare a ‘cambiare il mondo’” hanno “contribuito a formare un nuovo rapporto con l’urbanistica” (Choay, 1973: X). Tra queste la Choay colloca il barone Haussmann e Ildefonso Cerdà. Sul primo, in particolare – al quale dedicherà negli anni successivi importanti approfondimenti – la studiosa sente già allora la necessità di “sottolineare l’originalità del suo contributo e osservarne le differenze in rapporto alla via seguita dai suoi contemporanei, in particolare gli utopisti”, a fronte del perdurare di forti pregiudizi nei confronti della sua figura, inclini ancora a ridurre “alla leggera la sua opera alle dimensioni di una operazione poliziesca”, come nella lettura fortemente ideologica di Henri Lefebvre (Choay, 1973: XI)[27].
Viaggio nel Rinascimento italiano: La règle et le modèle e il lavoro su Leon Battista Alberti
Possiamo certamente dire che la figura centrale del rapporto tra la Choay e l’Italia sia stata Leon Battista Alberti[28], al quale la studiosa ha dedicato intense ricerche già a partire dai primi anni Settanta, originate dal dibattito dell’epoca sulle villes nouvelles[29]. Questo iniziale interesse è poi sfociato nella sua tesi di dottorato, sviluppata sotto la direzione di André Chastel e discussa nel marzo 1978. L’esito di questo lungo lavoro è costituito dal volume La règle et le modèle, pubblicato a Parigi per le Editions du Seuil nel 1980, che giungerà sei anni dopo all’edizione italiana, a cura di Ernesto d’Alfonso (Choay, 1980; 1986). Si tratta di un testo che si pone in esplicita continuità con la prima opera della Choay, L’urbanisme. Utopies et réalités, il cui obiettivo è l’indagine sulle origini della teoria dell’urbanistica al di là dei convenzionali testi ottocenteschi, sui quali si erano concentrati i primi anni di ricerca della studiosa.
La tesi fondamentale del libro, racchiusa nel titolo, è che le teorie dell’architettura e dell’urbanistica abbiano oscillato nei secoli a partire da due archetipi, quello della regola e quello del modello, simboleggiati da due testi “inaugurali”: nel primo caso il De re aedificatoria albertiano e nel secondo l’Utopia di Thomas More. Ma se nel primo è possibile riconoscere ancora un carattere “ludico”, che mette insieme regole e libertà creatrice, il secondo appare coercitivo e costrittivo. Così gli approcci della “regola” e del “modello” si rivelano antitetici, conducendo a una “temibile” scelta tra due concezioni: “l’una edonista, egotica, permissiva, l’altra correttiva, disciplinare, medicale”[30] (Choay, 1980: 334), quest’ultima incarnata dal fallimento della città contemporanea. In tal senso le due figure di Alberti e More, con i rispettivi testi, costituiscono l’ossatura primaria del libro, tanto che l’autrice vi dedica due corposi capitoli, senza nascondere la sua dichiarata preferenza per l’opera albertiana. Quest’ultima viene collocata dalla Choay nella duplice valenza di continuità e rottura rispetto al Quattrocento italiano, periodo al quale ella riconosce un ruolo cruciale, “senza equivalenti anteriori in nessun’altra cultura”[31] (Choay, 1980: 14), nella definizione di un discorso autonomo sullo spazio edificato.
L’interesse dell’autrice per Alberti si sviluppa quindi ulteriormente proprio in occasione dell’edizione italiana del volume, apparsa nel 1986, per la quale la Choay riscrive interamente il secondo capitolo dell’opera, dedicato appunto all’analisi del De re aedificatoria. È una riflessione che passa per un’ulteriore maturazione del pensiero della studiosa[32] tra il 1981 e il 1982, dedicata agli “operatori”[33] del testo albertiano e al rapporto di quest’ultimo con il trattato di Vitruvio, rispetto al quale la Choay ritiene il lavoro di Alberti decisamente originale[34]. Già in questo passaggio, la Choay riconosce all’opera albertiana il carattere di testo “instauratore, che si propone di fondare l’edificazione come disciplina specifica e autonoma”[35] (Choay, 1988b: 83), rispetto ad altri tipi di trattati che, in tutte le culture, virano piuttosto nel commentario o nella prescrizione. Questo processo di affinamento della sua lettura di Alberti beneficia inoltre di un ulteriore avvicinamento diretto alla cultura del nostro paese, sviluppato proprio negli anni 1980-1986, ovvero tra la prima edizione francese del volume e la traduzione italiana. È in questo momento, infatti, che si struttura il rapporto della Choay con il Politecnico di Milano, mediato da Ernesto d’Alfonso, che invita la studiosa a un seminario, svolto nel novembre 1983, dedicato proprio al confronto tra sguardi incrociati sul tema della storia e del progetto, originati dalla precoce lettura dell’edizione francese de La règle et le modèle. Gli esiti di questo incontro, raccolti due anni dopo nel volume Ragioni della storia e ragioni del progetto (d’Alfonso, 1985), testimoniano la veloce ricezione del volume della Choay in Italia e lo stimolo al dibattito che esso produce. Vi ritroviamo infatti riflessioni sul ruolo della storia, della teoria e del progetto, sviluppate da studiosi di discipline diverse, da Cesare Stevan a Maria Luisa Scalvini, da Giancarlo Consonni a Bianca Bottero, da Augusto Rossari ad Antonio Monestiroli, per citarne solo alcuni[36]. Riflessioni che sono originate – fatto ancor più significativo per il processo di ibridazione culturale – a partire da un testo inedito della Choay distribuito in anteprima ai partecipanti e poi pubblicato in appendice al volume: “Il De re aedificatoria quale testo inaugurale”, che la studiosa aveva presentato a un convegno a Tours nel 1981 e che sarà pubblicato solo nel 1988 in Francia, ma anticipato dalla pubblicazione italiana del 1985 (d’Alfonso, 1985: 130-143)[37].
Questo intenso scambio dei primi anni Ottanta è alla base della traduzione italiana de La règle et le modèle, giunta in porto nel 1986. È significativo, dunque, che proprio l’approdo del volume in terra italiana conduca l’autrice a sviluppare e approfondire la lettura di Alberti, presentando al pubblico del nostro paese una trattazione decisamente più ricca della prima edizione francese. Il confronto tra i due capitoli relativi al trattato albertiano nelle due edizioni del 1980 e del 1986 rivela infatti, innanzitutto, una maggiore estensione della trattazione, già soltanto nella descrizione del contenuto dei dieci libri, che si avvale anche di un maggior numero di esempi e di citazioni. Ma l’aspetto più rilevante dell’analisi proposta dalla Choay sul De re aedificatoria consiste nell’aver progressivamente riconosciuto un vero e proprio “progetto antropologico” alla base del trattato albertiano, tema sul quale la sua ricerca proseguirà ancora nel corso degli anni Novanta[38]. Così, nell’edizione italiana del 1986, la studiosa evidenzia il carattere instauratore del trattato e ne propone un attento smontaggio attraverso tabelle che erano assenti nell’edizione francese[39], finalizzato a disvelarne la struttura latente. Quest’ultima, per la Choay, si scopre a dispetto del carattere erratico di molti passaggi, che disorientano il lettore frettoloso, come quando Alberti “mette lo stesso zelo nell’enunciare regole universali della costruzione e quelle utili ad evitare che gli intonaci si spacchino” (Choay, 1986: 94). La solidità del trattato appare invece chiara se si procede dal libro I al libro IX, in una struttura a piramide rovesciata[40] dove si passa dal livello di “necessità” a quello di “comodità”, fino al “piacere” dell’architettura, mentre al libro X – ritenuto dall’autrice spurio rispetto al resto della trattazione (Choay, 1986: 140) – è affidato il livello di “correzione”.
A dispetto di questa lettura appassionata e per molti versi innovativa proposta dalla Choay, tuttavia, l’ambiente italiano reagisce in maniera controversa. La “scuola romana” di storia dell’architettura, in particolare, ne prende subito le distanze: in una lunga recensione pubblicata nel 1987 su “Architettura. Storia e documenti”, Renato Bonelli stigmatizza il “fallimento” del libro, che si rivela “deludente e pretestuoso, scritto in modo confuso, disordinato, a tratti involuto e oscuro, carico di molte parti gratuitamente aggiunte, che ci perviene attraverso una scadente traduzione” (Bonelli, 1987: 188).
La stroncatura di Bonelli muove innanzitutto dal confutare la lettura semiologica proposta dalla Choay nei confronti dei due trattati di Alberti e di More che, a detta dell’autore, risulta carente anche nella cognizione dei coevi sviluppi critici sul rapporto tra semiologia e architettura, fatta eccezione per l’opera di Umberto Eco (Bonelli, 1987: 186). In più, l’interpretazione del De re aedificatoria, “porta l’autrice a stravolgere il testo albertiano per ritrovarvi a forza quello che non c’è, per ridurre a entità astorica e cristallizzata un prodotto eminentemente storico” (Bonelli, 1987: 187). Per Bonelli ci conduce all’equivoco di poter “accostare Cerdà, Le Corbusier, o i CIAM all’Alberti e a Th. More”, operazione “destinata fin dall’inizio al fallimento” (Bonelli, 1987: 188), anche per la mancata distinzione concettuale tra architettura e urbanistica – oltre che tra architettura e edilizia – che porta la Choay ad attribuire un peso eccessivo al ruolo discorsivo nella produzione concreta dello spazio[41]. Pur convenendo su alcune critiche mosse da Bonelli a La regola e il modello, è facile riconoscere, oggi, nel suo duro giudizio, gli esiti della sua impostazione rigidamente idealistica, contraria a ogni analisi troppo condizionante la libertà creatrice. Ci appare ancor più evidente nella conclusione, dove egli si oppone decisamente all’invito della Choay a ripensare lo spazio urbano alla luce delle letture di Alberti e More: “Il processo di rinnovamento del linguaggio architettonico non obbedisce di certo a prescrizioni dettate dall’esterno, come quelle proclamate nelle ultime pagine del libro, ma dipende esclusivamente dalla creatività dell’uomo, che si manifesta sempre secondo soluzioni inattese e forme imprevedibili” (Bonelli, 1987: 189).
Per nulla turbata da queste obiezioni, la Choay porta avanti il suo lavoro su Alberti con diverse pubblicazioni negli anni successivi. Quando tuttavia, nel 1996, introduce la seconda edizione francese de La règle et le modèle – apparsa sedici anni dopo la prima – la studiosa non esita a dichiarare superate molte concezioni del suo libro, precisando che, alla luce delle evoluzioni del presente, non lo avrebbe più scritto in tal modo. Per converso, la Choay conferma la validità euristica ed ermeneutica degli strumenti epistemologici adottati nella sua analisi, in particolare per i testi di Alberti e More (Choay, 1996b: 12). Qualche anno più tardi la studiosa arriva persino a curare, con Pierre Caye, una nuova traduzione francese del De re aedificatoria (la seconda, dopo l’unica esistente di Jean Martin del 1553), che sfocia in un’edizione critica del trattato nel 2004. In questo “corpo a corpo” con il testo albertiano (Choay, 2008e: 52), la Choay vi riconosce un passaggio fondamentale della maturazione del suo pensiero sul patrimonio. In proposito infatti ammetterà: “Senza la violenza con cui Alberti, iniziatore di una nuova architettura, condanna la distruzione ingiustificata degli edifici medioevali che continuano a rispondere alle loro funzioni, non mi sarei probabilmente mai dedicata alle questioni del patrimonio costruito né interessata al senso che assume attualmente la sua conservazione” (Choay, 2008c: 24).
Proseguendo ancora le sue ricerche su Alberti attraverso un volume curato nel 2006 con Michel Paoli – che di per sé rappresenta, nel ricco parterre di studiosi francesi e italiani coinvolti[42], un significativo tassello di quel processo di cross-fertilization già richiamato – la studiosa arriverà a osservare che il valore del trattato albertiano consiste proprio nell’aver posto la “questione dell’edificare” alle più remote origini della stessa storia del genere umano (Choay, 2006b; 2006c). Si tratta di un’interpretazione che trova riscontro, in Italia, anche nella lettura già proposta qualche decennio prima da Giulio Carlo Argan[43], e che viene accolta favorevolmente da Marco Dezzi Bardeschi in occasione della pubblicazione del testo francese prima citato[44].
In definitiva tutti questi scambi provano in maniera evidente la circolarità del pensiero tra Italia e Francia nell’ambito degli studi albertiani, a cui la Choay ha contribuito in modo determinante. Non stupisce, infatti, che la studiosa figuri tra i membri fondatori della prestigiosa rivista Albertiana, tuttora attiva e pubblicata a partire dal 1998 dalla Societé Internationale Leon Battista Alberti, a sua volta istituita nel 1995 in stretta collaborazione tra i due paesi con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Anche attraverso questa rivista, dunque, dove nel primo numero la Choay pubblicava un articolo dedicato a “L’architecture d’aujourd’hui au miroir du De re aedificatoria” (Choay, 1998b), la studiosa ha portato avanti un significativo processo di acculturazione incrociata tra Italia e Francia, condiviso nel comitato di direzione con altri autorevolissimi studiosi albertiani, tra i quali hanno sempre prevalso, non a caso, italiani e francesi[45].
Verso il patrimonio: dalla “scoperta” di Giovannoni agli sviluppi dell’Allégorie, 1981-1998
È agli inizi degli anni Ottanta, e più precisamente nel 1981, che la Choay entra in contatto con l’opera di Gustavo Giovannoni[46], al quale dedicherà un’attenzione crescente, fino a includerlo nella ristretta élite di figure che animeranno il suo L’Allégorie du patrimoine, uno dei testi più celebri e fortunati tra quelli della sua maturità, tradotto in numerose lingue. Questo percorso di avvicinamento all’opera di Giovannoni culminerà nel 1998, quando la Choay promuoverà e curerà la parziale traduzione del Vecchie città ed edilizia nuova del 1931, pubblicata in Francia con il titolo L’urbanisme face aux villes anciennes. Nel corso di questo ventennio, compreso tra la conclusione del lavoro su Alberti e la traduzione appena citata, la presenza della studiosa in veste di visiting professor presso diversi atenei italiani si farà sempre più intensa.
Per comprendere meglio il significato della “scoperta” del contributo di Giovannoni da parte della Choay al principio degli anni Ottanta occorre relazionarla alla contemporanea cultura architettonica e urbanistica francese. Questa vede, già a partire dagli anni Settanta – e in una certa misura anche prima – una consistente irruzione della bibliografia italiana nell’ambito degli studi urbani, attraverso traduzioni non sempre fedeli, che conducono, come ha scritto Jean-Louis Cohen, a un vero e proprio processo di “italianizzazione” della cultura francese[47]. In questo contesto è interessante osservare innanzitutto la posizione che la Choay assume nei confronti della dilagante fortuna degli studi tipo-morfologici di derivazione italiana. L’occasione per discuterne giunge all’incirca alla metà del decennio, quando l’opera di Aldo Rossi approda in Francia attraverso l’esposizione Aldo Rossi. Théatre, Ville, Architecture, tenuta nel 1985 a Nantes e introdotta da un simposio al quale partecipano, tra gli altri, anche Bernard Huet e Hubert Damisch[48]. Nello stesso anno la Choay partecipa, con Pierre Merlin ed Ernesto d’Alfonso, all’organizzazione di un seminario dal titolo Morphologie urbaine et parcellaire, dedicato all’approfondimento dell’analisi urbana tipo-morfologica e della sua attuale eredità, nell’ambito di una ricerca sul medesimo tema avviata dagli stessi Choay e Merlin presso l’Institut français d’urbanisme, i cui esiti saranno in seguito tacciati di “italofobia” da Cohen (2015: 13).
Dopo una serie di relazioni che ne approfondiscono lo sviluppo e gli esiti[49], tocca proprio alla studiosa francese trarre le conclusioni del citato incontro di studi. La sua posizione sulla validità degli studi tipo-morfologici è fortemente dubitativa: essi testimoniano infatti una generale debolezza di impianto metodologico e appaiono spesso privi di fondamento storico[50]. Denunciando l’interpretazione superficiale delle origini del termine “tipo” – ricondotta agli studi di Giulio Carlo Argan e alla sua rilettura del contributo di Quatremère de Quincy – la studiosa francese sottolinea come l’Italia abbia esercitato una vera e propria “egemonia verbale (talvolta terroristica)”[51] (Choay, 1988a: 147) in questo campo. Ci appare evidente, per esempio, nell’estensione del termine “progetto” a lingue diverse dall’italiano, nelle quali esso assume un significato tutt’affatto differente (Choay, 1988a: 147-148). È necessario invece, scrive la Choay, rapportarsi correttamente alla terminologia e migliorare la qualità delle traduzioni dall’italiano, “che veicolano un vero e proprio sproloquio”[52] (Choay, 1988a: 148).
Con queste premesse la studiosa francese entra nel vivo dell’analisi morfologica applicata alla città, smascherandone le molte aporie, tra le quali la principale consiste proprio nello scopo stesso dell’analisi: quello di fornire un semplice “strumento operativo” per gli architetti (Choay, 1988a: 150), privo del rigore necessario a qualunque indagine storica (Choay, 1988a: 151-153). La città, in questo approccio, è presentata come un oggetto autoreferenziale, che è possibile indagare senza alcun riguardo per i fattori economici, giuridici, sociali che l’hanno prodotta e trasformata. A fronte di un interesse crescente per lo spazio urbano, manifestato dagli storici della città negli anni 1960-1970, tra i quali André Chastel[53], l’analisi morfologica propugnata dagli studiosi italiani di morfologia urbana appare alla Choay frettolosa e superficiale, fondata spesso su fonti di seconda mano e fortemente ideologica (Choay, 1988a: 152). In questo filone ella colloca alcune opere di Carlo Aymonino, Leonardo Benevolo e persino del gruppo degli allievi di Manfredo Tafuri, tutte pubblicate agli inizi degli anni Settanta[54].
Ma è evidente che il volume più ambiguo e fuorviante, in questa requisitoria, è proprio L’architettura della città di Aldo Rossi, che manifesta per la Choay “un florilegio di assurdità”[55] (Choay, 1988a: 156). Fiumi di inchiostro sono stati versati fino ad oggi su questo volume, ma ci sembra molto valido il giudizio sintetico che ne ha recentemente dato Alberto Ferlenga, riconducendolo prevalentemente a un avvio di ricerca, in parte autobiografica, finito in un successo forse imprevisto dal suo stesso autore (Ferlenga, 2014: 16). È noto, del resto, che le ambizioni e i limiti de L’architettura della città erano state ben individuate dallo stesso Rossi, quando vi si soffermava, alcuni anni dopo, nella sua Autobiografia scientifica, pubblicata nel 1981 negli Stati Uniti e solo nel 1990 in Italia (Rossi, 1981; 1990). Qui Rossi sottolineava come il suo lavoro mirasse più alla scoperta della “propria” architettura che delle radici del fenomeno urbano, finendo addirittura per rivelare il suo intento più profondo, ovvero quello di disfarsi della città (Rossi, 1990: 21-22). Non stupisce, dunque, che la stessa Choay concluda le sue pungenti osservazioni con la citata pagina dell’Autobiografia nella quale Rossi aveva compiuto il suo redde rationem, riconoscendo nelle sue parole la prova evidente del manifestarsi di una parabola discendente degli studi di morfologia urbana già alla metà degli anni Ottanta[56].
È questo, dunque, il contesto nel quale si colloca l’inattesa “scoperta” del contributo di Giovannoni da parte della Choay agli inizi degli anni Ottanta. Allo scetticismo manifestato nei confronti dell’eredità degli studi tipo-morfologici, la studiosa oppone il suo entusiasmo per il pensiero di un urbanista sui generis come Giovannoni, all’epoca ancora molto trascurato in ambito italiano a causa di pregiudizi ideologici e oggetto di una prima timida rivalutazione soltanto negli ambiti della storia dell’architettura e del restauro (Curuni, 1979; Del Bufalo, 1982). È del resto proprio da quest’ultimo fronte disciplinare che la studiosa trae lo spunto per la conoscenza dell’opera giovannoniana, dichiarando il proprio debito di riconoscenza verso un “classico” tra i testi disciplinari del restauro, scritto peraltro da un allievo diretto dell’ingegnere romano, ovvero il volume Teoria e storia del restauro di Carlo Ceschi (1970)[57].
La lettura di Giovannoni svolta dalla Choay si focalizza immediatamente sui tratti più innovativi della sua opera, ovvero la dimensione territoriale, la multiscalarità e la precoce anticipazione di una vera e propria era post-urbana. Così, già nel 1991, scrivendo della Urbanistica disorientata in un volume collettaneo apparso in Italia a cura di Jean Gottmann e Calogero Muscarà, la studiosa sottolinea il contributo anticipatore di Giovannoni, individuato come un antesignano dell’era post-urbana, teorizzata in anni più recenti da Melvin Webber[58]. Lo studioso romano è ricordato anche per il suo apporto al problema della conservazione del patrimonio urbano, in cui la Choay evidenzia l’importanza del
concetto di scala: alla dimensione territoriale delle reti dovevano affiancarsi altre scale d’intervento, in particolare nei luoghi destinati all’addensamento abitativo […]. Il tessuto dei centri storici offriva a un tempo la scala commisurata a tale uso ed esempi di come dimensionare modi di accorpamento diffusi, non urbani, da inventare (Choay, 1991: 159).
È tuttavia con il già citato L’Allégorie du patrimoine, pubblicato in prima edizione francese nel 1992[59], che la figura di Giovannoni assume un ruolo di primo piano nella costruzione di una “storia” del patrimonio architettonico e urbano in Europa, destinata, come prima si diceva, a notevole successo internazionale. Rileva tuttavia sottolineare che le origini di questo volume non sono tanto da ricercare in una curiosità storica da parte della Choay, quanto piuttosto in una preoccupazione sociale: come precisato in seguito dalla studiosa, la stesura del testo nasce dalla constatazione di un “malessere profondo” della società, testimoniato dal culto per il patrimonio[60].
Nell’economia di una trattazione generale della vicenda dalle origini all’attualità, la Choay dedica un notevole spazio allo studioso romano, assegnandogli un fondamentale ruolo di sintesi nella definizione del concetto di “patrimonio urbano”[61]. Fin dalle prime righe, la studiosa francese rileva il sorprendente oblio che ha caratterizzato l’opera di Giovannoni nel dopoguerra, “a lungo occultata a causa di passioni politiche ed ideologiche” (Choay, 1995a: 130), dovute sia ai coinvolgimenti con il regime che alle sue posizioni nei confronti dell’architettura moderna, che costituiscono oggi motivo ulteriore per “restituirgli il suo posto sullo scacchiere della storia” (Choay, 1995a: 130)[62]. Lo studioso è quindi collocato dalla Choay al termine di un percorso avviato con John Ruskin e proseguito attraverso le diverse elaborazioni di Camillo Sitte e Charles Buls, nel quale Giovannoni assume il ruolo di figura “storicizzante” (historiale)[63] nei confronti del patrimonio urbano, aprendo prospettive ancora attuali per l’analisi e l’intervento nella vecchia città (Choay, 1995a: 129). In particolare, la studiosa francese riconosce a Giovannoni il merito di aver individuato la strada per una possibile integrazione tra valori d’arte e valore d’uso dei tessuti antichi, attraverso una visione compiutamente urbanistica dei problemi che non disdegna l’impiego dei migliori prodotti della civiltà industriale (come le moderne reti di trasporto, che Giovannoni considera fondamentali per la definizione di nuove relazioni tra vecchia e nuova città)[64]. In questa direzione quindi, lo studioso romano – grazie anche alla sua “tripla formazione” di architetto, ingegnere e restauratore[65] – “supera l’urbanistica tradizionale unidimensionale nella quale Le Corbusier si è rinchiuso senza aver compreso che la sua ‘ville radieuse’ è una non-città” (Choay, 1995a: 131), definendo al contrario “una dottrina sofisticata della conservazione del patrimonio urbano” (Choay, 1995a: 132).
Tale dottrina è riassunta dalla Choay in tre principi:
innanzitutto ogni frammento urbano antico deve essere integrato in un piano urbanistico (piano regolatore) locale, regionale e territoriale che rappresenti con precisione la sua relazione con la vita presente […] in secondo luogo, il concetto di monumento storico non potrebbe designare un edificio singolo indipendentemente dal contesto […] infine, una volta soddisfatte queste due prime condizioni, gli ambienti urbani antichi reclamano dei procedimenti di manutenzione e restauro analoghi a quelli definiti da Boito per i monumenti (Choay, 1995a: 133)
Si arriva così al diradamento, termine che la Choay considera particolarmente felice, traducendolo con éclaircissage[66], nel quale divengono “lecite, raccomandabili o persino necessarie, la ricostituzione, a condizione di non essere falsa, e soprattutto alcune distruzioni” (Choay, 1995a: 133). Segue quindi qualche considerazione sugli esiti operativi delle teorie di Giovannoni, in cui la studiosa francese rileva innanzitutto i frequenti scontri “con una resistenza dovuta tanto al loro carattere anticipatore, quanto al modo con cui esse ostacolavano l’ideologia di un regime avido di grandi lavori spettacolari”, per poi osservare che – a fronte dei coinvolgimenti col fascismo – “occorre portare all’attivo di Giovannoni la sua opera negativa d’oppositore, il bilancio di tutte le distruzioni che è riuscito ad impedire in tutt’Italia” (Choay, 1995a: 134). Per la Choay, in definitiva, “praticamente unico tra i teorici dell’urbanistica del XX secolo”, Giovannoni ha il merito di aver “piazzato al centro delle sue preoccupazioni la dimensione estetica dell’insediamento umano” (Choay, 1995a: 134), anticipando, “con maggior garbo e complessità, le diverse politiche dei ‘secteurs sauvegardés’ messe a punto ed applicate in Europa dal 1960”, benché la sua teoria ne contenga “altresì in germe i paradossi e le difficoltà” (Choay, 1995a: 135).
Osservazioni, queste, che appaiono tutte pienamente condivisibili, al di là di alcune inesattezze dovute ad errori già presenti nella bibliografia italiana o di qualche esagerazione sui meriti dello studioso nelle quali si trascura l’apporto determinante di tante altre figure di comprimari. Ma l’approccio della Choay è dichiaratamente libero da preoccupazioni filologiche: già nella sua premessa, ella chiarisce che obiettivo del libro è la ricerca “di origini, ma non di una storia” del culto del patrimonio, per la quale si utilizzeranno “figure e punti di riferimento concreti, ma senza la preoccupazione di fare inventari” (Choay, 1995a: 13). Con questo taglio, in sostanza, la studiosa sceglie di evidenziare soltanto alcune personalità di rilievo, selezionate tra quelle che più di altre hanno segnato alcune tappe evolutive nel cammino della tutela.
Questi ultimi, infatti, non si fanno attendere: già nello stesso 1992 la parte più significativa de L’Allégorie – ovvero il capitolo “L’invention du patrimoine urbain”, nel quale è appunto trattata la figura di Giovannoni – riceve una prima traduzione italiana, quale saggio autonomo nell’antologia di scritti L’orizzonte del posturbano, curata da Ernesto d’Alfonso e pubblicata da Officina (Choay, 1992a)[67]. Nel suo insieme, quest’ultimo volume pu considerarsi un altro importante tassello del processo di diffusione dell’opera della Choay in Italia. Vi sono contenuti saggi, editi e inediti, sulla città e il monumento (Choay, 1987; 1992c), su Haussmann (Choay, 1992b)[68], su Riegl e Freud (Choay, 1989; 1992e)[69], sul patrimonio storico e le rivoluzioni (Choay, 1992d)[70], che veicolano efficacemente il multiforme contributo della studiosa, ma soprattutto il suo monito, sottolineato da d’Alfonso nella postfazione, contro la perdita di competenza di costruire delle culture occidentali[71]. Del resto, il successo del volume citato è ancora oggi dimostrato dal fatto che risulta da molti anni esaurito[72].
Di lì a poco, il riflesso degli studi della Choay su Giovannoni produce in Italia un ulteriore esito molto significativo: la ristampa anastatica di Vecchie città ed edilizia nuova del 1931, curata da Francesco Ventura nel 1995 con la prefazione della stessa Choay (Giovannoni, 1995). Nella sua breve prefazione, la Choay paragona il lungo occultamento del volume all’analogo destino subito dal più noto libro di Ildelfonso Cerdà, Teoría general de la urbanización, pubblicato in Spagna nel 1867 e “rimasto all’inferno per più d’un secolo”[73] (Cerdà, 1867; 1995). A differenza di quest’ultimo tuttavia, i decenni di silenzio che avvolgono il volume di Giovannoni appaiono alla studiosa francese “di gran lunga più duri”: la sua opera, infatti, non solo è stata “tenuta nascosta per ragioni politiche e quindi condannata a essere ignorata fuori d’Italia”, ma persino “falsificata e diffamata” (Choay, 1995b: VII). È per questi motivi, quindi, che la Choay non esita ad accogliere “la riedizione di Vecchie città come un’opera di ‘salute pubblica’” (Choay, 1995b: VII). Due sono gli “essenziali avvertimenti” che la Choay intravede nell’opera dello studioso: “il riconoscimento sereno, senza passatismo nostalgico né trionfalismo tecnicista, dell’influenza della tecnica sul nostro ambiente”, e “l’esistenza, direi anzi la presenza, dei tessuti urbani tradizionali”, per i quali “il libro di Giovannoni prende partito, ante litteram, contro l’industria culturale, la storicizzazione oltranzista […] e la falsa memoria di cui li si carica” (Choay, 1995b: VIII).
All’entusiasmo manifestato dalla Choay per la ristampa del volume risponde tuttavia anche qualche voce dissenziente, come quella di Alberto Maria Racheli, che in una sua articolata recensione contesta i giudizi sul presunto occultamento dell’opera di Giovannoni. Per Racheli, infatti, l’inattesa scoperta di Vecchie città da parte della studiosa francese “appare fin troppo candida, in quanto, fra coloro che invece si interessano di restauro, la lettura diretta del libro di Giovannoni di cui si tratta ha rappresentato in Italia una ininterrotta applicazione di studio, dal momento in cui è stato edito fino ai nostri giorni” (Racheli, 1996: 99). In sostanza, “è indubbio che l’oblio circa la conoscenza di questo libro, a partire dalla caduta del fascismo, a cui accenna la Choay, rappresenti un fenomeno marcatamente extraitaliano” (Racheli, 1996: 99).
Al di là di questa significativa eccezione, tuttavia, il 1995 segna un anno molto rilevante per il rapporto tra la studiosa e il contesto culturale della penisola, non soltanto per la ristampa del volume di Giovannoni, ma soprattutto per la contemporanea edizione italiana del suo L’Allégorie du patrimoine, che giunge ancora una volta nel nostro paese per i tipi di Officina e la cura di Ernesto d’Alfonso, al quale si affianca Ilaria Valente (Choay, 1995a). A fronte di una traduzione davvero poco felice[74], il volume conosce infatti notevole successo in Italia, ottenendo crescenti citazioni da studiosi anche non strettamente legati all’ambito disciplinare del patrimonio.
Pochi anni più tardi, come già si accennava, il percorso di approfondimento dell’opera di Giovannoni da parte della Choay raggiunge il suo compimento con la pubblicazione della traduzione francese di Vecchie città, annunciata dalla stessa studiosa fin dalla prefazione alla ristampa italiana del volume prima citata. Il lavoro prende le mosse da una tesi di dottorato, svolta da Claire Tandille nel 1994, sotto la direzione della stessa Choay. Come precisato nell’introduzione, tuttavia, il testo finale è frutto di un’attenta rielaborazione della ricerca di quest’ultima, finalizzata a selezionare le parti più significative del volume di Giovannoni, allo scopo di realizzare un’edizione tascabile da rivolgere ad un pubblico formato non soltanto da specialisti[75]. Mancano pertanto – oltre ad alcuni brani giudicati eccessivamente ripetitivi e ridondanti – tutte le parti più direttamente legate al contesto italiano, come i commenti alla legislazione vigente e le relative proposte avanzate dallo studioso, i numerosi esempi di città italiane e gran parte delle immagini. In compenso, il saggio introduttivo della Choay costituisce una testimonianza di notevole interesse, nella quale la studiosa, oltre a sviluppare ed approfondire alcune considerazioni già anticipate qualche anno prima in L’Allégorie du patrimoine, rivolge un attento commento al volume del 1931, soffermandosi anche sulla biografia di Giovannoni e sulla sua sfortunata vicenda critica, fino ad accennare al recente risveglio di interessi attorno alla sua figura.
Dopo una breve premessa, che ripercorre in parte le considerazioni già svolte dalla Choay nella prefazione alla ristampa italiana di Vecchie città del 1995, la studiosa articola l’interessante saggio introduttivo in cinque capitoli. Nel primo di questi la Choay analizza i contenuti essenziali del volume di Giovannoni, suggerendo alcune chiavi interpretative per comprenderne il testo. Per la studiosa, tutta la trattazione di Vecchie città è fondata su un rapporto dialettico tra due mondi apparentemente opposti, che Giovannoni cerca di conciliare conservandone le rispettive differenze; il suo lavoro potrebbe quindi essere definito “come un esercizio di messa in compatibilità e complementarità di esigenze contraddittorie”[76] (Choay, 1998a: 9). Questo rapporto dialettico è inoltre articolato su un aspetto fondamentale, che la Choay colloca tra gli elementi caratterizzanti del volume, ovvero la “nozione della scala”, attraverso la quale Giovannoni legge tanto i vecchi tessuti che gli organismi urbani moderni, analizzando questi ultimi per la prima volta “in termini di reti infrastrutturali: tiene già conto delle reti di telecomunicazioni, ma anche di tutte le reti di trasporto”[77] (Choay, 1998a: 10). Così, la soluzione dell’inconciliabilità tra i due opposti universi “si riassume per Giovannoni nella combinazione di due termini (sdoppiamento + innesto), che si potrebbero sviluppare in una formula: separare unendo. In altre parole separare le due formazioni riservando a ciascuna il suo specifico carattere, ma nello stesso tempo farle comunicare, raccordarle”[78] (Choay, 1998a: 10-11). Per la Choay, in sostanza, “la piena cognizione della modernità tecnologica colloca Giovannoni all’opposto dei nostalgici della città antica come Ruskin”, ma, al contempo, lo distingue anche dall’approccio dei CIAM: “a buon diritto”, lo studioso “taccia Le Corbusier di arretrato semplicismo: nella sua concezione della vita futura, quest’ultimo non tiene conto che della rete stradale e di una scala di pianificazione unica che esclude ogni rapporto col contesto”[79] (Choay, 1998a: 12). Al contrario, la riflessione dello studioso sulle reti di trasporto e comunicazione, gli apre “l’orizzonte della deurbanizzazione”[80].
È comunque nella nozione di “patrimonio urbano”, “espressione da lui stesso coniata”, che la studiosa francese ritrova il contributo più interessante di Giovannoni. Considerando “la città o il quartiere storico come un’opera d’arte autonoma, un monumento storico in sé” – caratterizzato non solo dalle opere maggiori, ma anche “da un tessuto articolato di edifici minori (di cui Giovannoni sottolinea vivamente l’interesse storico, spesso superiore a quello degli edifici maggiori)”[81] – lo studioso arriva infatti ad una visione complessa della salvaguardia, che “non riguarderà tanto gli edifici singoli quanto i rapporti ambientali che generano l’opera d’arte urbana” (Choay, 1998a: 13)[82]. Tuttavia – ed è questo il punto che la Choay tiene particolarmente ad evidenziare – il suo approccio alla conservazione del patrimonio non si ferma ai valori estetici e storici, ma contempla anche “un valore d’uso sociale, in accordo con le condizioni di vita della nostra epoca”, che bandisce “una protezione paralizzante, di tipo archeologico e museale”[83] (Choay, 1998a: 13) per i tessuti antichi. Ecco quindi che “Giovannoni propone un approccio dinamico, più libero e interventista, che permette di adattare i tessuti antichi alla vita contemporanea, pur rispettando il loro stile e il loro ambiente”[84] (Choay, 1998a: 14). Si arriva così alla “metafora botanica” del diradamento, opportunamente tradotto dalla Choay con il termine éclaircissage[85], che tuttavia non rappresenta un insieme di regole assolute, la cui definizione è possibile soltanto “caso per caso, secondo le condizioni storiche, geografiche, topografiche, morfologiche, economiche […] specifiche di ogni circostanza”[86] (Choay, 1998a: 14).
Nel secondo capitolo, la studiosa affronta brevemente la biografia dello studioso, soffermandosi in particolare sulla sua formazione giovanile, in cui rintraccia quell’approccio “integrale”, che più tardi Giovannoni stesso indicherà come il fondamento della nuova figura dell’architetto. Particolarmente interessante, in questo contesto, è un paragrafo specificamente dedicato ai riferimenti europei dello studioso, in cui la Choay sottolinea l’ampia cultura di Giovannoni, fondata su “una pratica delle lingue straniere che gli consente di accedere direttamente alla lettura dei testi inglesi, tedeschi e francesi: il suo pensiero si arricchisce così della diversità di queste tradizioni europee, di cui saprà assimilare le divergenze”[87] (Choay, 1998a: 18). Oltre ai più noti riferimenti di area germanica ed anglosassone, la studiosa si sofferma quindi sull’ambiente francese, citando la sua conoscenza delle opere di storici e geografi come Poëte, Müntz, Vidal de la Blache, ed evidenziando, in particolare, la palese influenza esercitata dalle due diverse figure di Auguste Choisy e Pierre Lavedan. Per la Choay, l’insieme di questi riferimenti, “tramite i libri e gli insegnamenti di Giovannoni […] faranno d’ora in poi parte della cultura architettonica italiana, come testimoniano, per esempio, gli studi tipo-morfologici di Carlo Aymonino e le opere di Aldo Rossi” (Choay, 1998a: 19)[88].
Ai rapporti tra Giovannoni e il contesto italiano è rivolto il terzo capitolo dell’introduzione, in cui la biografia dello studioso è distinta in tre periodi fondamentali, legati alle vicende politiche del nostro paese[89]. Qui la Choay si avvale, ben più che nella lettura svolta nel 1992 in L’Allégorie du patrimoine, di un’aggiornata bibliografia italiana sull’opera dello studioso, che proprio nel corso degli anni Novanta stava progressivamente arricchendosi. Ai vecchi testi di Ceschi e Del Bufalo si aggiungono quindi, tra le letture della Choay, quelli di Vanna Fraticelli, Giorgio Ciucci, Paolo Marconi, Attilio Belli e Guido Zucconi[90]. È in particolare al volume di Belli Immagini e concetti nel piano – pubblicato nel 1996 e rivolto all’approfondimento della cultura urbanistica italiana dei primi decenni del Novecento alla luce dell’attuale riflessione disciplinare – che la studiosa attribuisce il merito di aver evidenziato il ruolo-guida di Giovannoni nell’istituzione di uno statuto teorico dell’urbanistica in Italia e nella creazione di “un campo disciplinare”, soprattutto a confronto con le ambiguità di Piacentini e Piccinato (Choay, 1998a: 21, n. 17)[91]. Su questa falsariga, la Choay precisa quindi che Giovannoni “non è un isolato”: molte sono le personalità “che hanno contribuito all’elaborazione dei principi o dei concetti giovannoniani, e che a volte ne hanno potuto dare delle formulazioni più felici delle sue in articoli di riviste o nell’Enciclopedia Italiana […]. Nessuno di loro, tuttavia, ne possiede la sua capacità di sintesi né la sua statura di teorico». Giovannoni pu pertanto «essere considerato come il creatore di questa disciplina in Italia e della sua specificità italiana”[92] (Choay, 1998a: 21).
Molto interessante è poi il paragrafo espressamente dedicato ai rapporti tra Giovannoni e il fascismo, in cui la Choay – partendo dai frequenti ossequi rivolti dallo studioso a Mussolini nel testo di Vecchie città – chiarisce alcuni aspetti del suo coinvolgimento politico. Per la studiosa, Giovannoni non è neanche lontanamente paragonabile a una figura come quella di Albert Speer: a riguardo basterebbe infatti osservare che nel primo “l’espressione delle speranze portate dal fascismo è associata alla critica spietata e permanente di un’amministrazione che, nei fatti, è quella del regime mussoliniano”[93] (Choay, 1998a: 24). Il suo nazionalismo – fondato sulla speranza “che l’Italia possa colmare il suo ritardo e ricollocarsi al primo posto tra le nazioni europee” (Choay, 1998a: 24) – potrebbe forse accostarsi a quello di un d’Annunzio; tuttavia, per la Choay, Giovannoni appare decisamente più un tecnico che una figura politica. Pertanto, “la presa del potere da parte di Mussolini rappresenta per lui una possibilità di far comprendere e di realizzare la sua visione dello sviluppo urbano; niente di più”[94] (Choay, 1998a: 25). “Già alla fine degli anni Venti”, infatti, “appare chiaro che Giovannoni non fa parte dei tecnici al servizio del regime, come Alberto Calza Bini, Marcello Piacentini o Luigi Piccinato. Non è implicato in nessuna delle istituzioni create e gestite da Calza Bini […] né parteciperà ad alcuna delle imprese di glorificazione monumentale del regime”[95] (Choay, 1998a: 25).
Il quarto capitolo affronta, infine, l’interessante argomento della sfortuna critica dello studioso, accennando anche al recente risveglio di interessi sulla sua opera. Per la Choay, il silenzio che avvolge di colpo la figura di Giovannoni subito dopo il 1947, appare al contempo “paradossale e sorprendente”:
paradossale se si immagina che nell’Italia del secondo dopoguerra l’insegnamento dell’architettura, la legislazione urbanistica, il dibattito sul restauro portano l’impronta del suo pensiero [...], sorprendente, se si immagina che in materia di architettura e di urbanistica, che si tratti di storiografia, di teoria o di pratica, quasi tutti i protagonisti della scena italiana sono direttamente o indirettamente usciti dalla sua scuola[96] (Choay, 1998a: 26).
Le ragioni di questa esclusione sono per la studiosa tutte di natura ideologica: “l’Italia del secondo dopoguerra cerca di cancellare tutto quello che, in qualche modo, è legato al fascismo. I nuovi valori sono rappresentati dall’America e dal marxismo. In materia d’architettura e di urbanistica, il Movimento moderno diventa sinonimo di democrazia”[97] (Choay, 1998a: 27). Giovannoni, per contro, “non ha mai aderito alle avanguardie ufficiali […] la sua cultura internazionale non ha mai scalfito il suo nazionalismo e i suoi rapporti con la filosofia passano per Hegel attraverso l’estetica di Croce, ma ignorano Marx, a dispetto di un interesse mai smentito per l’economia”[98] (Choay, 1998a: 27). In altre parole, lo studioso non dispone “di nessuno degli alibi di cui potevano valersi Piacentini o Piccinato, per esempio”[99] (Choay, 1998a: 27), e finisce per essere presto dimenticato. È solo agli anni Ottanta, infatti, che la Choay fa risalire un primo squarcio in questo “pesante silenzio ideologico”, riconducibile da un lato “al tempo, che aveva smorzato il disagio e i complessi degli intellettuali italiani”[100] (Choay, 1998a: 27), e dall’altro al disincanto che ormai attraversava tanto i dogmi dell’ortodossia marxista che le certezze del Movimento moderno. Se tuttavia oggi si assiste ad un tangibile risveglio di interessi sulla sua figura, per la studiosa “il grande libro di sintesi su Giovannoni resta ancora da scrivere”: escludendo infatti “i contributi apparsi nel settore del restauro, tutti i lavori pubblicati fino ad oggi in italiano sono stati, ciascuno a suo modo, assai riduttivi”[101] (Choay, 1998a: 27-28).
Pur condividendo i rischi di “beatificazione sommaria” del personaggio, già paventati da Guido Zucconi nel 1997 (Choay, 1998a: 28)[102], la Choay conferma in definitiva la grande attualità del lavoro di Giovannoni, focalizzato “su un problema che è oggi al centro dei nostri interrogativi sulla città: quello dei rapporti tra una tradizione urbana millenaria e le mutazioni del nostro ambiente, dei nostri comportamenti e delle nostre mentalità, generate dallo sviluppo accelerato di un insieme di nuove tecnologie”[103] (Choay, 1998a: 28-29). In questo senso, per la studiosa, l’approdo dell’opera di Giovannoni in Francia appare particolarmente appropriato: “Vecchie città si rivolge in particolare, a noi, Francesi, che non abbiamo, nel lungo periodo, beneficiato di una cultura urbana paragonabile a quella di alcuni dei nostri vicini, che si tratti in particolare dell’Italia o degli antichi territori anseatici”[104] (Choay, 1998a: 29).
In questa conclusione si intravede chiaramente l’effetto della cross-fertilization di cui prima si diceva. A confronto con le perplessità manifestate dalla Choay nei confronti della cultura architettonica italiana ancora negli anni Ottanta – come si evidenziava all’inizio del paragrafo in rapporto agli studi tipo-morfologici – la studiosa riconosce ormai pienamente il valore della cultura urbana del nostro paese, ancorché concentrandosi forse in modo un po’ troppo esclusivo sulla figura simbolo di Giovannoni.
Quest’ultimo aspetto si rivela anche scorrendo una delle altre importanti opere portate avanti dalla Choay a partire dalla metà degli anni Ottanta, ovvero il Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, curato con Pierre Merlin nel 1988 e giunto nel 2015 alla settima edizione completamente riveduta. Sorto da un interesse specifico per la linguistica e la terminologia – che la studiosa ha progressivamente coltivato negli anni della sua maturità – il Dictionnaire va visto in stretta continuità con il lavoro iniziato con L’urbanisme. Utopie et réalités nel 1965. Alla Choay è assegnato il compito di redigere le voci di ordine storico e teorico – tra le quali figurano due lemmi fondamentali come Architecture e Urbanisme – mentre a Merlin e ad altri collaboratori quelle di ambito più tecnico. Ebbene anche in questo lavoro la presenza dell’Italia emerge in modo evidente, incarnata dalla figura di Giovannoni, insieme a quella del meno celebre soprintendente milanese Giorgio Nicodemi (1891-1967), che la Choay ha avuto occasione di conoscere studiando dettagliatamente gli atti della Conférence internationale sur la conservation artistique et historique des monuments, organizzata dall’Office international des musées ad Atene nell’ottobre 1931[105].
A Giovannoni, infatti, la studiosa attribuisce tanto l’invenzione del concetto di patrimonio urbano (cf. voce Patrimoine) (Choay, 2015b), quanto l’anticipazione di quello di “posturbano”, termine coniato dalla stessa Choay a partire da quello di post-city age di Melvin Webber (cf. voce Posturbain) (Choay, 2015c). A Nicodemi, invece – il cui contributo andrebbe tuttavia ridimensionato come semplice interprete di posizioni condivise da una moltitudine di studiosi italiani dell’epoca, che vede proprio Giovannoni tra i protagonisti – ella riconosce il merito di aver ampliato l’ambito della tutela al contesto dei monumenti e all’ambiente, grazie alla sua relazione presentata ad Atene nel 1931. Così la figura di Nicodemi, e di riflesso il contributo italiano, assumono una parte rilevante nello sviluppo di diverse voci del Dictionnaire, a partire da Abords (letteralmente “dintorni”, ma traducibile proprio come contesto del monumento), concetto già presente in forma embrionale nella prima legge di tutela francese del 31 dicembre 1913 e poi ampliato con la legge del 25 febbraio 1943 (Choay et Preschez, 2015)[106]. Lo stesso pu dirsi per le voci Conservation intégrée e Ensemble historique ou traditionnel, nell’ultima delle quali la studiosa sottolinea il carattere precursore delle leggi italiane di tutela del 1939 (Choay, 2015a).
Il patrimonio e la sua dimensione globalizzata agli albori del terzo millennio
Come si è visto nei paragrafi precedenti, già a partire dalla fine degli anni Novanta i riferimenti italiani della Choay si ampliano e si moltiplicano, tanto sul piano dei rapporti con studiosi di diverse generazioni, quanto su quello della sua presenza come relatrice o docente in numerosi atenei della penisola. Al contatto con Ernesto d’Alfonso, primo curatore e traduttore delle opere della Choay in Italia fin dagli anni Ottanta, si aggiungono ora quelli con Francesco Paolo Di Teodoro e Mario Carpo per i suoi interessi sul Rinascimento, con Attilio Belli, Paola Di Biagi, Bruno Gabrielli, Alberto Magnaghi, Claudia Mattogno, Francesco Ventura per l’urbanistica e, infine, con Marco Dezzi Bardeschi e il sottoscritto per il campo del restauro, per citarne solo i principali[107].
Sarebbe impossibile ricostruire gli innumerevoli inviti che la studiosa ha ricevuto dalle università italiane – culminati nella laurea honoris causa, citata in apertura di questo scritto, presso l’Università di Genova nel 2001[108] – ma tra questi va sicuramente richiamata, in primis, la sua pluridecennale consuetudine con il Politecnico di Milano, già citata in precedenza. E sarà proprio in ambito milanese che si svilupperà, a partire dai primi anni Novanta, il rapporto con Dezzi Bardeschi, avviato in contemporanea con la nascita di Ananke (rivista fondata e diretta da quest’ultimo dal 1993 fino alla sua recente scomparsa nel novembre 2018), come testimonia una lusinghiera lettera della Choay pubblicata sul numero 6 di giugno 1994 (Choay, 1994b)[109]. Nell’arco di venticinque anni, la rivista ospiterà tanto articoli della Choay (1998c; 2013), quanto puntuali segnalazioni sugli scritti della studiosa apparsi in Francia, attraverso editoriali o recensioni quasi sempre firmati dallo stesso Dezzi Bardeschi, a partire da un lungo e positivo commento sull’antologia Pour une anthropologie de l’espace, pubblicata nel 2006 e insignita del Prix du livre d’Architecture nel 2007, che gli farà osservare: “Per Françoise mi pare che quella che si apre è la felice stagione matura della sintesi, come se tutti gli avvincenti nodi problematici che ha affrontato con tanta ragione e passione ora stiano trovando, sotto le sue abili mani leggere e attraverso la sua limpida penna la loro composizione unitaria” (Dezzi Bardeschi, 2006: 2)[110].
Negli stessi anni Novanta, intanto, la sua presenza in Italia come docente invitato a tenere corsi, seminari e convegni non si limiterà al solo Politecnico di Milano, spaziando dall’Università di Roma La Sapienza all’IUAV di Venezia, per lasciare quasi sempre tracce del suo passaggio in significative pubblicazioni[111]. Tra queste spicca un saggio dedicato a un argomento imbarazzante e “scomodo” da trattare come la demolizione, al quale la Choay dedica un saggio particolarmente interessante, dove – richiamando la celebre metafora di Sigmund Freud su Roma, contenuta in apertura del suo Il disagio nella civiltà (1929) – sottolinea la sua opposizione contro ogni conservazione feticista, museale e incapace di reinserire il patrimonio nel circuito vitale del presente e del futuro, ma anche contro ogni pratica di “demolizione mascherata” che il restauro fondato sul solo obiettivo della valorizzazione comporta (Choay, 2008f: 92).
Al principio del XXI secolo gli interessi di ricerca della Choay percorreranno due filoni principali, in parte intrecciati fra loro, entrambi segnati da multiformi addentellati nella cultura del nostro paese: da un lato essi approfondiranno i temi del patrimonio, attraverso letture antologiche e traduzioni di diversi testi dei “padri fondatori” della tutela e della conservazione; dall’altro toccheranno i temi della globalizzazione in rapporto alla scala locale degli insediamenti umani.
Nel primo ambito si colloca la traduzione francese di alcuni scritti di Camillo Boito, curata dalla Choay con Jean-Marc Mandosio e sfociata in un volumetto dal titolo Conserver ou restaurer apparso nel 2000. Prendendo a prestito il titolo di un celebre dialogo di Boito, il libro in questione rappresenta la prima testimonianza della diffusione dell’opera dell’architetto e teorico italiano in Francia. Dopo una breve introduzione della Choay, nella quale sono citati come riferimenti i testi di Maria Antonietta Crippa, Alberto Grimoldi, Paolo Marconi e Guido Zucconi, oltre all’immancabile Carlo Ceschi – già utilizzato dalla Choay come fonte primaria per la conoscenza di Giovannoni – vengono proposte le traduzioni de “I restauri in architettura” e “La basilica d’oro”, entrambi nelle versioni pubblicate da Boito in Questioni pratiche di belle arti nel 1893 e a loro volta riediti nell’antologia curata da Maria Antonietta Crippa nel 1989. A questi si aggiungono due “variazioni” che la Choay ritiene particolarmente significative per evidenziare i rapporti tra Francia e Italia attraverso Boito: una lettera di Prosper Mérimée sui restauri della cattedrale di Strasburgo del 1836, utile per testimoniare l’impegno di quest’ultimo nei confronti del patrimonio medioevale francese, più volte lodato da Boito, e un articolo di Viollet-le-Duc del 1872 dedicato al restauro degli edifici in Italia, nel quale il grande restauratore francese indica come un modello la cura che gli italiani manifestano verso i loro monumenti (Mérimée, 2000; Viollet-le-Duc, 2000).
Ancora nell’ambito degli studi sul patrimonio si colloca il volume antologico della Choay intitolato Le patrimoine en questions, pubblicato in prima edizione nel 2009 e frutto, come da lei stessa precisato nell’introduzione, della sua lunga esperienza di docente presso l’École de Chaillot, deputata alla più alta formazione degli architetti specialisti nella cura del patrimonio (Choay, 2009a: 10-11). Qui la Choay raccoglie un ricco insieme di testi, apparentemente eterogenei ma utili per definire lo statuto ambiguo del patrimonio alla luce delle sfide del terzo millennio, invitando all’azione per la sua difesa. In tal senso il lavoro pu rapportarsi direttamente al più remoto L’urbanisme. Utopies et réalités, non soltanto per la scelta antologica, ma anche per la serrata critica al tempo presente. La scelta dei brani conduce quindi la Choay a spaziare dall’abate Suger ad André Malraux, fino ai testi della Carta di Venezia del 1964 e dell’UNESCO, in un percorso che vede affacciarsi anche diverse figure della cultura italiana di ogni tempo, da Poggio Bracciolini, a Pio II Piccolomini, a Raffaello e Baldassarre Castiglione, fino, ovviamente, a Giovannoni, di cui vengono tradotti anche brani estratti da due articoli solo in parte presenti nel volume L’urbanisme face aux villes anciennes del 1998[112]. Il tutto è preceduto da una lunga e profonda introduzione critica, che indaga sullo sviluppo dei concetti di monumento e di patrimonio – avvalendosi di più ampi riferimenti bibliografici italiani rispetto ai suoi precedenti lavori[113] – e pone l’accento sulla attuale crisi nel quadro della globalizzazione (Choay, 2009a: III-XLX). In tale ambito appaiono particolarmente pertinenti e illuminanti le pagine che la studiosa dedica alla rivoluzione elettro-telematica e alla museificazione e mercificazione del patrimonio[114].
Quest’ultimo passaggio ci riconduce al secondo filone di studi portato avanti dalla Choay agli albori del XXI secolo, consistente in una progressiva attenzione verso i temi della gestione locale del territorio nel quadro della globalizzazione, già annunciata in alcuni suoi scritti precedenti, ma che giungerà a occupare gran parte della sua riflessione dei due ultimi decenni. Anche in questo caso i contatti con l’ambiente italiano appaiono molto significativi, concentrati in particolare sulla figura di Alberto Magnaghi, conosciuto nel 1998[115] e divenuto negli anni successivi uno dei suoi principali riferimenti tra gli studiosi italiani. Nel contesto di questo rapporto si collocano due libri in qualche modo simmetrici, testimonianza di un reciproco scambio: l’edizione francese dell’opera più celebre di Magnaghi, Il progetto locale (2000; 2010a), tradotta dalla Choay e apparsa con una sua prefazione per le edizioni Mardaga a Liegi (Belgio) nel 2003[116], e la raccolta di scritti della Choay dal titolo Del destino della città, pubblicata da Alinea nel 2008 per cura dello stesso Magnaghi (Choay, 2008a).
In quest’ultimo volume – da porre in stretta relazione con la già citata antologia Pour une anthropologie de l’espace, apparsa solo due anni prima in Francia, dalla quale sono tratti quasi tutti i brani[117] – è contenuta anche la lectio, già più volte citata, pronunciata dalla Choay a Genova nel 2001 per il conferimento della laurea honoris causa in Architettura, dove la studiosa chiarisce, per la prima volta in modo più esteso, il suo debito verso l’Italia (Choay, 2008c)[118]. La struttura tripartita del sommario di Del destino della città[119] rispecchia la lettura che Magnaghi propone del contributo recente della studiosa, nel quale egli individua il leitmotiv di un’amara presa di coscienza della morte della città, privata dei suoi elementi fondativi dagli esiti della globalizzazione e del cyberspace, espressione – quest’ultima – utilizzata dalla stessa Choay in antitesi al patrimonio urbano in uno dei brani dell’antologia. A questa pars destruens, scrive Magnaghi, si oppone tuttavia una vitale pars construens, nella quale la Choay invita gli architetti e gli urbanisti “a ‘toccar terra’ dalle piazze telematiche alle piazze materiali”, ritornando “a lavorare per i piccoli mondi di vita dell’abitare fra le grandi maglie della organizzazione vertiginosa del movimento globale” (Magnaghi, 2008: 9). È, in sostanza, un invito a porre in relazione inter-scalare il sistema ineludibile delle reti del cyberspazio con la dimensione locale del territorio reale, basata sulla partecipazione, ovvero su “un grande atto corale, sociale, di ricostruzione della memoria, di carattere euristico-pedagogico, cui partecipano insieme artisti, abitanti, progettisti e utenti” (Magnaghi, 2008: 9).
In questa lettura si riconosce perfettamente il processo di scambievole influenza intercorso tra i due studiosi: la Choay attribuisce a Magnaghi la capacità di aver sviluppato in concrete esperienze una parte delle sue utopie, mentre quest’ultimo ritrova nelle riflessioni storico-teoriche della Choay le radici profonde della propria ricerca. Non stupisce, dunque, che la Choay citi Magnaghi nella conclusione del suo Le patrimoine en questions, ricorrendo a una sua bella frase per gettare una luce di speranza sul futuro delle città e del patrimonio[120]. Ma il suo entusiasmo per il lavoro dell’urbanista italiano non si ferma qui: la studiosa infatti arriva a collocare l’opera di Magnaghi al termine di un percorso ideale, avviato dai trattatisti rinascimentali come Alberti, proseguito con Thomas More e Giovannoni, e infine approdato oggi alla consapevolezza della necessità di pianificare il territorio attraverso un attento processo di ascolto delle comunità locali (Choay, Mongin et Paquot, 2005: 91).
Di riflesso, Magnaghi cita più volte la Choay nella prefazione alla seconda edizione accresciuta del suo Il progetto locale, tributando allo scambio con la studiosa lo sviluppo ulteriore delle sue ricerche (Magnaghi, 2010: 9-14). Come conseguenza ulteriore, il nome della Choay si ritrova nelle attività della Società dei Territorialisti, fondata nel 2011 da Magnaghi, di cui la studiosa è membro del comitato scientifico e co-firmataria del relativo “Manifesto”, redatto a più mani tra il 2010 e il 2011[121].
Lungo i percorsi appena citati, con una specifica focalizzazione sulla figura di Giovannoni, si colloca anche il rapporto della Choay con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, incarnato dalle relazioni con Attilio Belli, Stella Casiello e chi scrive. Procedendo in ordine di tempo, vanno richiamati proprio i contatti con Belli, avviati nel corso degli anni Novanta, testimoniati da un’attenta lettura svolta da quest’ultimo de L’Allégorie du patrimoine, per la parte relativa a Giovannoni, da lui discussa nel suo Immagini e concetti nel piano (Belli, 1996: 36-38, 44, 100), cui fa riscontro un giudizio molto lusinghiero della studiosa sul volume citato[122]. Al rapporto con Belli è dovuto anche il primo invito ufficiale della studiosa a Napoli, in occasione del seminario svolto il 10 ottobre 1998 a Castel Nuovo, dedicato al confronto tra il già citato volume di Belli Immagini e concetti nel piano (1996) e la traduzione francese di Giovannoni, appena pubblicata, L’urbanisme face aux villes anciennes.
Agli albori del XXI secolo risale infine il mio primo contatto con la Choay, originato dalle ricerche allora in corso per la mia tesi di dottorato sulla fortuna critica di Giovannoni[123]. Dal fecondo scambio che ne è originato, si è sviluppata anche una specifica riflessione sui temi della globalizzazione, attorno ai quali la Choay ha svolto, su invito di alcuni docenti dell’ateneo Federico II, tra cui Stella Casiello e il sottoscritto, alcuni seminari a Napoli nel novembre 2009, ritornando dopo dieci anni in una città che ha più volte dichiarato di amare profondamente per l’autenticità della sua vita urbana. L’esito del suo passaggio napoletano ha dato quindi luogo a un piccolo libro, curato ancora da Stella Casiello e dal sottoscritto, dal titolo Patrimonio e globalizzazione, pubblicato da Alinea nel 2012 (Choay, 2012b)[124] e presentato a Napoli, alla presenza della Choay, nel maggio 2013[125]. In tale occasione la studiosa ha svolto anche una lectio su Il barone Haussmann conservatore del patrimonio urbano, testimonianza del volume, allora fresco di stampa, da lei scritto sul medesimo tema con Vincent Sainte Marie Gauthier (2013)[126].

Conclusioni
Nell’arco di oltre cinquant’anni, il rapporto biunivoco tra la Choay e l’Italia ha costituito uno dei capisaldi del processo di cross-fertilization della cultura architettonica, urbanistica e patrimoniale tra Italia e Francia. Come fin qui dimostrato, la studiosa ha contaminato le proprie idee attraverso un continuo contatto, svolto sul filo dei secoli, con i grandi pensatori del nostro paese, da Leon Battista Alberti a Gustavo Giovannoni, fino ai tanti studiosi suoi coetanei o più giovani, con i quali lo scambio è stato tanto fecondo e intenso da dare luogo anche a numerose pubblicazioni nei due rispettivi paesi. Basterebbe, in tal senso, citare soltanto il lavoro decennale su Alberti per verificarne la consistenza.
Tra i tanti meriti del lavoro della Choay sull’Italia vi è anche il costante impegno a superare quella tendenza all’exagonalisme (dalla forma esagonale del paese) che ha sempre caratterizzato la Francia, poco incline ad aprirsi ad altre culture europee in rapporto, per esempio, a quanto da sempre svolto dalla Germania (Choay, 2008c: 22). Si deve in effetti assolutamente al suo apporto se figure fondamentali come Alberti, Giovannoni, Boito, siano oggi più conosciute in Francia, ma non solo. La straordinaria notorietà internazionale della Choay ha infatti contribuito certamente a diffondere l’opera di queste ultime anche altrove: le numerose traduzioni de L’Allégorie du patrimoine – volume edito finora in italiano, tedesco, rumeno, portoghese, inglese, spagnolo e cinese[127], letto da generazioni di studiosi – hanno infatti consentito di far conoscere figure come Giovannoni persino in contesti assolutamente remoti rispetto alla nostra cultura. Il lavoro della grande studiosa sull’Italia ha dunque costituito non soltanto un ponte verso la Francia, ma più in generale verso la cultura architettonica e urbanistica occidentale e, in qualche misura, persino orientale.
Nel contempo, la traduzione italiana di molte opere della Choay ha diffuso nel nostro paese una maggiore consapevolezza su tante questioni scottanti per la città e il patrimonio, conferendo alla grande studiosa lo status di vero e proprio nume tutelare dell’autenticità della cultura, a fronte della disumanizzazione debordante della civiltà elettro-telematica. In tal senso la Choay pu dirsi davvero erede degli stessi mitici predecessori da lei studiati e diffusi nella cultura del presente: come il suo amato Alberti, ella ha combattuto e ancora combatte per porre l’uomo al centro di tutte le cose, al fine di restituirgli il ruolo di arbitro del proprio destino, che le moderne tecnologie sembrano volergli fatalmente sottrargli. E in questo processo è sicuro che il nostro paese ha svolto un ruolo fondamentale: come da lei stessa ammesso, infatti, “partire per l’Italia ha cambiato non solo la mia idea del costruire, dell’architettura e della città, ma anche la percezione della mia propria identità. E non è questa la cosa meno preziosa” (Choay, 2008c: 25).
*
Bibliografia
Alberti, Leon Battista (2004) L’Art d’édifier, trad. Pierre Caye et Françoise Choay, Editions du Seuil, Paris.
Argan, Giulio Carlo (1974) .Il trattato De re aedificatoria”, in. Convegno internazionale indetto nel V Centenario di Leon Battista Alberti (Roma-Mantova-Firenze, 25-29 aprile 1972), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, pp. 43-54.
Aymonino, Carlo, Gianni Fabbri e Angelo Villa (1975) Le città capitali del XIX secolo, Officina, Roma.
Belfiore, Pasquale (2018) “La storiografia italiana”, in: Gemma Belli, Alessandro Castagnaro e Fabio Mangone (a cura di), Le Corbusier e noi. Mezzo secolo di studi napoletani, Clean, Napoli, pp. 22-23.
Belli, Attilio (1996) Immagini e concetti nel piano. Inizi dell’urbanistica in Italia, Etas, Milano.
Benevolo, Leonardo (1975) Storia della città, Laterza, Roma/Bari.
Boito, Camillo (1893) Questioni pratiche di belle arti. Restauri, concorsi, legislazione, professione, insegnamento, Hoepli, Milano.
Boito, Camillo (1989) Il nuovo e l’antico in architettura, a cura di M.A. Crippa, Jaca Book, Milano.
Boito, Camillo (2000) Conserver ou restaurer. Les dilemmes du patrimoine, trad. Jean-Marc Mandosio, Les Éditions de l’Imprimeur, Paris.
Bonelli, Renato (1987) “Recensione a F. Choay, La regola e il modello, Officina, Roma 1986”, Architettura. Storia e documenti (1-2): 185-189.
Calvino, Italo (1972) Le città invisibili, Einaudi, Torino.
Calvino, Italo (1993) “Presentazione”, in. Le città invisibili (1972), Oscar Mondadori, Milano, pp. V-XI.
Casiello, Stella (a cura di) (2008) Verso una storia del restauro. Dall’età classica al primo Ottocento, Alinea, Firenze.
Catoni, Maria Luisa (a cura di) (2007) Il patrimonio culturale in Francia, Electa, Milano.
Cerdà, Ildefonso (1867) Teoría general de la urbanización, y aplicación de sus principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona, Imp. Española, Madrid.
Cerdà, Ildefonso (1995) [1985] Teoria generale dell’urbanizzazione, Jaca book, Milano.
Ceschi, Carlo (1970) Teoria e storia del restauro, Bulzoni, Roma.
Choay, Françoise (1956) «Vous pouvez construire une maison pour le prix de deux voitures», France-Observateur 305 (15 mars 1956).
Choay, Françoise (1958a) «La XXIX. Biennale de Venise», L’Œil(45): 29-35.
Choay, Françoise (1958b) «Introduction», in. Le Siège de l’Unesco à Paris, Verlag Gerd Hatje, Stuttgart, pp. 2-17.
Choay, Françoise (1958c) «Un nouvel art de bâtir», Le Courrier XI (11): 4-7.
Choay, Françoise (1958d) «Jean Prouvé», L’Œil (46): 29-35.
Choay, Françoise (1959a) «Bagnols-sur-Cèze: ville nouvelle, intégrée dans le passé», L’Œil (54): 82-87.
Choay, Françoise (1959b) «Le pavillon du Brésil que Le Corbusier vient d’achever à la Cité universitaire de Paris», L’Œil (57): 54-59.
Choay, Françoise (1959c) «Nouvelles zones ou cités-jardins?», L’Œil (55-56): 55-61.
Choay, Françoise (1959d) «Une capitale préfabriquée: Brasilia», L’Œil (59): 76-83.
Choay, Françoise (1960a) «La 30. biennale de Venise», Jardin des arts (70): 44-56.
Choay, Françoise (1960b) Le Corbusier, George Braziller, New York.
Choay, Françoise (1960c) Le Corbusier, trad. Augusta Monferini, Il Saggiatore, Milano.
Choay, Françoise (1962) «La grande compétition pour le Palais d’Orsay. Face aux Tuileries, la gare d’Orsay va faire place à un palais pour lequel plusieurs grands architectes français se disputent l’honneur de voir accepter leurs plans», Connaissance des arts (120): 50-57.
Choay, Françoise (1964a) «Grands ensembles et petites constructions», Art de France (4): 386-391.
Choay, Françoise (1964b) «Situation de l’industrial design», Revue d’esthétique XVII : 264-269.
Choay, Françoise (1965) L’Urbanisme. Utopies et réalités, Editions du Seuil, Paris.
Choay, Françoise (1967a) «Vingt ans d’architecture», Revue d’esthétique XX (4): 376-387.
Choay, Françoise (1967b) «Sémiologie et urbanisme», L’architecture d’aujourd’hui (132): 8-10.
Choay, Françoise (1968) «Le Problème des Halles», L’architecture d’aujourd’hui XXXIX (138): 53.
Choay, Françoise (1969) The modern city: planning in the 19th century, George Braziller, New York.
Choay, Françoise (1972) «Sémiologie et urbanisme», in: Françoise Choay et al., Le sens de la ville, Editions du Seuil, Paris, pp. 9-30.
Choay, Françoise, et al. (1972) Le Sens de la ville, Editions du Seuil, Paris.
Choay, Françoise (1973) La città. Utopie e realtà, trad. Paola Ponis, Einaudi, Torino.
Choay, Françoise (1975) «Haussmann et le système des espaces verts parisiens», Revue de l’art (29): 83-99.
Choay, Françoise (1980), La Règle et le modèle, Editions du Seuil, Paris.
Choay, Françoise (1986) La regola e il modello. Sulla teoria dell’architettura e dell’urbanistica, a cura di E. d’Alfonso, Officina, Roma.
Choay, Françoise (1987) «Mémoire de la ville et monumentalité», in: La qualité de la ville, urbanité française, urbanité nippone, Maison Franco-Japonaise, Tokyo, pp. 121-129.
Choay, Françoise (1988a) «Conclusion», in: Pierre Merlin con Ernesto d’Alfonso et Françoise Choay (eds.), Morphologie urbaine et parcellaire, Colloque d’Arc-et-Senans (28-29 ottobre 1985), Presses Universitaires de Vincennes, Saint-Denis, pp. 145-161.
Choay, Françoise (1988b) «Le De re aedificatoria comme texte inaugural», in: Jean Guillaume (ed.), Les Traités d’architecture de la Renaissance, Actes du Colloque (Tours, 1-11 luglio 1981), Picard, Paris, pp. 83-90.
Choay, Françoise (1989) “Riegl, Freud et les monuments historiques: pour une approche sociétale de la préservation”, in: Irving Lavin (ed.), World Art: Themes of Unity in Diversity, Acts of the 26 International Congress of the History of Art, Pennsylvania State University Press, University Park/London, pp. 799-807.
Choay, Françoise (1991) “L’urbanistica disorientata”, in: Jean Gottmann e Calogero Muscarà (a cura di), La città prossima ventura, Laterza, Roma/Bari, pp. 145-162.
Choay, Françoise (1992a) “Difficile genesi del concetto di patrimonio urbano storico. Ruskin, Viollet-le-Duc, Sitte, Giovannoni”, in: Ernesto d’Alfonso (a cura di),L’orizzonte del posturbano, Officina, Roma, pp. 32-69.
Choay, Françoise (1992b) “La Parigi di Haussmann, ultima forma della città occidentale: ruolo degli spazi verdi e dell’arredo urbano”, in: Ernesto d’Alfonso (a cura di),L’orizzonte del posturbano, Officina, Roma, pp. 63-88.
Choay, Françoise (1992c) “Memoria della città e monumentalità”, in: Ernesto d’Alfonso (a cura di),L’orizzonte del posturbano, Officina, Roma, pp. 11-21.
Choay, Françoise (1992d) “Patrimonio storico e rivoluzioni”, in: Ernesto d’Alfonso (a cura di),L’orizzonte del posturbano, Officina, Roma, pp. 115-125.
Choay, Françoise (1992e) “Riegl, Freud ed i monumenti storici: per un approccio alla conservazione riguardante la coscienza sociale”, in: Ernesto d’Alfonso (a cura di), L’orizzonte del posturbano, Officina, Roma, pp. 101-114.
Choay, Françoise (1994a) «Des textes…au contexte. Réflexions sur la ville et l’architecture», Urbanisme, supplément 5 (décembre 1994): 1-7.
Choay, Françoise (1994b) “Lettera del 1° giugno 1994 da Parigi”, Ananke (6): 35.
Choay, Françoise (1995a) L’allegoria del patrimonio, a cura di Ernesto d’Alfonso e Ilaria Valente, Officina, Roma.
Choay, Françoise (1995b) “Prefazione”, in: Gustavo Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, ristampa a cura di F. Ventura, Cittàstudi, Milano, pp. VII-VIII.
Choay, Françoise (1995c) “Riegl, Freud e i monumenti storici. Per un approccio “societale” alla conservazione”, in: Sandro Scarrocchia, Alois Riegl: teoria e prassi della conservazione dei monumenti, Clueb, Bologna, pp. 455-465.
Choay, Françoise (1996a) [1980] La Règle et le modèle, Editions du Seuil, Paris.
Choay, Françoise (1996b) «Préface à la nouvelle édition», in. La Règle et le modèle, Editions du Seuil, Paris, pp. 11-13.
Choay, Françoise (1998a) «Introduction», in: Gustavo Giovannoni, L’Urbanisme face aux villes anciennes, trad. Jean-Marc Mandosio, Amélie Petita et Claire Tandille, Seuil, Paris, pp. 7-32.
Choay, Françoise (1998b) «L’architecture d’aujourd’hui au miroir du De re aedificatoria», Albertiana (I): 7-29.
Choay, Françoise (1998c) “La competenza di costruire”, Ananke (24): 4-16.
Choay, Françoise (1998d) “Sulla demolizione/conservazione”, in: Alessandra Criconia (a cura di), Figure della demolizione, Costa & Nolan, Roma, pp. 77-93.
Choay, Françoise (1999) [1992] L’Allégorie du patrimoine, Seuil, Paris.
Choay, Françoise (2000a) «Introduction», in: Baron Georges Eugène Haussmann, Mémoires, édition intégrale établie par Françoise Choay, Seuil, Paris, pp. 9-39.
Choay, Françoise (2000b) «Le “De re aedificatoria” comme métaphore du fondement», in: Francesco Furlan et Anna Pia Filotico (eds.), Leon Battista Alberti, Actes du Congrès international de Paris, Sorbonne, Institut de France, Institut culturel italien, Collège de France (Paris, 10-15 avril 1995), 2 volumes, N. Aragno/J. Vrin, Torino/Paris, Volume II, pp. 851-861.
Choay, Françoise (2002) “Camillo Sitte, Der Städtebau nach seinen Künstlerischen Grundsätzen, 1889. Uno statuto antropologico dello spazio urbano”, in: Paola Di Biagi (a cura di), I classici dell’urbanistica moderna, Donzelli, Roma, pp. 3-16.
Choay, Françoise (2003) “Trent’anni dopo”, in. Espacements.Figure di spazi urbani nel tempo. L’evoluzione dello spazio urbano in Francia, a cura di E. d’Alfonso, Skira, Milano, pp. 7-8.
Choay, Françoise, Olivier Mongin et Thierry Paquot (2005) «Les ressorts de l’urbanisme européen: d’Alberti et Thomas More à Giovannoni et Magnaghi. Entretien avec Françoise Choay», Esprit (318): 76-92.
Choay, Françoise (2006a) Le Corbusier en perspective: 1995-1966, in. Pour une anthropologie de l’espace, Editions du Seuil, Paris, pp. 15-37.
Choay, Françoise (2006b) «Le De re aedificatoria et l’institutionnalisation de la société», in: Françoise Choay et Michel Paoli (eds.), Alberti, humaniste, architecte, École nationale supérieure des beaux-arts, Paris, pp. 93-109.
Choay, Françoise (2006c) «Le De re aedificatoria et l’institutionnalisation de la société», in. Pour une anthropologie de l’espace, Seuil, Paris, pp. 374-401.
Choay, Françoise (2006d) Pour une anthropologie de l’espace, Editions du Seuil, Paris.
Choay, Françoise (2008a) Del destino della città, a cura di A. Magnaghi, Alinea, Firenze.
Choay, Françoise (2008b) Les rapports de Ruskin et Viollet-le-Duc, ou la longue durée des idées reçues, Les Nouveaux Cahiers de l’Académie d’architecture 3, Paris.
Choay, Françoise (2008c) “Prologo: Partire per l’Italia”, in: Françoise Choay, Del destino della città, a cura di A. Magnaghi, Alinea, Firenze, pp. 21-26.
Choay, Françoise (2008d) “L’utopia e lo statuto antropologico dello spazio edificato”, in: Françoise Choay, Del destino della città, a cura di A. Magnaghi, Alinea, Firenze, pp. 29-51.
Choay, Françoise (2008e) “Il De re aedificatoria e l’istituzionalizzazione della società, ovvero: lezioni da una traduzione”, in: Françoise Choay, Del destino della città, a cura di A. Magnaghi, Alinea, Firenze, pp. 52-74.
Choay, Françoise (2008f) “Sulla demolizione”, in: Françoise Choay, Del destino della città, a cura di Alberto Magnaghi, Alinea, Firenze, pp. 77-93.
Choay, Françoise (2008g) “Introduzione a: Baron Haussmann, Mémoires”, in: Françoise Choay, Del destino della città, a cura di A. Magnaghi, Alinea, Firenze, pp. 173-202.
Choay, Françoise (2009a) Le Patrimoine en questions. Anthologie pour un combat, Éditions du Seuil, Paris.
Choay, Françoise (2009b) «Lévi-Strauss et l’aménagement des territoires», Urbanisme (365): 17-21.
Choay, Françoise (2010) “Utopia e patrimonio nel progetto del territorio”, in: Daniela Poli (a cura di), Contesti: città, territori, progetti. Rivista del Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio (2): 46-54.
Choay, Françoise (2011) La terre qui meurt, Fayard, Paris.
Choay, Françoise (2012a) La Conférence d’Athènes sur la conservation artistique et historique des monuments (1931), édition établie et préfacée par Françoise Choay, Editions du Lintau, Paris.
Choay, Françoise (2012b) Patrimonio e globalizzazione, trad. Jean-Marc Mandosio, Alinea, Firenze.
Choay, Françoise (2013) «Victor Hugo aux avant-postes de l’anthropologie et de la linguistique», Ananke 68: 4-10.
Choay, Françoise et Vincent Sainte Marie Gauthier (2013) Haussmann conservateur de Paris, Actes Sud, Paris.
Choay, Françoise (2015a) [1988] «Ensemble historique ou traditionnel», in: Pierre Merlin et Françoise Choay (sous la direction de), Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Presses Universitaires de France, Paris, pp. 295-296.
Choay, Françoise (2015b) [1988] «Patrimoine», in: Pierre Merlin et Françoise Choay (sous la direction de), Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Presses Universitaires de France, Paris, pp. 535-538.
Choay, Françoise (2015c) [1988] «Posturbain», in: Pierre Merlin et Françoise Choay (sous la direction de), Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Presses Universitaires de France, Paris, pp. 611-612.
Choay, Françoise et Philippe Preschez (2015) [1988] «Abords», in: Pierre Merlin et Françoise Choay (sous la direction de), Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Presses Universitaires de France, Paris, pp. 1-4.
Ciucci, Giorgio, Francesco Dal Co, Mario Manieri Elia e Manfredo Tafuri (1973) La città americana dalla guerra civile al New Deal, Laterza, Roma/Bari.
Ciucci, Giorgio (1989) Gli architetti e il fascismo. Architettura e città 1922-1944, Einaudi, Torino.
Cohen, Jean-Louis (1984) «La coupure entre architectes et intellectuels, ou les enseignements de l’italophilie», In extenso/1, Recherches à l’École d’Architecture Paris-Villemin, Paris.
Cohen, Jean-Louis (2015) La Coupure entre architectes et intellectuels, ou les enseignements de l’italophilie, Mardaga, Bruxelles.
Cornu, Marie et Vincent Négri (2018) «La protection des abords», in: Jean-Pierre Bady, Marie Cornu, Jérome Fromageau, Jean-Michel Leniaud et Vincent Négri (sous la direction de), De 1913 au Code du patrimoine. Une loi en évolution sur les monuments historiques, Comité d’histoire du ministère de la Culture, Paris, pp. 100-115.
Curuni, Alessandro (1979) “Riordino delle carte di Gustavo Giovannoni. Appunti per una biografia”, in. Archivio di Documenti e Rilievi dei Monumenti, 2, Roma.
d’Alfonso, Ernesto (a cura di) (1985) Ragioni della storia e ragioni del progetto: discussioni sulla teoria con Françoise Choay, Clup, Milano.
d’Alfonso, Ernesto (1988) «Introduction au concept de morphologie urbaine», in: Pierre Merlin, Ernesto d’Alfonso et Françoise Choay (eds.), Morphologie urbaine et parcellaire, Colloque d’Arc-et-Senans (28-29 ottobre 1985), Presses Universitaires de Vincennes, Saint-Denis, pp. 67-74.
d’Alfonso, Ernesto (1992) “Postfazione”, in: Françoise Choay, L’orizzonte del posturbano, Officina, Roma, pp. 127-132.
Del Bufalo, Alessandro (1982) Gustavo Giovannoni. Note e osservazioni integrate dalla consultazione dell’archivio presso il Centro di Studi di Storia dell’Architettura, Kappa, Roma.
De Poli, Aldo, Marino Naropozzi, Thierry Roze, Claude Cosneau et Marie-Paule Dalgand (1984) “Aldo Rossi, théâtre, ville, architecture”, 303 Recherches et Créations (TAP 5).
Dezzi Bardeschi, Marco (2006) “Françoise Choay, Leon Battista Alberti e l’antropogenesi dello spazio urbano”, Ananke (49): 2-5.
Dezzi Bardeschi, Marco (2009) “Françoise Choay e una lettera inedita di Ruskin del 1887”, Ananke (56): 2-8.
Dezzi Bardeschi, Marco (2010) “Antologia per una grande crociata”, Ananke (59): 70-71.
Dezzi Bardeschi, Marco (2013) “Françoise Choay: riabilitare Haussmann”, Ananke (70): 160-161.
Dezzi Bardeschi, Marco (2016) “Choay: Hugo e Lévi-Strauss, linguistica e antropologia”, Ananke (77): 94.
Dunford, Nelson and Jacob T. Schwartz (1958-1971) Linear operators, Interscience, New York.
Ferlenga, Alberto (2014) “A due anni dal ’68. L’architettura della città e la conquista di una libertà intellettuale”, in: Fernanda De Maio, Alberto Ferlenga, Patrizia Montini Zimolo (a cura di), Aldo Rossi, la storia di un libro, Il Poligrafo, Padova, pp. 15-22.
Fraticelli, Vanna (1982) Roma 1914-1929. La città e gli architetti tra la guerra e il fascismo, Officina, Roma.
Giovannoni, Gustavo (1913) “Il «diradamento» edilizio dei vecchi centri. Il quartiere della Rinascenza in Roma”, Nuova Antologia XLVIII (997): 56-76.
Giovannoni, Gustavo (1925) “Ricostruzione del vecchio centro o decentramento?”, Capitolium I (4): 221-225.
Giovannoni, Gustavo (1995) Vecchie città ed edilizia nuova, ristampa a cura di Francesco Ventura, Cittàstudi, Milano.
Heidegger, Martin (1976) .Costruire, abitare, pensare", in. Saggi e discorsi, a cura di Gianni Vattimo, Mursia, Milano.
Ingallina, Patrizia (2004) Il progetto urbano. Dall’esperienza francese alla realtà italiana, Franco Angeli, Milano.
Jencks, Charles and George Baird (eds.) (1969) Meaning in architecture, Barrie & Rockliff, London.
Lefebvre, Henri (1968) Le Droit à la ville, Anthropos, Paris.
Lefebvre, Henri (1970) Il diritto alla città, trad. Gianfranco Morosato, Marsilio, Padova.
Magnaghi, Alberto (2000) Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Torino.
Magnaghi, Alberto (2003) Le Projet local. Manuel d’aménagement territorial, trad. Amélie Petita, Mardaga, Liège.
Magnaghi, Alberto (2008) “Presentazione: un urbanista alle prese con Françoise Choay”, in: Françoise Choay, Del destino della città, a cura di A. Magnaghi, Alinea, Firenze, pp. 77-93.
Magnaghi, Alberto (2010a) Il progetto locale. Verso la coscienza di luogo, Bollati Boringhieri, Torino.
Magnaghi, Alberto (2010b) “Presentazione della nuova edizione”, in. Il progetto locale. Verso la coscienza di luogo, Bollati Boringhieri, Torino, pp. 9-14.
Marconi, Paolo (1993) Il restauro e l’architetto. Teoria e pratica in due secoli di dibattito, Marsilio, Venezia.
Mérimée, Prosper (2000) «Variation I. Lettre sur la cathédrale de Strasbourg (15 juin 1836)», in: Camillo Boito, Conserver ou restaurer. Les dilemmes du patrimoine, trad. Jean-Marc Mandosio, Les Editions de l’Imprimeur, Paris pp. 89-92.
Merlin, Pierre et Choay, Françoise (sous la direction de) (2015) [1988] Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Presses Universitaires de France, Paris.
Mumford, Lewis (1961) The City in History: its origins, its transformations, and its prospects, Harcourt, Brace & World, New York.
Mumford, Lewis (1964) La Cité à travers l’histoire, trad. Guy et Gérard Durand, Éditions du Seuil, Paris.
Pane, Andrea (2005) “La fortuna critica di Gustavo Giovannoni: spunti e riflessioni dagli scritti pubblicati in occasione della sua scomparsa”, in: Maria Piera Sette (a cura di), Gustavo Giovannoni: riflessioni agli albori del XXI secolo, giornata di studio dedicata a Gaetano Miarelli Mariani (Roma, 26 giugno 2003), Bonsignori, Roma, pp. 207-216.
Pane, Andrea (2020) “Françoise Choay dall’urbanisme al patrimoine: architettura, urbanistica e restauro tra Francia e Italia”, in: Attilio Belli (a cura di), Pensare lo spazio urbano. Intrecci tra Italia e Francia nel Novecento, Franco Angeli, Milano, pp. 52-108.
Paquot, Thierry (2019) “Die Städtebautheoretikerin Françoise Choay. Eine diskurs bildende Propagatorin der Disziplin“, in: Katia Frey und Eliana Perotti (a cura di), Frauen blicken auf die Stadt. Architektinnen, Planrinnen, Reformerinnen, Reimer, Berlin, pp. 275-292.
Persico, Edoardo (1935) “Introduzione a Le Corbusier”, Casabella VIII (85): 42-43.
Racheli, Alberto Maria (1996) “Recensione a G. Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, ristampa a cura di F. Ventura, Cittàstudi, Milano 1995”, Ricerche di storia dell’arte 60: 98-100.
Rossi, Aldo (1981) A scientific autobiography, MIT Press, Cambridge/London.
Rossi, Aldo (1990) Autobiografia scientifica, Pratiche editrice, Parma.
Roze, Thierry (2014) “The Architecture of the City: from Zurich to Nantes”, in: Fernanda De Maio, Alberto Ferlenga, Patrizia Montini Zimolo (a cura di), Aldo Rossi, la storia di un libro, Il Poligrafo, Padova, pp. 201-212.
Turco, Maria Grazia (2019) “La Conferenza di Atene del 1931. Rilettura critica di alcuni documenti conservati nell’Archivio di Gustavo Giovannoni”, in: Giuseppe Bonaccorso e Francesco Moschini (a cura di), Gustavo Giovannoni e l’architetto integrale, Quaderni degli Atti, 2015-2016, Atti del convegno internazionale, Accademia Nazionale di San Luca, Roma, pp. 39-46.
Valente, Ilaria (1988) «Continuité et crise: les études sur la morphologie urbaine en Italie (1959-1975)», in: Pierre Merlin, Ernesto d’Alfonso et Françoise Choay (eds.), Morphologie urbaine et parcellaire, Colloque d’Arc-et-Senans (28-29 ottobre 1985), Presses Universitaires de Vincennes, Saint-Denis, pp. 75-80.
Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel (2000) «Variation II. De la restauration des anciens édifices en Italie (1872)», in: Camilo Boito, Conserver ou restaurer. Les dilemmes du patrimoine, trad. Jean-Marc Mandosio, Les Editions de l’Imprimeur, Paris, pp. 93-99.
Zevi, Bruno (1950) Storia dell’architettura moderna, Giulio Einaudi editore, Torino.
Zucconi, Guido (1989) «Gustavo Giovannoni. La naissance de l’architecte intégral en Italie», Les Annales de la recherche urbaine (44-45): 185-194.
Zucconi, Guido (1997) “Dal capitello alla città. Il profilo dell’architetto totale”, in: Gustavo Giovannoni, Dal capitello alla città, antologia di scritti a cura di G. Zucconi, Jaca Book, Milano, pp. 9-69.
Nota

