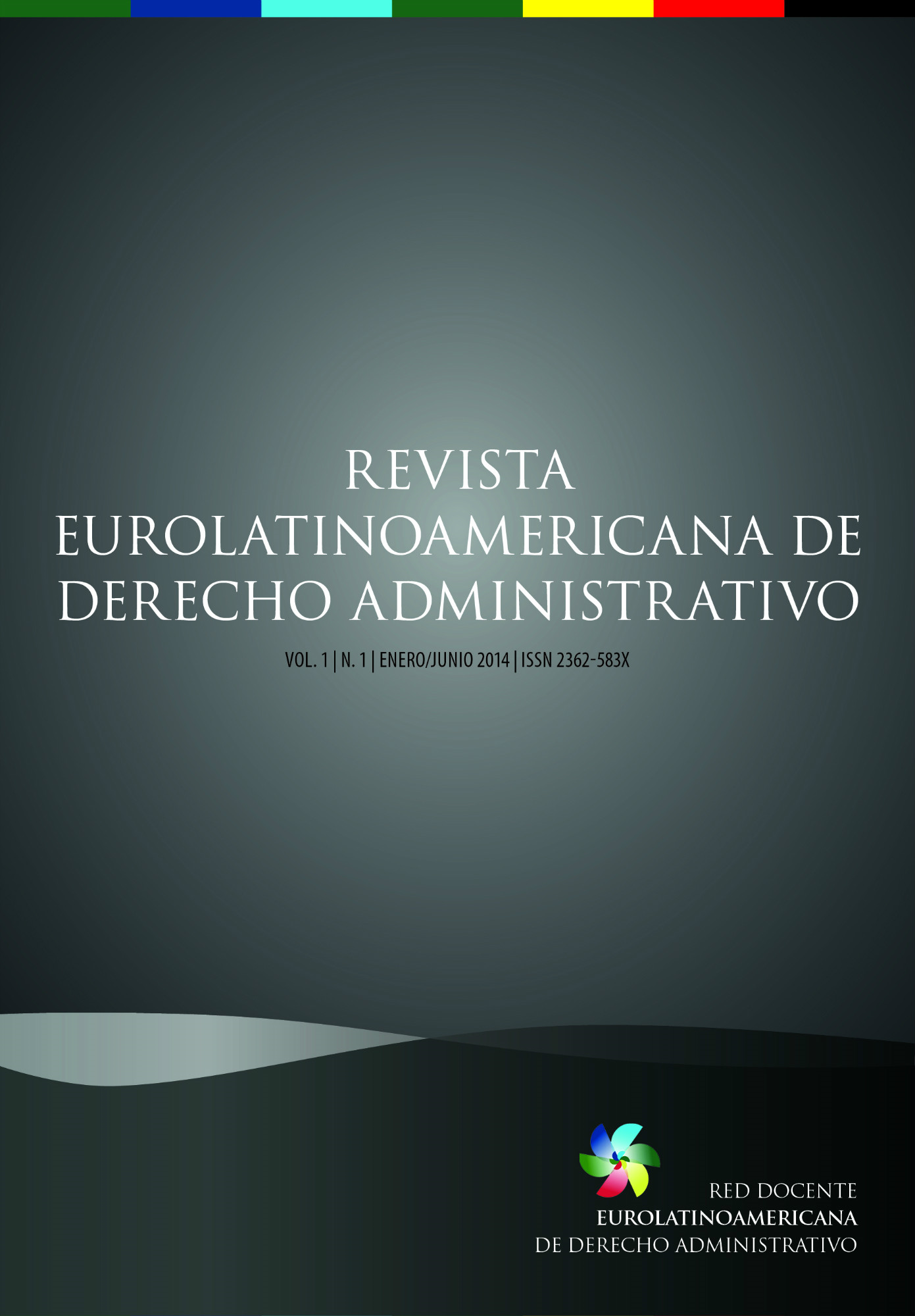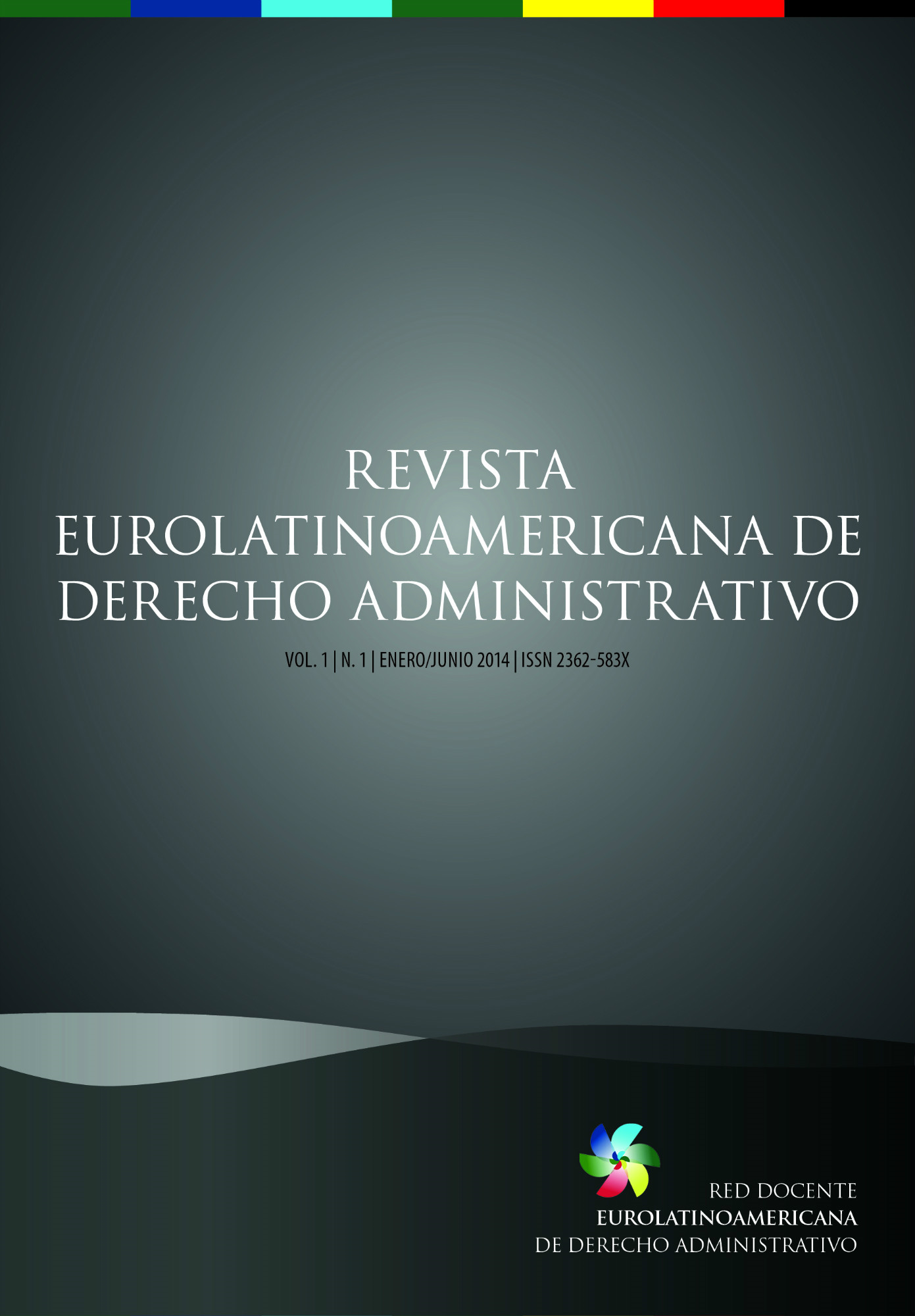Sommario:
1.
Il «ritorno di fiamma» di «una fonte di complessa tipologia». 2. Dallo «statuto redivivo»
all’«orizzonte ermeneutico post statuale» dell’autonomia. 3. Riferimenti.
1. Il «ritorno di fiamma» di «una fonte di
complessa tipologia»
Gli interventi del legislatore italiano a cavaliere dei secoli XX-XXI, culminati con la costituzionalizzazione del principio di autonomia normativa di comuni, province e città metropolitane, tramite l’esercizio dell’autonomia statutaria e regolamentare[1], hanno impresso un’accelerazione nello sviluppo di nuovi moduli interpretativi diretti a uno studio comparativo tra la legislazione statutaria delle civitates e quella dei centri minori e una diversa attitudine intorno al rapporto tra ‘storia delle città’ e ‘storia delle comunità’[2], al fine di far emergere i tratti peculiari dell’universo policentrico d’antico regime.
La storiografia giuridica è parsa subito interessata a recuperare spazio nell’analisi e nell’indagine dei temi dell’autonomia politico-normativa e finanziaria degli enti locali[3], potendo contare su una consolidata tradizione di studi nell’Italia centro-settentrionale, tanto da suscitare interesse anche negli storici dell’età moderna, accanto ai medievisti, nella logica di un approccio multidisciplinare[4]:
La
storia del diritto che negli ultimi anni ha registrato un imperioso ritorno,
dopo un periodo di eclissi, per merito dei suoi studiosi ex-professo, ha
conosciuto anche l’attenzione di storici dell’età moderna. La storia delle
comunità ha dunque beneficiato (se non promosso in taluni casi) di quello
che... abbiamo definito un "ritorno agli statuti"[5].
Il «ritorno di fiamma»[6] degli statuti ha offerto la possibilità agli studiosi di affrontare in modo più articolato anche il tema storiografico del "dualismo italiano", costruito sull’idea di un Regno, nel Sud del paese, che dalla sua nascita, nel XII secolo, aveva mostrato notevoli capacità di sviluppo di un modello di ordinamento pubblico accentrato sulla monarchia e sulle aristocrazie feudali, sacrificando la vitalità economica e commerciale delle comunità urbane, tanto da essere classificato come "area passiva" prevalentemente agricola, destinata ad essere sfruttata commercialmente dalle forze autonome, manifatturiere, mercantili e finanziarie che promanavano dallo sviluppo comunale delle città nel Centro-Nord[7].
La chiave di volta, allora, è consistita nel collocare i rapporti tra Nord e Sud d’Italia in una prospettiva di interconnessione, più che di lineare dipendenza economica, tra diverse aree della penisola, badando ad evitare l’applicazione di rigidi schemi di omogeneità e di uniformazione, perché la presenza di una logica di scambio ineguale, certamente evidente, nondimeno si è rivelata suscettibile di significative oscillazioni in relazione alle variabili geografiche, storiche e agli sviluppi dei singoli settori sociali, economici e commerciali, di volta in volta, presi in considerazione. Nello stesso tempo, se si eccettua l’insorgenza del "nuovo dualismo" noto come "questione meridionale", conseguente all’unificazione dell’Italia nel XIX secolo[8], la storiografia ha colto l’opportunità di allargare gli orizzonti di ricerca, in una prospettiva non soltanto nazionale, ma che, obbligatoriamente, si rivolge in chiave comparatistica ad osservare le trame delle dinamiche relazionali tra le regioni europee e quelle mediterranee[9].
Sul piano più strettamente giuridico, il "dualismo italiano", riguardante la diversa natura e fondamento degli ordinamenti municipali tra le città del Nord e quelle del Sud, era stato già messo a fuoco e calibrato nei primi decenni del Novecento dallo storico del diritto italiano, Francesco Calasso, il primo a «ricostruire anche per l’Italia meridionale una dottrina degli Statuti»[10] e a far uscire dallo "stato di minorità" «La legislazione statutaria dell’Italia meridionale»[11].
A raccogliere il testimone del maestro salentino è stato uno dei suoi allievi, Mario Caravale, che sin dagli anni ottanta del XX secolo si è reso promotore di iniziative dirette a
riprendere l’analisi del diritto statutario e consuetudinario delle città dell’Italia meridionale e della Sicilia, senza lasciarsi coinvolgere dalla polemica che ha impegnato gli storici, e soprattutto gli storici del diritto, tra la seconda metà del secolo scorso e la prima metà del nostro... Appare ormai necessario esaminare quel diritto proprio nel suo contenuto, per coglierne la ricchezza e il notevole apporto al quadro complessivo dell’ordinamento giuridico del regno[12].
Per qualificare il livello d’interazione organica tra i compiti amministrativi delle comunità locali del Sud d’Italia in antico regime e la presenza di un ordinamento politico unitario di tipo monarchico, lo storico medievale, Ivan Antonio Pini[13], ha utilizzato la categoria dell’«ente amministrativo», differenziandola dal modello del «comune politico» dell’Italia centro-settentrionale[14]. Una linea interpretativa, questa, descritta con una sensibilità affinata dall’esperienza politica anche dallo storico medievale e moderno napoletano, Giuseppe Galasso, secondo il quale:
Nella fissazione del comune come modulo ed ente amministrativo locale l’esperienza del Mezzogiorno ebbe... un suo valore che andava ben oltre i confini del paese, e non si può neppure negare che la «legislazione statutaria» dei comuni meridionali abbia rappresentato un importante contributo alla formazione del grande patrimonio amministrativo italiano e della sua esperienza istituzionale e normativa[15].
Questo tipo di argomentazione mostra, tuttavia, le asperità di una valutazione giuridica che racchiude fattori di criticità, laddove ci si spinga, e non è il caso degli autorevoli maestri summenzionati, ad appiattire il discorso storiografico sulla riduzione del rapporto tra monarchia e città dei Regni di Napoli e di Sicilia in un automatico rapporto di comparazione tra Stato ed enti locali, nell’accezione contemporanea:
Si tratta, infatti, di due relazioni diverse nella sostanza, dato che si tratta oggi della dialettica tra l’unico titolare della sovranità e un ente locale, nel Medioevo di quella tra due titolari di dominium sul territorio municipale. Una differenza che dovrebbe suggerire estrema cautela nell’utilizzare per il Medioevo lo stesso concetto di «autonomia» costruito dalla scienza giuridica del secolo XIX in riferimento alla competenza degli enti territoriali locali definita dalla legge statale[16].
Si aggiunga, poi, che nell’età moderna la tendenza a sviluppare pratiche di governo di stampo assolutistico nel regno di Napoli produsse un modello di Stato giurisdizionale "macrocefalo", vale a dire avviluppato sulla capitale e sui tribunali supremi, con modelli urbani periferici dai tratti giuridici peculiari e nondimeno rilevanti rispetto al contesto nazionale[17], i quali attendono di essere studiati a fondo senza ricorrere agli abusati e anacronistici termini dell’«analogia» o peggio dell’«anomalia» rispetto ai corrispettivi del Centro-nord d’Italia[18]:
Un’altra
importante caratteristica della storia provinciale del Regno di Napoli, che si
viene delineando in età moderna, è l’assenza di un vero e proprio sistema
urbano. Le città non mancano: non solo gli ambiti provinciali della Campania e
delle Puglie, ma anche altre aree del Mezzogiorno presentano nuclei urbani
dotati di una storia vivacissima e dal punto di vista economico-sociale e dal
punto di vista civile. Essi hanno potuto sviluppare nel tempo un complesso di
funzioni legate al particolare tipo di insediamento, alla vita religiosa,
all’economia protoindustriale o agricolo-pastorale, agli scambi commerciali, al
servizio politico-amministrativo, alla posizione strategico-militare, ecc. Ma
le città meridionali sono intimamente collegate al territorio rurale da una
stretta rete di interdipendenze: il continuum
città-campagna è un elemento caratterizzante, nel senso che la città
dipende largamente dal contado per la formazione del reddito e della ricchezza,
e nel senso che la città raramente svolge una funzione di coordinamento e di
organizzazione del suo hinterland.
Tra il XVI e il XVIII secolo la dimensione prevalente dei comuni meridionali –
oltre il 70% – è inferiore agli 8 mila abitanti[19].
Analoghe considerazioni si possono cogliere negli studi dello storico del diritto italiano e delle istituzioni politiche, Andrea Romano, per quanto riguarda il regno di Sicilia:
Prassi
statutaria e contrattualismo diventavano espressione degli equilibri politici
del Regno che si riflettevano nei capitula
e nelle consuetudines seu statuta delle
città. Illuminante, in tale prospettiva, può risultare l’indagine diplomatica,
a torto sottovalutata da chi disprezza i lettori di carte polverose, colme di
particolari... Quelle formule, con il passaggio dai diplomi alle gratiae,
nella loro intrinseca diversità, finivano per essere il risultato di equilibri
politici e attestavano realtà giuridiche diverse, peraltro non sempre ben
comprese, specialmente da chi legge le vicende siciliane e del diritto
dell’Isola, in aderenza o in contrapposizione all’altra Italia o da chi guarda
alla Sicilia collocandola in un generico "regno meridionale"[20].
La fioritura di studi sulle città del Sud d’Italia ha trovato una sintesi tra medievisti, modernisti e storici del diritto, nella consapevolezza di verificare, attraverso attività di ricerca e di valorizzazione del materiale documentario superstite, la possibilità di costruire nuove basi di interpretazione delle vicende urbane per il tramite del tema dell’identità, come si evince dalle riflessioni di Pietro Corrao[21] e di Giovanni Vitolo:
un campo promettente di indagine è... quello delle città, che appaiono
in grado di interagire sempre, sia pur con esiti diversi, con il potere regio,
con il ceto baronale e con le comunità rurali, sviluppando nello stesso tempo
una strategia "identitaria" pienamente comparabile con quella di altre realtà
urbane dell’Italia e dell’Europa: strategia che fu assai varia e si attuò con
tempi diversi, anche se fu soprattutto sul finire del Medioevo che giunse ad
esiti tendenzialmente stabili e duraturi, non a caso in coincidenza con i
fenomeni di consolidamento delle istituzioni politico-amministrative e di
formalizzazione della preminenza sociale e politica. Saldamente inquadrate
nelle strutture dello "Stato moderno" spagnolo e sotto la protezione di santi
patroni di collaudata potenza, ma nello stesso tempo consapevoli del carattere
identitario del proprio patrimonio normativo e della propria storia politica,
religiosa e culturale, le città del Mezzogiorno si accingevano ad affrontare
una navigazione ancora più difficile e avventurosa di quella medievale, prima,
nel "lungo Cinquecento" e poi in quelli che la storiografia chiamava "i tempi
grigi della storia d’Italia"[22].
Assolutamente speculare all’orientamento metodologico delineato dai due storici medievisti è il quadro d’indagine tracciato dagli storici del diritto Beatrice Pasciuta[23], per il regno di Sicilia, e Aurelio Cernigliaro, per il regno di Napoli, il quale ritiene indispensabile abbandonare il riferimento al
criterio dell’autonomia[24],
ossia di uno specifico potere deliberativo, mentre rilievo crescente assume
l’identità[25] del centro di volta in
volta preso in esame: quanto a dire in sede storiografica l’esigenza di
chiarirne a fondo i termini peculiari dell’essere in rapporto alle entità
finitime od analoghe per condizioni esistenziali ovvero – e sopra tutto – in
rapporto alla ‘dominante’. Quell’esigenza generale s’impone, d’altra parte, in
maniera precipua per la realtà giuridica ed istituzionale del Mezzogiorno
quando ci si prefigga d’individuare per i centri minori la sfera di specifica
identità innanzitutto in riferimento a Napoli come centro-capitale[26].
La storiografia giuridica, sull’onda della cornice normativa approntata in Italia tra la fine del XX e gli inizi del XXI secolo, che sembrava avviare una stagione di costruzione di diverse e più aggiornate forme di democrazia partecipativa e di superamento del rigido centralismo statale attraverso il richiamo, nell’esercizio dell’autonomia normativa degli enti locali, alle specificità territoriali e storiche, è ritornata, quindi, a Nord come a Sud del paese, ad occuparsi della legislazione statutaria delle città d’antico regime. L’attenzione metodologica si è presto configurata come esigenza accademica di fornire agli estensori dei nuovi statuti la ricostruzione di una documentazione storica, che, affiancata ai dati paesaggistici, archeologici e linguistici, potesse essere in grado di restituire vitalità a una fonte giuridica d’antico regime, non nella dimensione comparativa in quanto a natura e fondamento, ma nella veste di recuperato patrimonio genetico e identitario funzionale alla contemporanea gestione del patrimonio culturale ed ambientale locale.
La storiografia politica italiana, invece, dal 1945 in poi, ha mostrato una pressoché indifferenza in merito al tema del particolarismo territoriale, ritenendolo un inutile fardello di cui la modernità si era presto liberata attraverso la scelta dell’accentramento e del potere statale innervato su scala nazionale. È pur vero che le interpretazioni romantiche e risorgimentali sul tema della libertà dei liberi comuni medievali italiani, rese in musica anche da Giuseppe Verdi[27], hanno fatto breccia nelle teorie indipendentiste e federaliste assorbite e proposte da alcuni movimenti territoriali nel Nord d’Italia, confluiti nei primi anni novanta del secolo scorso nel partito della Lega Nord[28]. Ma proprio queste tendenze hanno finito per innalzare uno steccato nella valutazione negativa degli enti locali come "anti-Stato", causa di frammentazione del potere politico e di debolezza dell’autorità pubblica centrale asservita agli interessi particolaristici delle fazioni e dei gruppi di interesse territoriali[29].
Verso la fine degli anni novanta del XX secolo, è stato coinvolto nel dibattito storiografico sul tema statutario anche lo storico del diritto, Mario Sbriccoli, autore di un’insuperata monografia nel 1969 sul ruolo dei giuristi nel funzionamento delle istituzioni comunali, non a caso ristampata nel 2002[30], che gli aveva consentito di indagare «i rapporti di potere, le ideologie politiche, gli strumenti di mediazione di cui l’interpretatio iuris dei giuristi è parte integrante attraverso la scrittura, l’uso e la revisione [degli statuti]»[31].
Al fine di agevolare l’individuazione di strumenti più aggiornati di analisi, lo storico di Macerata ha indicato il percorso da seguire per rinnovare la letteratura storico-giuridica. Una fonte certamente giuridica, ma di «complessa tipologia»[32], come quella statutaria, richiede sul piano metodologico un più intenso dialogo tra giuristi e storici della società. Non stupisca, dunque, il monito agli studiosi del
rilievo della legislazione
statutaria non solo nella storia del giuridico, ma anche – e forse soprattutto
– nella storia politica delle città, perché è ormai acquisita anche per gli
storici non giuristi la convinzione che la storia delle città sta in
grandissima parte nella storia della loro costituzione formale e materiale. Ma
negli statuti c’è molto di più che questo: c’è la traccia stabile delle
culture, dei conflitti, della crescita anche materiale della comunità, della
loro produzione artistica, del loro sviluppo economico e della loro maturazione
civile... Ma lo statuto non è una legge, nel senso che noi diamo a questa
espressione, e tanto meno una «carta costituzionale» moderna. Lo statuto è il
risultato stratificato di una storia, ed in questa misura registra e conserva
elementi storici che possono sembrare, e magari sono, contraddittori e
incoerenti... Questo elemento della lunga durata è, per così dire, l’indizio
probante della valenza simbolica dello statuto, considerato alla stregua di un
baluardo, un’ancora della autonomia; in tempi più tardi, tra XVII e XVIII
secolo, sarebbe stato tenuto come l’antico testimone della identità, o meglio
ancora, forse, della speranza di una comunità, che ha perso la sua autonomia e
che rischia di perdere la sua riconoscibilità storica: la speranza di
conservare esistenza ed immagine in una realtà statale che minaccia di
cancellarle... Cosa che in qualche misura ed in un certo modo è avvenuta:
perché io credo che il mantenimento del senso delle municipalità, quello che
l’ottocento ha identificato con i campanili e che l’esperienza politica recente
sta rivalorizzando con l’affermazione ed il progressivo rafforzamento del
principio delle autonomie locali, altro non sia se non il lontano esito di quella
vicenda storica[33].
2. Dallo «statuto redivivo»
all’«orizzonte ermeneutico post statuale» dell’autonomia
Il processo di riforma, iniziato con la l. n. 142/90[34] e proseguito negli anni successivi con la l. n. 59 /1997, l. n. 265/1999, t.u. e.l. n. 267/2000, l. cost. n. 3/2001[35], l. n. 131/2003 etc., aveva come obiettivo la valorizzazione delle autonomie regionali e locali, assecondando l’idea di realizzare una «Repubblica delle autonomie»[36] fondata sulla coesione e solidarietà sociale. L’evoluzione di una simile prospettiva è apparsa agli studiosi accorti subito impervia, in un quadro istituzionale e normativo giammai coerente e organico[37], alla perenne ricerca di una sintesi, al netto delle ideologie e delle strategie dei partiti, tra coscienza civica e interessi nazionali[38].
Le nuove formulazioni degli artt. 114 e 118 Cost. sembravano, tuttavia, in grado di garantire agli enti locali, nella qualità di «enti autonomi», una formale posizione di equiordinazione tra gli elementi costitutivi della Repubblica e una pari dignità costituzionale rispetto al ruolo delle regioni ex art. 117 Cost. Le amministrazioni locali, tramite il conferimento di una significativa autonomia statutaria[39] e regolamentare[40], avrebbero potuto finalmente, nei limiti dell’ordinamento statuale, individuare una cornice normativa idonea a rappresentare i moduli di governo e di amministrazione a misura delle specificità territoriali[41].
La ricerca storico-giuridica sulla legislazione statutaria e sulle consuetudini delle città italiane d’antico regime, prima della loro definitiva abolizione nel XIX secolo, è apparsa, allora, indispensabile non solo per ricostruire le matrici identitarie locali, ma soprattutto per agevolare la realizzazione di modelli strutturali ed organizzativi in grado di coniugare il radicamento di una comunità con i suoi possibili sviluppi futuri. Il lessico delle patrie, della cittadinanza e delle comunità è in continua evoluzione, sotto la pressione della mondializzazione delle economie, dell’integrazione transnazionale della società civile e «della crisi di uno degli elementi centrali del concetto di Stato, il territorio». In questo quadro di «spazio giuridico globale» che depotenzia, ma non dissolve, lo Stato-nazione e le sue matrici borghesi, si delinea la sfida di salvaguardare la coesistenza delle identità territoriali e dei "microsistemi" nelle nuove realtà, pluriordinamentale, nazionale, europea ed internazionale, perseguendo l’obiettivo di coniugare le spinte all’autonomia con l’integrazione nell’ordinamento del "macrosistema"[42].
Contro le nuove identità fittizie dei fondamentalismi, costruite in contrapposizione al processo di globalizzazione, occorre recuperare il senso del radicamento territoriale, con i «vexilla» e le specificità geo-storiche. Ma non basta, altrimenti si corre il rischio di alimentare pittoreschi, quanto sterili, atteggiamenti folcloristici. Il localismo in Italia, stretto tra la «deterritorializzazione» dovuta alla globalizzazione, l’integrazione europea e l’«autocentralizzazione», è determinante solo se lo si inquadra in un modello policentrico delle autonomie, «non semplicemente [in] un sistema bipolare (federazione-Stati membri o Stato-regioni)»[43].
Il recupero della dimensione locale, del paesaggio e della memoria storica con la possibilità di nuove forme di partecipazione e di responsabilità, nonché di una più diretta applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza[44], va, però, fecondamente integrato con altri valori identitari. Non inquadrabili in un modello d’identificazione univoco, perché sempre più al servizio di comunità fluttuanti, questi ultimi potranno, in ogni modo, ben adeguarsi ai profili giuridici di una nuova amministrazione pubblica che dimostri, consapevolmente, di sapersi organizzare intorno alla centralità delle "autonomie" e dell’integrazione tramite diritti-doveri intimamente connessi alla vita e al sentire locale.
In base ad un orientamento autorevole, il radicamento identitario può interpretarsi, non solo come un valore di chiusura alimentato dalle paure della crisi economica e dalle legittime preoccupazione di sicurezza e ordine pubblico, ma, più fecondamente, come parte essenziale delle fondamenta di una "casa aperta" agli abbellimenti e alle ristrutturazioni, anche perché nessuna cultura inizia da una tabula rasa e «l’identità, come la musica, è una cosa bastarda, e rimane viva solo quando non è fissa ma aperta»[45]:
A
partire dalla seconda metà del XX secolo, infatti, nel mondo occidentale la
postmodernità si è connotata con il crescente venir meno della pretesa di
spiegare il mondo attraverso l’applicazione di principi unitari, come nel
recente passato avevano voluto i grandi movimenti della modernità quali
l’illuminismo, l’idealismo e il marxismo. Ciò ha implicato che la realtà si
manifestasse come differenza, molteplicità ‘irriducibile’, mutamento ‘non
ingabbiabile entro uno schema unico’, con un trend positivo atto a produrre maggiore ricchezza culturale,
laddove prima il principio unico pretendeva di costringere ogni cosa entro la
sua rigida legge, negando, a ben vedere, ogni effettiva innovazione. Bisogna
per vero riconoscere che nella nuova temperie si è connotata altresì come
fallace anche la pretesa di trovare per la morale un fondamento certo e
stabile, con l’implicazione della crisi del senso esistenziale stesso
dell’individuo, motivo per cui ciascuno perde ogni riferimento forte che poteva
determinarne con sicurezza l’identità... Nella odierna società, ‘avanzata’, ma
troppo spesso dimentica di essere comunità, senza indulgere a vacue nostalgie,
è proprio in termini di ‘dovere’ che si propone con immediatezza una nuova
‘sfida’, più ‘degna’ e forse decisiva per l’umanità intera: è in essa che si
scorge il compito non effimero di ogni uomo «deciso ad avere ancora un profondo
destino»[46].
In Italia, lo statuto, quale «carta fondamentale»[47] dell’ente locale «autonomo» e fonte del diritto costituzionalmente necessaria[48] che lascia al legislatore statale soltanto la fissazione dei ‘principi generali’[49], avrebbe potuto, in relazione alla diversità dimensionale ed organizzativa del comune, fornire un contributo decisivo, in quanto
non... più strumento
dell’autonomia amministrativa sub lege,
ma... fonte basilare della democraticità della nostra forma di Stato... Non vi
sono più alibi interpretativi per ridurre (di fatto e, tanto meno, di diritto) gli
statuti ad un passaggio amministrativo-burocratico dell’autonomia: i cittadini
e le Comunità locali dovranno prenderne assoluta consapevolezza se non vorranno
essere intaccati in ben altro che nei loro interessi di natura patrimoniale[50].
In realtà, nonostante la crisi delle strutture verticali di autorità[51], gli abusati termini di democrazia, bilancio e urbanistica partecipativi o partecipati non si sono mai concretizzati in strutture originali di governi locali protesi ad integrare le tradizionali forme rappresentative e a garantire l’adeguato esercizio di un’autonomia politico-amministrativa[52]. A dispetto dei tentativi di scardinamento del modello geometrico uniforme della l. 25 marzo 1993, n. 81 e della radicale riforma della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, con il formale superamento del principio gerarchico in luogo del principio paritario tra legge e fonti locali, il contesto dottrinale e giurisprudenziale, soprattutto della Corte Costituzionale, nega ai Comuni sia l’esistenza di un’autonomia normativa rispondente ai soli principi costituzionali, in ragione dell’unità ed indivisibilità della Repubblica, sia la piena autonomia finanziaria di spesa dovendo coesistere e soccombere ai vincoli delle politiche di bilancio[53]. In questa chiave di lettura va collocato il fallimento della l. 5 giugno 2003, n. 131, detta "La Loggia" dal nome del proponente ministro per gli affari regionali, che dando attuazione alla l. cost. 3/2001 intendeva chiarire i confini della legislazione concorrente, gli ambiti della sussidiarietà verticale, e assicurare nuove prospettive di ulteriori conferimenti in favore degli enti locali. Ancor più difficoltosa appare oggi la possibilità di risolvere le problematiche relative al ruolo degli stranieri, nella direzione di affiancare alla "cittadinanza statale" una "cittadinanza locale", «intesa come uno status che ricomprende diritti e doveri previsti dallo statuto e che viene attribuita a tutti coloro che risiedono nel territorio locale», dovendosi registrare soluzioni ad elastico condizionate dallo scatenamento di pulsioni di respingimento causate o da eventi straordinari, come quelli conseguenti a drammatici eventi di terrorismo, oppure dal disagio dei quotidiani rapporti di convivenza, specie nelle periferie urbane[54].
Il rischio che si corre è che le scelte politiche e le soluzioni giuridiche sui temi del welfare municipale, della recente riforma delle province in luogo delle "aree vaste" di secondo livello, e del superamento del bicameralismo perfetto[55], possano incagliarsi ai lacci di un federalismo rintracciabile, al momento, solo nella veste di missione ‘fiscale’, condizionato, com’è, dalle dinamiche cogenti della centralizzazione sull’argomento intricato dei costi nelle manovre governative, non apparendo all’orizzonte
un vero «progetto locale», le cui ambizioni non si tengono alla pura innovazione delle forme di democrazia interna, ma che aspirano a sottrarre il locale al suo imprigionamento nelle spire della globalizzazione – in cui non può che comportarsi da «glocale» –, trasferendo il ruolo degli enti territoriali tradizionali «dal governo dei servizi al governo dello sviluppo», collaborando ad attivare «utopie concrete» in direzione di una riappropriazione e rivitalizzazione del «territorio», secondo la vocazione particolare di ciascun «luogo»[56].
In questo ambito la storiografia giuridica ha ancora da dire molto. La comprensibile disillusione e il relativo disincanto sul tema statutario, anche se, in realtà, non sono mai mancati studi accurati nel solco di una profonda tradizione disciplinare[57], giungono alla fine di una stagione politica e giuridica che, oltre ai motivi tratteggiati, si è caratterizzata anche per la pigrizia di alcuni amministratori locali, avvezzi a seguire pedissequamente le linee guida della modulistica ministeriale, nella stesura delle normative cittadine, invece di ricercare soluzioni originali, nei limiti prefissati dall’ordinamento giuridico, tramite il confronto con il mondo accademico. Le recenti scelte politiche e normative di promozione dell’Unione dei Comuni e delle Città metropolitane[58], invece, hanno bisogno dell’autorevolezza dell’analisi comparativa sulle "aree statutarie" per il disvelamento del radicamento identitario che collega zone geograficamente ben definite, per cultura e tradizione storico-giuridica, sociale ed economica, e si impone per la difesa del territorio e, quindi, per la soluzione di conflitti identitari e ambientali.
Non è un caso, che nel 2014 i curatori dei «Quaderni Fiorentini» abbiano avvertito il bisogno di dedicare l’intero numero 43 della rivista al tema dell’«Autonomia. Unità e pluralità nel sapere giuridico fra Otto e Novecento», al fine di verificare in
che modo la parola ‘autonomia’ si è collocata nel divenire del linguaggio giuridico dei secoli XIX e XX? Quale ruolo ha giocato nel discorso dei giuristi? Com’è stata riscoperta, utilizzata, trasformata, levigata, dal sapere giuridico per rappresentare l’ordine, il rapporto fra le parti e il tutto, tra pluralità e unità?... Più che l’indefinibilità dell’etimo, a conferire polisemia a ‘autonomia’ è la sua disponibilità a rinascere e ad assumere funzioni diverse, a ˗ si può dire con Michel Foucault ˗ moltiplicarsi e disperdersi: ora si piega docile entro una gerarchia, graduata e subordinata a un’unità vincolante, a un sistema di regole e confini; ora invece si sottrae a degradazioni e subordinazioni, rifiutando perfino un riconoscimento proveniente dall’estero… Non s’intende, dunque, ricercare l’originaria purezza della parola per verificare se, e come, è stata falsata e tradita, ma seguirne l’esistenza nel sapere dei giuristi, nel modo di fissare nessi tra unità e pluralità, e nel farsi delle pratiche istituzionali nei diversi momenti storici [59].
In attesa dell’esplicazione del programma di riforme avviato da alcuni decenni in Italia, troppo spesso ondivago sui temi del federalismo fiscale, demaniale, municipale, regionale[60], e della verifica dell’effettivo grado di incisività nel supportare le attese trasformazioni strutturali, appare proficuo concludere con le considerazioni espresse nel 1945 dallo storico e federalista, Gaetano Salvemini:
Da quel tanto che arriva qui in America di quanto si pubblica oggi in Italia, ho l’impressione che ben pochi in Italia si interessino di questa materia [federalismo]. Tutti si dicono rivoluzionari e tutti sono conservatori. Tutti dicono male del governo, come tutti ne dicevano male anche quando si stava meglio e quando si stava peggio. Ma invece di domandare al «governo», cioè ai padreterni di Roma, che non si occupi di affari che non lo riguardano, tutti domandano qualcosa al governo. Naturalmente il governo dà quel che solamente può dare: moneta cartacea che aggrava l’inflazione, e burocrati che contribuiscono alla inflazione coi loro stipendi e per giunta paralizzano le iniziative private usurpando per sé funzioni che dovrebbero essere lasciate ai privati. Si grida contro la burocrazia e nello stesso tempo si accettano, anzi si domandano, governatori al di sopra dei prefetti, cioè nuove ruote burocratiche, per la Sicilia e la Sardegna, come se un superprefetto possa dare alla Sardegna e alla Sicilia quel che egli stesso non ha. È la storia delle quattro guardie che guardan le due guardie che guardan la guardia che guarda la figlia del re[61].
3. Riferimenti
ALBINI, G. (cur.). Bibliografia statutaria italiana: 1985-1995, vol. I. Biblioteca del Senato della Repubblica. Roma: Centro di Studi sulla Civiltà del tardo Medioevo di San Miniato, Comitato per gli Studi e le Edizioni delle Fonti normative, 1998.
ALIANELLI, N. Delle antiche consuetudini e leggi marittime delle provincie napoletane. Napoli: De Angelis, 1871.
ALIANELLI, N. Delle consuetudini e degli statuti municipali delle provincie napoletane. Napoli: Rocco, 1873.
ALLEGRETTI, U. La pubblica amministrazione e il sistema delle autonomie. In: FIORAVANTI, M. (cur.). Il valore della Costituzione. L’esperienza della democrazia repubblicana. Roma-Bari: Laterza 2009.
AMATUCCI, F., SAN LUCA, G. Clemente di. (curr.). I principi costituzionali e comunitari del federalismo fiscale. Torino: Giappichelli, 2008.
ANGIOLINI, E. (cur.). Bibliografia statutaria italiana: 1996-2005. vol. II. Biblioteca del Senato della Repubblica. Roma: Comitato per gli Studi e le Edizioni delle Fonti normative, 2009.
ANNICHINI, A. Legnani. Il paradigma della giustizia locale in una terra emiliana: gli statuti di San Felice sul Panaro del 1464. In: Historia et ius [www.historiaetius.eu], 2, 2012.
ANTONINI, L. (cur.). Verso un nuovo federalismo fiscale. Milano: Giuffrè, 2005.
ASCHERI, M. Agli albori della primavera statutaria. In: CONTE, E., MIGLIO, M. (curr.), Il diritto per la storia: gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica. Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2010.
ASCHERI, M. Famiglia, potere e legislazione nelle città-Stato ‘popolari’ (secc. XIII.-XIV). In: PAGLIANTINI, S., QUADRI, E., SINESIO, D. (curr.). Scritti in onore di Marco Comporti. vol. I. Milano: Giuffrè, 2008.
ASCHERI, M. Introduzione. Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia. In: BULGARELLI, G. Pierangeli-S. (cur.). Biblioteca del Senato della Repubblica, Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII. VII: S. Firenze: La Nuova Italia, 1990.
ASCHERI, M. La pace negli statuti dei Comuni toscani: una introduzione. In: COLLI, V., CONTE, E. (curr.). Iuris Historia. Liber Amicorum Gero Dolezalek. Berkeley: Robbins Collection, 2008,
ASCHERI, M. Le città-Stato. Bologna: Il Mulino, 2006.
ASCHERI, M. Législation et coutumes dans les villes italiennes et leur ‘contado’ (XIIe-XIVe siècles). In: MOUSNIER, M., POUMARÈDE, J. (cur.). La coutume au village dans l’Europe médiévale et modern. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 2001.
ASCHERI, M. Législation italienne du bas moyen âge: le cas de Sienne (ca. 1200-1545). In: BOUSMAR, J.-M. Cauchies-E. (cur.). Faire bans, edictz et statuz: légiférer dans la ville médiévale. Sources, objects et acteurs de l'activité législative communale en Occident, ca. 1200-1550. Actes du colloque international (Bruxelles, 17-20 novembre 1999). Bruxelles: Publications des Facultés universitaires Saint-Luis, 2001.
ASCHERI, M. Lo straniero nella legislazione e nella letteratura giuridica del Tre-Quattrocento: un primo approccio. In: Rivista di Storia del diritto italiano. 60. S.l.: s.n., 1987.
ASCHERI, M. Lo straniero: aspetti della problematica giuridica. In: ROSSETTI, G. (cur.). Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell’Europa dei secoli XII-XVI. Napoli: Liguori, 1999.
ASCHERI, M. Siena e la città-stato del Medioevo italiano. Siena: Betti, 2003.
ASCHERI, M. Siena nel 1310: «la giustitia s’offende et la verità si cela. Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [Online], 126-2|2014. Messo online il 06 agosto 2014, consultato il 26 gennaio 2015. URL: http://mefrm.revues.org/2122.
ASCHERI, M. Statuti e consuetudini tra storia e storiografia. In: DONDARINI, G.M.; VARANINI, M.Venticelli (cur.). Signori regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo. VII Convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000). Bologna: Pàtron, 2003.
ASCHERI, M. Statutory Law of Italian Cities from Middle Ages to Early Modern. In: DROSSBACH, G. (cur.). Von der Ordnung zur Norm: Statuten in Mittelalter und Früher Neuzeit. Paderborn: F. Schöningh, 2010.
ASCHERI, M. Un’altra cittadinanza: nei privilegi e nella fedeltà pre-comunali. In: PRODI, P. (cur.). La fiducia secondo i linguaggi del potere. Bologna: Il Mulino, 2007
ASCHERI, M., DANI, A. La mezzadria nelle terre di Siena e Grosseto: dal medioevo all’età contemporanea. Siena: Pascal, 2011.
BAMBI, F. Alle origini del volgare del diritto. La lingua degli statuti di Toscana tra XII e XIV secolo. Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [Online], 126-2|2014, Messo online il 06 agosto 2014, consultato il 26 gennaio 2015. URL: http://mefrm.revues.org/2112.
BIANCIARDI, P., OTTAVIANI, M.G. Nico. (cur.). Repertorio degli statuti comunali umbri. Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1992.
BIROCCHI, I., CORTESE, E., MATTONE, A., MILETTI, M.N. Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII – XX secolo). Vol II. Bologna : Il Mulino, 2013.
BORDIGNON, M. (cur.). Federalismo fiscale. Proposta per un modello italiano, Milano: F. Angeli, 1996.
BRACCIA, R. Diritto della città diritto del contado. Autonomie politiche e autonomie normative di un distretto cittadino. Milano: Giuffrè, 2004
BRACCIA, R. Processi imitativi e circolazione dei testi statutari: il ponente ligure. In: Studi in onore di Franca De Marini Avonzo. Torino, Giappichelli, 1999.
BUCHANAN, A. Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi, presentazione di G. Miglio, A. Milano: Mondadori, 1994.
BUSSOLETTI, A. Autonomia e federalismo tra diritto e scienza politica: il pensiero di Gianfranco Miglio. In: Quaderni Fiorentini. vol. I 43. Firenze: s.n., 2014.
CALASSO, F. La città nell’Italia meridionale dal sec. IX al XI [1959]. In: Annali di storia del diritto, 9. S.l: s.n., 1965.
CALASSO, F. Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale. Milano: Giuffrè, 1949.
CALASSO, F. La «dottrina degli statuti» per l’Italia meridionale [1928]. In: Annali di storia del diritto, 9. S.l.: s.n., 1965.
CALASSO, F. La città nell’Italia meridionale durante l’età normanna [1959], in Annali di storia del diritto, 9. S.l.: s.n., 1965.
CALASSO, F. La legislazione statutaria dell’Italia meridionale, parte prima. Roma: Signorelli, 1929.
CARABELLESE, F. Il Comune pugliese durante la monarchia normanno-sveva. Bari: Vecchi, 1924.
CARABELLESE, F. L’Apulia e il suo Comune nell’alto Medio Evo. Bari: Vecchi, 1905.
CARAVALE, M. La legislazione statutaria dell’Italia meridionale e della Sicilia. In: CARAVALE, M. La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni. Roma-Bari: s.n, 1998.
CARAVALE, M. Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale. Bologna: Il Mulino, 1994.
CASANA, P. Gli statuti di Vernante e il diritto locale della Contea di Tenda, Società per gli studi Storici. Cuneo: Archeologici ed Artistici della provincia di Cuneo, 2000.
CASSANDRO, G. Il Comune meridionale nell’età aragonese. In: CASSANDRO, G. Lex cum moribus. Saggi di metodo e di Storia giuridica meridionale, pref. di M. Caravale, pres. di A. Campitelli, vol. I. Bari: Cacucci, 1994.
CASSESE, S. La crisi dello Stato. Roma-Bari: Laterza, 2002.
CASSESE, S. Lo spazio giuridico globale. Roma-Bari: Laterza, 2003.
CASSESE, S. Lo Stato introvabile. Modernità e arretratezza delle istituzioni italiane. Roma: Donzelli, 1998.
CASSESE, S., CONTICELLI, M. (curr.), Diritto e amministrazioni nello spazio giuridico globale. Milano: Giuffrè, 2006.
CASSI, A. (cur.). Ai margini della civitas: figure giuridiche dell’altro fra Medioevo e futuro. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2013.
CAZZETTA, G. Pagina introduttiva. Autonomia: per un’archeologia del sapere giuridico fra Otto e Novecento. In: Quaderni Fiorentini, 43, vol I, 2014.
CERNIGLIARO, A. Civitas et insula de Yscla. Un centro marinaro tra Aragonesi e Asburgo. In: Studi Veneziani, 52. S.l.: s.n., 2006.
CERNIGLIARO, A. Dall’età dei diritti all’età dei doveri: la dissoluzione della soggettività nelle ragioni complessive dell’umanità. In: LORUSSO, S. (cur.). Costituzione e ordinamento giuridico. Convegno per il decennale della Facoltà di Giurisprudenza (Foggia, 24-25 novembre 2006). Milano: Giuffrè, 2009.
CHECCHINI, A. Pressupposti giuridici dell’evoluzione storica dalla «bartoliana» teoria degli statuti al moderno diritto internazionale. In: SEGOLONI, D. (cur.), Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario, vol. II. Milano: Giuffrè, 1962.
CHIEFFI, L. (cur.). Regioni e dinamiche di integrazione europea. Torino: Giappichelli, 2003.
CHIODI, G. Tra la civitas e il comitatus: i suburbi nella dottrina di diritto comune. In: GALLINA, M. Antico. (cur.). Dal suburbium al faubourg: evoluzione di una realtà urbana. Milano: Edizioni Et, 2000.
CHITTOLINI, G. Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI). Milano: Unicopli, 1996.
CHITTOLINI, G., JOHANEK, P. (curr.), Aspetti e componenti dell’identità urbana in Italia e in Germania (secoli XIV-XVI). Bologna: il Mulino, 2003.
CIARLO, P., PITRUZZELLA, G. Monocameralismo: unificare le due camere in un unico Parlamento della Repubblica. In: Il Piemonte delle Autonomie. n. 1. S.l.: s.n., 2014.
COMINI, I., MOI, F. Le città metropolitane nella riforma “Delrio”. In: Il Piemonte delle Autonomie, 1, 2014.
CORRAO, P. Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo. Note sul caso siciliano. In: CHITTOLINI, G., MOLHO, A., SCHIERA, P. (curr.), Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna. Convegno storico (University of Chicago, 26-29 aprile 1993). Bologna: il Mulino, 1994.
CORRAO, P. Città e normativa cittadina nell’Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema storiografico da riformulare. In: DONDARINI, R. (cur.). La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del Medioevo, Atti del Convegno (Cento, 6-7 maggio 1993). Cento: Deputazione provinciale ferrarese di storia patria, 1995.
CORRAO, P. La difficile identità delle città siciliane. In: CHITTOLINI, G., JOHANEK, P. (curr.), Aspetti e componenti dell’identità urbana in Italia e in Germania (secoli XIV-XVI). Bologna: il Mulino, 2003.
COSTA, Pietro. Civitas, respublica, corpus. Immagini dell’ordine e dell’appartenenza fra ‘antico’ e ‘moderno’. In: CARILLO, G. (cur.). Unità e disunione della polis. Avellino: Elio Sellino, 2007.
COSTA, Pietro. Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 1. Dalla civiltà comunale al Settecento. Roma-Bari : Laterza, 1999.
COSTA, Pietro. Così lontano, così vicino: il Comune medievale e la sua 'autonomia'. In: Quaderni Fiorentini, 43, vol II, 2014.
DANI, A. Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa, secoli XVI-XVIII. Bologna: Monduzzi, 2006.
DANI, A. Le risorse naturali come beni comuni. Arcidosso: Effigi, 2013.
DANI, A. Il concetto giuridico di “beni comuni” tra passato e presente. In: Historia et ius [www.historiaetius.eu], 6, 2014.
DANI, A. Usi civici nello Stato di Siena di età medicea., Bologna: pref. di D. Quaglioni, Monduzzi, 2003.
DANI, A., RONDONI, A. (curr.). Chianciano e i suoi statuti in età moderna: una comunità federata dello Stato di Siena, introduzione di M. Ascheri. Monteriggioni: Il Leccio, 2014.
DE CHIARA, A. La funzione normativa della Regione e degli enti locali. In: SAN LUCA, G. Clemente di. (cur.). Comuni e funzione amministrativa. Torino: Giappichelli, 2007.
DE MARTIN, G.C. Il processo di riassetto dei ruoli istituzionali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In: SALA, G. Sui caratteri dell’amministrazione comunale e provinciale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Studi in onore di Giorgio Berti. vol. II. Napoli: Jovene, 2005.
DE PASQUALE, P. Il principio di sussidiarietà nell’ordinamento comunitario. Napoli: Editoriale Scientifica, 1996.
DELILLE, G. Governo locale e identità urbana: il caso italiano in una prospettiva europea. In: CHACÓN, F., VISCEGLIA, M.A., MURGIA, G., TORE, G. (curr.). Spagna e Italia in Età moderna: storiografie a confronto. Primo Incontro Internazionale. Identità mediterranee: Spagna e Italia in una prospettiva comparativa (secoli XVI-XVIII). Roma: Viella, 2009.
DI FOLCO, M. La garanzia costituzionale del potere normativo locale. Statuti e regolamenti locali nel sistema delle fonti tra tradizione e innovazione costituzionale. Padova: Cedam, 2007.
DI GENIO, G. Ordinamento europeo e fonti di autonomia locale. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2000.
DOGLIANI, M. Appunto sulla possibile riforma del Senato: una seconda Camera, non una Camera secondaria. In: Il Piemonte delle Autonomie. N. 1. S.l.: s.n., 2014.
EDIGATI, D., TANZINI, L. Ad statutum florentinum. Esegesi statutaria e cultura giuridica nella Toscana medievale e moderna. Pisa: Ets, 2009.
FARAGLIA, N.F. Il comune nell’Italia meridionale (1110-1806). Napoli: Tip. della Regia Università, 1883.
FERRARESE, M.R. La governance tra politica e diritto. Bologna: il Mulino, 2010.
FERRARESE, M.R. Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale. Bologna: il Mulino, 2000.
FERRARI, G.F. (cur). Federalismo, sistema fiscale, autonomie. Modelli giuridici comparati. Roma: Donzelli, 2010.
FIORAVANTI, M. Costituzionalismo dei beni comuni. In: Storica, 19, 2013.
FIORAVANTI, M. Diritto alla città e azione popolare, (a proposito di Paolo Maddalena, Il territorio bene comune degli Italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico, Introduzione di Salvatore Settis, Roma, Donzelli, 2014). In: Historia et ius [www.historiaetius.eu], 5, 2014.
FIORILLO, F., ROBOTTI, L. (curr.). Dall’unione alla fusione dei comuni. Rimini: Maggioli, 2012.
FIORILLO, F., ROBOTTI, L. (curr.). L’unione dei comuni. Teoria economica ed esperienze concrete. Milano: F. Angeli, 2006.
GALASSO, G. Dal comune medievale all’unità. Linee di storia meridionale. Bari: Laterza, 1969.
GALASSO, G. Sovrani e città nel Mezzogiorno tardo-medievale. In: GENSINI, S. (cur.). Principi e città alla fine del Medioevo. Pisa: Pacini, 1996.
GALASSO, G. (cur.). Alle origini del dualismo italiano. Regno di Sicilia e Italia centro-settentrionale dagli Altavilla agli Angiò (1100-1350). Atti del Convegno internazionale di studi (Ariano Irpino, 12-14 settembre 2011). Soveria Mannelli: Rubbettino, 2014.
GALASSO, G. Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494). In: GALASSO, G. (cur.), Storia d’Italia. vol. XV/1. Torino: s.n., 1992.
GAMBA, C. Comunità e statuti della provincia romana. Roma: Aracne, 2012.
GAMBINO, S Regioni e autonomie locali nella riforma del Titolo V della Costituzione. In: Scritti in memoria di Livio Paladin, vol. II. Napoli: Jovene, 2004.
GAMBINO, S. (cur.). Il federalismo fiscale in Europa. Milano: Giuffrè, 2014.
GAUDIOSO, M. Natura giuridica delle autonomie cittadine nel “Regnum Siciliae”. Catania: Casa del libro, 1952.
GIARDA, P. La favola del federalismo fiscale. Milano: Università cattolica del Sacro Cuore, 2009.
GIARDA, P. Regioni e federalismo fiscale. Bologna: il Mulino, 1995.
GROPPI, T., OLIVETTI, M. (curr.). La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V. Torino: Giappichelli, 2003.
Grossi, P. Globalizzazione, diritto, scienza giuridica. In: Il Foro Italiano. 127. S.l.: s.n., 2002.
GROSSI, Paolo. L’ordine giuridico medievale. Roma-Bari: Laterza, 1997.
GUARINI, E. Fasano. Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna? In: CHITTOLINI, G., MOLHO, A., SCHIERA, P. (curr.), Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna. Convegno storico (University of Chicago, 26-29 aprile 1993). Bologna: il Mulino, 1994.
JANZ, O., SCHIERA P., SIEGRIST, H. (curr.). Centralismo e federalismo tra Ottocento e Novecento. Italia e Germania a confronto. Bologna: il Mulino, 1997.
LEO, P. De (cur.). Il Mezzogiorno medievale nella storiografia del secondo dopoguerra: risultati e prospettive. Atti del IV Convegno nazionale dell’Associazione dei medievisti italiani (Università di Calabria, 12-16 giugno 1982). Soveria Mannelli: Rubbettino, 1985.
LUTHER, J. Il bicameralismo si supera se si reinventa (ma anche se si rottama). In: Il Piemonte delle Autonomie. N. 1. S.l.: s.n., 2014.
MANNORI, L. ‘Autonomia’ Fortuna di un lemma nel vocabolario delle libertà locali tra Francia ed Italia. In: Quaderni Fiorentini, 43, vol. I, 2014.
MANNORI, L. Autonomia. Tracciato di un lemma nel vocabolario amministrativo italiano dal Settecento alla Costituente. L’affermazione dell’autonomia-Federalismo, Unità, Regioni. Atti del convegno (Torino, 13 maggio 2011). In: Il Piemonte delle Autonomie, 1, 2014.
MANNORI, L. Dall’autonomia all’autoamministrazione: legicentrismo e comunità locali tra Sette e Ottocento, in Diritto generale e diritti particolari nell’esperienza storica. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998). Roma: Fondazione Sergio Mochi Onory, 2001.
MANNORI, L. Il «piccolo Stato» nel «grande Stato». Archetipi classici e processi di territorializzazione nell’Italia tardo medievale e proto moderna. In: GABBA, E., SCHIAVONE, A. (curr.). Polis e piccolo Stato tra riflessione antica e pensiero moderno. Atti delle Giornate di studio (Firenze, 21-22 febbraio 1997). Como: New press, 1999.
MARCHETTI, P. De iure finium: Diritto e confini tra tardo medioevo ed età moderna. Milano: Giuffrè, 2001.
MARENGHI, E.M. Lo statuto comunale: l’altro modo di essere dell’autonomia. In: SALA, G. Sui caratteri dell’amministrazione comunale e provinciale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Studi in onore di Giorgio Berti. vol. II. Napoli: Jovene, 2005.
MARINO, I. M. Sulla funzione statutaria e regolamentare degli enti locali, in Id., Aspetti della recente evoluzione del diritto degli enti locali. Palermo: Quattrosoli, 2002.
MAZZANTI, G. Rileggendo gli Statuti di Gemona nel Friuli. In: Historia et ius [www.historiaetius.eu], 1, 2012.
MECCARELLI, M.. Statuti, «potestas statuendi» e «arbitrium»: la tipicità cittadina nel sistema giuridico medievale. In: MENESTÒ, E. (cur.). Gli statuti delle città: l’esempio di Ascoli nel secolo XIV. Atti del Convegno di studio (Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998). Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1999.
MENESTÒ, E. (cur.). Gli statuti comunali umbri. Atti del Convegno di Studi svoltosi in occasione del VII centenario della promulgazione dello Statuto comunale di Spoleto (Spoleto 8-9 novembre 1996). Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1997.
MIGLIO, G. Federalismo e secessione. Un dialogo (con A. Barbera). Milano: Mondadori, 1997.
MIGLIO, G. Per un’Italia federale. Milano: Il Sole 24 ore, 1990.
MILETTI, M.N. Ermeneutica del Ius Municipale nella giurisprudenza napoletana d’età moderna. In : STORTI, C. (cur.). Il ragionamento analogico. Profili storico-giuridici. Napoli : Jovene, 2010.
MILETTI, M.N. Peregrini in patria. Percezioni del ius regni nella giurisprudenza napoletana d’eta moderna. In I. BIROCCHI, I., MATTONE, A. (curr.). Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX). Atti del convegno internazionale (Alghero, 4-6 novembre 2004). Roma: Viella, 2006.
MONACO, F. Roversi (cur.). Sussidiarietà e Pubbliche Amministrazioni. Atti del Convegno (Bologna, 25-26 settembre 1995). Rimini: Maggioli, 1997.
MONTORZI, M. Giustizia in contado. Studi sull’esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna. Pisa: Edifir, 1997.
MUSI, A. (cur.). Le città del Mezzogiorno nell’Età moderna. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2000.
MUSI, A. Il Regno di Napoli dagli Spagnoli all’Unità. In: MUSI, A., VITOLO, G. (curr.). Il Mezzogiorno prima della questione meridionale. Firenze: Le Monnier, 2004.
OLIVETTI, M. L’autonomia statutaria tra omogeneità e differenziazione. L’affermazione dell’autonomia-Federalismo, Unità, Regioni. Atti del convegno (Torino, 13 maggio 2011). In: Il Piemonte delle Autonomie, 1, 2014.
OLIVETTI, M. Lo Stato policentrico delle autonomie (art. 114, 1° comma). In: GROPPI, T., OLIVETTI, M. (curr.). La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V. Torino: Giappichelli, 2003.
PAOLA, I. Pluricittadinanza, cittadinanza amministrativa e partecipazione all’attività dell’amministrazione. In: MANGANARO, F., TASSONE, A. Romano. (curr.), Persona ed amministrazione. Privato, cittadino, utente e pubbliche amministrazioni. Torino: Giappichelli, 2004.
PASCIUTA, B. Due falsi privilegi fredericiani su Corleone: la normativa cittadina e il paradigma della falsificazione. In: Annali del Seminario giuridico dell’Università di Palermo. 48. n. 2. Palermo: Università di Palermo, 2003.
PASTORI, G. Le autonomie territoriali nell’ordinamento republicano. L’affermazione dell’autonomia-Federalismo, Unità, Regioni. Atti del convegno (Torino, 13 maggio 2011). In: Il Piemonte delle Autonomie, 1, 2014.
PEZZANI, F., PREITE, D. L’attuazione del federalismo fiscale: quale autonomia finanziaria? Milano: Egea, 2011.
PICA, F. Del federalismo fiscale in Italia. Scritti sul tema dal 1994 al 2003. Napoli: Grimaldi, 2004.
PIERGIOVANNI, V. Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine. In BULGARELLI, S. (cur.). Biblioteca del Senato della Repubblica, Gli statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI. Catalogo della mostra (8 novembre 1995-8 gennaio 1996). Roma: De Luca, 1995.
PIERGIOVANNI, V. Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali. In MENESTÒ, E. (cur.). Gli statuti delle città: l’esempio di Ascoli nel secolo XIV. Atti del Convegno di studio (Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998). Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1999.
PINI, A.I. Dal comune città-stato al comune ente amministrativo. In: PINI, A.I. Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano. Bologna: Clueb, 1986.
PINTO, G. Ricordo di Antonio Ivan Pini. In: Bullettino storico pistoiese. CV. S.l.: s.n., 2003.
PIOGGIA, A., VANDELLI, L. (curr.). La repubblica delle autonomie nella giurisprudenza costituzionale: regioni ed enti locali dopo la riforma del titolo V. Bologna: il Mulino, 2006.
POGGI, A. Introduzione. In: Il Piemonte delle Autonomie. n. 1, 2014.
QUAGLIONI, D. Le radici teoriche della dottrina bartoliana della cittadinanza. In: QUAGLIONI, D. ‘Civilis sapientia’. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno. Rimini: Maggioli, 1989.
QUAGLIONI, D. Legislazione statutaria e dottrina degli statuti nell’esperienza politica tardomedievale. In: Statuti e ricerca storica. Atti del Convegno (Ferentino, 11-13 marzo 1988). Ferentino: Comune di Ferentino, 1991.
QUAGLIONI, D. Un bilancio storiografico. In DONDARINI, R.; VARANINI, G.M.; VENTICELLI, M. (cur.). Signori regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo. VII Convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000). Bologna: Pàtron, 2003.
RINELLA, A., COEN, L., SCARCIGLIA, R. Sussidarietà e ordinamenti costituzionali. Esperienze a confronto. Padova: Cedam, 1999.
RIZZONI, G. La riforma del sistema delle autonomie nella XIII legislatura. In: GROPPI, T., OLIVETTI, M. (curr.). La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V. Torino: Giappichelli, 2003.
ROLLA, G. L’autonomia dei comuni e delle province. In: GROPPI, T., OLIVETTI, M. (curr.). La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V. Torino: Giappichelli, 2003.
ROMANELLI, R. Centralismo e autonomie. In: ROMANELLI, R. (cur.). Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi. Roma: Donzelli, 1995.
ROMANO, A. Definizione e codificazione dello ius commune siculum. In: BIROCCHI, I., MATTONE, A. (curr.). Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX). Atti del convegno internazionale (Alghero, 4-6 novembre 2004). Roma: Viella, 2006.
ROMANO, A. Consuetudini, statuti e privilegi cittadini nella realtà giuridico-istituzionale del Regno di Sicilia. In: DÖLEMEYER, B. (cur.). Das Privileg im europäischen Vergleich. vol. 2. Frankfurt am Main: Heinz Mohnhaupt, 1999.
ROSBOCH, M. Invalidità e statuti medievali: Pisa, Bologna, Milano, Ivrea. Roma: Fondazione Sergio Mochi Onory per la Storia del diritto italiano, 2003.
RUFFINI, E.M. Federalismo fiscale: la grande illusione. Milano: pref. di V. Visco, Novecento media, 2010.
SALA, G. Sui caratteri dell’amministrazione comunale e provinciale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Studi in onore di Giorgio Berti. vol. III. Napoli: Jovene, 2005.
SALVEMINI, G. Federalismo, regionalismo, autonomismo. In: SALVEMINI, G. Scritti sulla questione meridionale (1896-1955). Torino: Einaudi, 1955.
SAN LUCA, G. Clemente di. Introduzione. Titolarità ed esercizio della funzione amministrativa nel nuovo assetto del sistema autonomistico locale. In: SAN LUCA, G. Clemente di. (cur.). Comuni e funzione amministrativa. Torino: Giappichelli, 2007.
SANTARELLI, U. La normativa statutaria nel quadro dell’esperienza giuridica bassomedievale. In: Diritto generale e diritti particolari nell’esperienza storica. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998). Roma: Fondazione Sergio Mochi Onory, 2001.
SANTARELLI, U. Lo statuto «redivivo». In Archivio storico italiano. 151. S.l.: s.n., 1993.
SAVELLI, R. Gli statuti della Liguria. Problemi e prospettive di ricerca. In: Società e Storia, 21. S.l.: s.n, 1999.
SAVELLI, R. Scrivere lo statuto amministrare la giustizia organizzare il territorio. In: SAVELLI, R. (cur.). Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII- XVIII). Genova: Società ligure di Storia Patria, 2003.
SBRICCOLI, M. Legislation, Justice and Political Power in Italian Cities, 1200-1400. In: SCHIOPPA, A. Padoa (cur.). Legislation and Justice. Oxford: Clarendon press, 1997.
SBRICCOLI, M. Conclusioni. In: MENESTÒ, E. (cur.). Gli statuti delle città: l’esempio di Ascoli nel secolo XIV. Atti del Convegno di studio (Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998). Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1999.
SBRICCOLI, M. L’interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell’età comunale. Milano: Giuffrè, 1969.
SENATORE, F. Gli archivi delle universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali. In LANGELI, A. B., GIORGI, A., MOSCADELLI, S. (curr.). Archivi e comunità tra Medioevo ed Età Moderna. Siena: Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2009.
SERGI, G. La comparazione che cambia: le riletture comunali del Settentrione in una prospettiva italiana. In: SAITTA, B. (cur.). Città e vita cittadina nei paesi dell’area mediterranea. Secoli XI-XV. Atti del Convegno Internazionale in onore di Salvatore Tramontana (Adrano-Bronte-Catania-Palermo, 18-22 novembre 2003). Roma: Viella, 2006.
SIANO, A. De. La funzione amministrativa degli enti locali. Attuazione del principio di sussidiarietà e adeguatezza delle risorse finanziarie allo svolgimento dei compiti. In: SAN LUCA, G. Clemente di. (cur.). Comuni e funzione amministrativa. Torino: Giappichelli, 2007.
SORDI, B. Selfgovernment, Selbstverwaltung, autarchia: fondali inglesi per scenografie continentali. In: Quaderni Fiorentini, 43, vol I, 2014.
STADERINI, F. Diritto degli enti locali,. Padova: Cedam, 2006.
STANCO, G. Gli statuti di Ariano. Diritto municipale e identità urbana tra Campania e Puglia. Ariano Irpino: Centro Europeo di Studi Normanni, 2012.
STANCO, G. Le prospettive del policentrismo in Italia ‒ Radici e costruzioni identitarie tra storiografia e dottrina giuridica. In: A&C - Revista de Direito Administrativo & Constitucional, n. 49, 2012.
STORCHI, C. Storti. Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all’età preunitaria. Aspetti civilistici. Milano: Giuffrè, 1990.
STORCHI, C. Storti. Scritti sugli statuti lombardi. Milano: Giuffrè, 2007.
STORTI, C. Gli statuti tra autonomie e centralizzazioni nel medioevo. In: CONTE, E., MIGLIO, M. (curr.), Il diritto per la storia: gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica. Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2010.
TOCCI, G. Le comunità in età moderna: problemi storiografici e prospettive di ricerca. Roma: Carocci, 1997.
TREMONTI, G., VITALETTI, G. Il federalismo fiscale. Autonomia municipale e solidarietà sociale. Roma-Bari: Laterza, 1994.
TREPPO, M. Del. Medioevo e Mezzogiorno: appunti per un bilancio storiografico, proposte per un’interpretazione. In: Rossetti, G. (cur.). Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo. Bologna: il Mulino, 1977.
TREPPO, M. Del. Stranieri nel regno di Napoli. Le élites finanziarie e la strutturazione dello spazio economico e politico. In: ROSSETTI, G. (cur.). Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell’Europa dei secoli XII-XVI. Napoli: Liguori, 1999.
UNGARI, P. (cur.). Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio. Repertorio (secc. XII-XIX). Roma: Cervati, 1993.
URICCHIO, A. (cur.). I percorsi del federalismo fiscale. Bari: Cacucci, 2012.
VALLONE, G. Riflessioni sull’ordinamento cittadino del Mezzogiorno continentale. In Rivista internazionale di diritto comune, 2. S.l.: s.n., 1991.
VARANINI, G.M. (cur.). Storiografia e identità dei centri minori italiani tra la fine del Medioevo e l’Ottocento. Atti del XIII Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo (San Miniato, 24-26 settembre 2010). Firenze : Firenze University Press, 2013.
VARANINI, G.M.. Comuni cittadini e stato regionale: ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento. Verona: Libreria editrice universitaria, 1992.
VASINA, A. (cur.). Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI). Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1997-1999.
VENTURA, P. Il linguaggio della cittadinanza a Napoli tra ritualità civica, amministrazione e pratica politica (secoli XV-XVII). In BALBI, G. Petti, Vitolo, G. (curr.). Linguaggi e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed Età moderna. Salerno: Laveglia, 2007.
VIDARI, G.S. Pene. Aspetti storico-giuridici. In: SPINA, L. (cur.). L’Alpe e la Terra. I bandi campestri biellesi nei secoli XVI-XIX. Biella: Rosso, 1997.
VIDARI, G.S. Pene. Censimento ed edizione degli statuti con particolare riferimento al Piemonte. In: Dal dedalo statutario. Atti dell’incontro di studio dedicato agli statuti. Ascona: Centro Seminariale Monte Verità, 1993.
VIDARI, G.S. Pene. Consuetudini di Alessandria e «ius statuendi». In: Rivista di Storia del diritto italiano. 61. S.l.: s.n., 1988.
VIDARI, G.S. Pene. Introduzione. Atteggiamenti della storiografia giuridica italiana. In BULGARELLI, S.; CASAMASSIMA, A.; PIERANGELI, G.(cur.), Biblioteca del Senato della Repubblica, Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII. VIII: T-U. Firenze: Nuova Italia, 1999.
VIDARI, G.S. Pene. Un ritorno di fiamma: l’edizione degli statuti comunali. In Studi piemontesi. n. 25. S.l: s.n., 1996.
VILLANI, V. (cur.). Istituzioni e statuti comunali nella Marca d’Ancona: dalle origini alla maturità (secoli XI-XIV). Ancona: Deputazione di Storia Patria per le Marche, 2005-2007.
VIOLINI, L. Le prospettive di riforma del bicameralismo italiano. In: Il Piemonte delle Autonomie. N. 1. S.l.: s.n., 2014.
VITOLO, G. Tra Napoli e Salerno. La costruzione dell’identità cittadina nel Mezzogiorno medievale. Salerno: Carlone, 2001.
VITOLO,G. (cur.), Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna. Salerno: Laveglia, 2005.
Nota
[1] Cfr.:
artt. 2, co. 4, e 4, l. 8 giugno 1990, n. 142; l. 25 marzo 1993, n. 81; art. 1,
l. 3 agosto 1999, n. 265; artt. 3, 6-7, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3;
art. 114, co. 2, art. 117, co. 6, e art. 119, co. 1, Cost. Cfr., infine, l’art. 4, l. 5 giugno 2003, n. 131: «1. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi
fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà
statutaria e in quella regolamentare. 2. Lo statuto, in armonia con la
Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica,
nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione
dell’articolo 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento
dell’ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle
minoranze e le forme di partecipazione popolare. 3. L’organizzazione degli enti
locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie. 4.
La disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle
funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata
alla potestà regolamentare dell’ente locale, nell’ambito della legislazione
dello Stato o della regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità,
secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli
articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione. 5. Il potere
normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane o
isolane. 6. Fino all’adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano
le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal
presente articolo».
[2] «"chi fa storia della città dà a vedere, e spesso
in modo assai esplicito" di fare "qualcosa di diverso dalla storia delle
comunità, e ciò discende dal punto di vista prescelto, che è, o è sentito come,
ideologicamente privilegiato"; la città, in quanto centro urbano di rilievo e
di solito sede di organismi politico-amministrativi tendenzialmente decisionali
o comunque di governo per e su il territorio, resta punto di
irradiazione di poteri verso le
comunità e di riferimento per le comunità; ossia luogo di elaborazione di
politiche e di scelte che, per il loro peso, potrebbero determinare in modo
inequivocabile i caratteri complessivi di una struttura statuale articolata in
un reticolo di interdipendenze di cui città, comunità, territori costituiscono
gli elementi portanti. "Il rinvio ad una accezione anch’essa ideologicamente
privilegiata (ma in realtà solo fuorviante) dello stato è evidente, e mentre
per l’età di mezzo i rischi sono ridotti al minimo da quell’oggetto specifico
di riflessione che è la città-stato, per l’età moderna le complicazioni paiono
accrescersi"... Le comunità, altre dalla città, "sono tali perché ‘minori’ o
‘periferiche’ o ‘rurali’ o ‘di valle’ o ‘di montagna’ o di ‘confine’, ecc."...
In sintesi, nello studio delle comunità si istituisce una molteplicità di
rapporti tra spazi e tempi, che sono fisici, politici, giurisdizionali,
economici, culturali, e che nella loro sequenza finiscono per confluire ma
senza dissolversi, in quella struttura complessiva, ma niente affatto omogenea,
che è lo stato di antico regime» (TOCCI, G. Le
comunità in età moderna: problemi storiografici e prospettive di ricerca.
Roma: Carocci, 1997, pp. 24-25). Cfr. anche VARANINI, G.M.. Comuni cittadini e stato regionale: ricerche
sulla Terraferma veneta nel Quattrocento. Verona: Libreria editrice
universitaria, 1992; CHITTOLINI, G. Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia
centro-settentrionale (secoli XIV-XVI). Milano: Unicopli, 1996;
CHIODI, G. Tra la civitas e il comitatus: i suburbi nella dottrina di diritto
comune. In: GALLINA, M. Antico. (cur.). Dal
suburbium al faubourg: evoluzione di una realtà urbana.
Milano: Edizioni Et, 2000, pp. 225-331; MARCHETTI, P. De iure finium: Diritto e confini tra tardo medioevo ed età
moderna. Milano: Giuffrè, 2001.
[3] Cfr. ASCHERI, M. Introduzione. Gli statuti:
un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia. In: BULGARELLI, G.
Pierangeli-S. (cur.). Biblioteca del
Senato della Repubblica, Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini,
leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti
locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII. VII: S. Firenze:
La Nuova Italia, 1990, pp. XXXI-XLIX; ASCHERI, M. Législation
italienne du bas moyen âge: le cas de Sienne (ca. 1200-1545). In:
BOUSMAR, J.-M. Cauchies-E. (cur.). Faire
bans, edictz et statuz: légiférer dans la ville médiévale. Sources, objects et
acteurs de l'activité législative communale en Occident, ca. 1200-1550. Actes
du colloque international (Bruxelles, 17-20 novembre 1999). Bruxelles:
Publications des Facultés universitaires Saint-Luis, 2001, pp. 51-83; ASCHERI, M.
Statuti e consuetudini tra storia e storiografia. In: DONDARINI, G.M.; VARANINI, M.Venticelli (cur.). Signori regimi signorili e statuti nel tardo
Medioevo. VII Convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle
Fonti Normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000). Bologna: Pàtron, 2003, pp.
21-31; DANI, A. Usi civici nello Stato di
Siena di età medicea., Bologna: pref. di D. Quaglioni, Monduzzi, 2003; DANI,
A. Il processo
per danni dati nello Stato della Chiesa, secoli XVI-XVIII. Bologna:
Monduzzi, 2006; MONTORZI, M. Giustizia in contado. Studi sull’esercizio
della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna.
Pisa: Edifir, 1997; VIDARI, G.S.
Pene. Un ritorno di fiamma: l’edizione degli statuti comunali. In Studi piemontesi. n. 25. S.l: s.n.,
1996, pp. 327-343; VIDARI, G.S. Pene. Introduzione. Atteggiamenti della
storiografia giuridica italiana. In BULGARELLI, S.; CASAMASSIMA, A.;
PIERANGELI, G.(cur.), Biblioteca del
Senato della Repubblica, Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini,
leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti
locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII. VIII: T-U.
Firenze: Nuova Italia, 1999, pp. XI-XCVI; CASANA, P. Gli statuti di Vernante e il diritto locale
della Contea di Tenda, Società per gli studi
Storici. Cuneo: Archeologici ed Artistici
della provincia di Cuneo, 2000; ROSBOCH, M. Invalidità e statuti medievali: Pisa,
Bologna, Milano, Ivrea. Roma: Fondazione Sergio
Mochi Onory per la Storia del diritto italiano, 2003; PIERGIOVANNI, V.
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine. In BULGARELLI, S.
(cur.). Biblioteca del Senato della
Repubblica, Gli statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli
XIII-XVI. Catalogo della mostra (8 novembre 1995-8 gennaio 1996). Roma: De
Luca, 1995, pp. 13-19; PIERGIOVANNI, V. Note per la storia degli statuti e
delle autonomie locali. In Menestò, E. (cur.). Gli statuti delle città: l’esempio di Ascoli nel secolo XIV. Atti
del Convegno di studio (Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998). Spoleto: Centro
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1999, pp. 3-9; SAVELLI, R. Gli statuti
della Liguria. Problemi e prospettive di ricerca. In: Società e Storia, 21. S.l.: s.n, 1999, pp. 3-33; SAVELLI, R.
Scrivere lo statuto amministrare la giustizia organizzare il territorio. In:
SAVELLI, R. (cur.). Repertorio degli
statuti della Liguria (secc. XII- XVIII). Genova: Società ligure di Storia
Patria, 2003, pp. 3-191; BRACCIA, R. Processi imitativi e circolazione dei
testi statutari: il ponente ligure. In: Studi
in onore di Franca De Marini Avonzo. Torino, Giappichelli, 1999, pp. 55-69;
BRACCIA, R. Diritto della città diritto
del contado. Autonomie politiche e autonomie normative di un distretto
cittadino. Milano: Giuffrè, 2004; QUAGLIONI, D. Legislazione statutaria e
dottrina degli statuti nell’esperienza politica tardomedievale. In: Statuti e ricerca storica. Atti del
Convegno (Ferentino, 11-13 marzo 1988). Ferentino: Comune di Ferentino, 1991,
pp. 61-75; QUAGLIONI, D. Un bilancio storiografico. In DONDARINI, R.; VARANINI,
G.M.; VENTICELLI, M. (cur.). Signori
regimi signorili e statuti, cit., pp. 11-20; SANTARELLI, U. Lo statuto
«redivivo». In Archivio storico italiano.
151. S.l.: s.n., 1993, pp. 519-526; SANTARELLI, U. La normativa statutaria nel quadro
dell’esperienza giuridica bassomedievale. In: Diritto generale e diritti particolari nell’esperienza storica. Atti
del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto
(Torino, 19-21 novembre 1998). Roma: Fondazione Sergio Mochi Onory, 2001,
pp. 337-350; SBRICCOLI, M. L’interpretazione
dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell’età
comunale. Milano: Giuffrè, 1969, rist. 2002; SBRICCOLI, M. Legislation, Justice and Political Power in
Italian Cities, 1200-1400. In: SCHIOPPA, A. Padoa (cur.). Legislation and Justice. Oxford:
Clarendon press, 1997, pp. 37-55; MECCARELLI, M.. Statuti, «potestas statuendi» e «arbitrium»: la
tipicità cittadina nel sistema giuridico medievale. In: MENESTÒ, E. (cur.). Gli statuti delle città, cit., pp.
89-124; STORCHI, C. Storti. Scritti sugli
statuti lombardi. Milano: Giuffrè, 2007.
[4] Un
contributo, in materia di ricerca, repertorizzazione e pubblicazione di fonti
normative urbane medievali e moderne, è garantito dalla Biblioteca del Senato
della Repubblica, dal Comitato italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti
normative (CISEFN), dal Centro di Studi sulla Civiltà del tardo Medioevo di S.
Miniato, dal Gruppo Interuniversitario per la Storia dell’Europa Mediterranea
(GISEM), dall’Istituto
Storico Italiano per il Medio Evo, dal Centro Italiano di
Studi sull’Alto Medioevo, dal Centro Interuniversitario per la Storia delle
città campane nel Medioevo. Cfr. ALBINI, G. (cur.). Bibliografia statutaria italiana: 1985-1995,
vol. I. Biblioteca del Senato della Repubblica. Roma: Centro di Studi sulla
Civiltà del tardo Medioevo di San Miniato, Comitato per gli Studi e le Edizioni
delle Fonti normative, 1998; ANGIOLINI, E. (cur.). Bibliografia statutaria italiana: 1996-2005. vol. II. Biblioteca
del Senato della Repubblica. Roma: Comitato per gli Studi e le Edizioni delle
Fonti normative, 2009. Cfr. SAVELLI,
R. (cur.). Repertorio degli statuti della
Liguria (secc. XII- XVIII), cit.; UNGARI, P. (cur.). Statuti
cittadini, rurali e castrensi del Lazio. Repertorio (secc. XII-XIX). Roma:
Cervati, 1993; VIDARI, G.S. Pene. Consuetudini di
Alessandria e «ius statuendi». In: Rivista
di Storia del diritto italiano. 61. S.l.: s.n., 1988, pp. 285-305; VIDARI, G.S.
Pene. Censimento ed edizione degli statuti con particolare riferimento al
Piemonte. In: Dal dedalo statutario. Atti dell’incontro di studio dedicato agli
statuti. Ascona: Centro Seminariale Monte Verità, 1993, pp. 262-288; VIDARI, G.S.
Pene. Aspetti storico-giuridici. In: SPINA, L. (cur.). L’Alpe e la Terra. I bandi campestri biellesi nei secoli XVI-XIX.
Biella: Rosso, 1997, pp. 15-52; VASINA, A. (cur.). Repertorio degli statuti comunali emiliani e
romagnoli (secc. XII-XVI). Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio
Evo, 1997-1999; BIANCIARDI, P., OTTAVIANI, M.G. Nico. (cur.). Repertorio degli
statuti comunali umbri. Spoleto: Centro Italiano di
Studi sull’Alto Medioevo,
1992; MENESTÒ, E. (cur.). Gli statuti comunali umbri. Atti del Convegno di
Studi svoltosi in occasione del VII centenario della promulgazione dello
Statuto comunale di Spoleto (Spoleto 8-9 novembre 1996). Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1997; VILLANI, V. (cur.). Istituzioni e
statuti comunali nella Marca d’Ancona: dalle origini alla maturità (secoli
XI-XIV). Ancona: Deputazione di Storia Patria per le Marche, 2005-2007. Cfr. anche le collane "Corpus statutario delle Venezie", diretta da
Gherardo Ortalli, Viella, Roma; "Statuti Comunali dell’Umbria", diretta da M.G.
Nico Ottaviani, Deputazione di Storia Patria per l’Umbria; "Statuti Comunali
della Patria del Friuli", Forum Editrice Universitaria, Udine.
[5] TOCCI, G. Le
comunità in età moderna: problemi storiografici e prospettive di ricerca.
Roma: Carocci, 1997, p. 93-94.
[6] VIDARI, G.S. Pene. Un ritorno di fiamma:
l’edizione degli statuti comunali. In Studi
piemontesi. n. 25. S.l: s.n., 1996.
[7] Sul
tema cfr. GALASSO, G. (cur.). Alle
origini del dualismo italiano. Regno di Sicilia e Italia centro-settentrionale
dagli Altavilla agli Angiò (1100-1350). Atti del
Convegno internazionale di studi (Ariano Irpino, 12-14 settembre 2011). Soveria
Mannelli: Rubbettino, 2014.
[8] «Nettamente preferibile appare, perciò, riconoscere che il dualismo del paese
preesiste alla sua unificazione politica, ma che nell’unificazione si sono
determinate condizioni per cui la precedente dualità ha assunto la complessa
fisionomia economica e sociale della questione meridionale. Il che rende, detto
per inciso, opportuno conservare a tale "questione" la sua canonica
denominazione e il senso di un problema nato e sviluppatosi nelle condizioni
dell’Italia unita e della sua gestione politica, economica e sociale.
Condizioni, però, che non sono solo interne, e che, meno che mai, si possono
riassumere nella conquista, rapina e sfruttamento del Mezzogiorno, ridotto a "colonia interna" da parte del Nord. Si tratta, infatti, di condizioni che in
parte non minore, e per molti versi in misura ben più determinante, dipendono
dall’esterno; risiedono, cioè, nella nuova struttura e nei nuovi rapporti
maturati nel "grande mercato" dell’economia industriale e capitalistica a un
livello che, alla fine del secolo XX, avrebbe fatto parlare di una "globalizzazione"» (GALASSO, G. Dualismo italiano. In: GALASSO, G.. (cur.), Alle origini del dualismo italiano, cit., p. 308).
[9] Da
qualche decennio, la storiografia italiana sembra sensibilizzata rispetto alla
necessità di dare un nuovo impulso alle ricerche sulla documentazione normativa
delle universitates civium, «nella
direzione di individuare organiche strutture dentro le articolazioni regionali
del Mezzogiorno» (TREPPO, M. Del. Medioevo e Mezzogiorno: appunti per un
bilancio storiografico, proposte per un’interpretazione. In: Rossetti, G.
(cur.). Forme di potere e struttura
sociale in Italia nel Medioevo. Bologna: il Mulino, 1977, p. 251). Dopo il
rinnovamento metodologico dello storico del diritto Francesco Calasso, agli
inizi del Novecento, il dibattito si è sviluppato intorno all’esigenza di
elaborare un modello autonomo, da collocare in una «più larga comparazione con
le altre aree dell’Occidente» (TABACCO, G. Il potere politico nel Mezzogiorno
d’Italia dalla conquista normanna alla dominazione aragonese. In: LEO, P. De
(cur.). Il Mezzogiorno medievale nella
storiografia del secondo dopoguerra: risultati e prospettive. Atti del IV
Convegno nazionale dell’Associazione dei medievisti italiani (Università di
Calabria, 12-16 giugno 1982). Soveria Mannelli: Rubbettino, 1985, pp. 65-111).
Cfr. anche SERGI, G. La comparazione che cambia: le riletture comunali del
Settentrione in una prospettiva italiana. In: SAITTA, B. (cur.). Città e vita cittadina nei paesi dell’area
mediterranea. Secoli XI-XV. Atti del Convegno Internazionale in onore di
Salvatore Tramontana (Adrano-Bronte-Catania-Palermo, 18-22 novembre 2003).
Roma: Viella, 2006, pp. 87-95; DELILLE, G. Governo locale e identità urbana: il
caso italiano in una prospettiva europea. In: CHACÓN, F., VISCEGLIA, M.A.,
MURGIA, G., TORE, G. (curr.). Spagna e
Italia in Età moderna: storiografie a confronto. Primo Incontro Internazionale.
Identità mediterranee: Spagna e Italia in una prospettiva comparativa (secoli
XVI-XVIII). Roma: Viella, 2009, pp. 119-133); Les
pouvoirs territoriaux en Italie centrale et dans le sud de la France.
Hiérarchies, institutions et langages (XIIe-XIVe siècle):
études comparées, in «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen-Âge», 123 (2011), n. 2;
Codicologie et langage de la norme dans les statuts de la Méditerranée
occidentale à la fin du Moyen Âge (XIIe-XVe siècles),
in «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen-Âge», 126 (2014), n. 2.
[10] Cfr.
CALASSO, F. La «dottrina degli statuti» per l’Italia meridionale [1928]. In: Annali di storia del diritto, 9. S.l.:
s.n., 1965, pp. 283-312. Questa chiave di interpretazione fu contrastata da
GAUDIOSO, M. Natura giuridica delle
autonomie cittadine nel "Regnum Siciliae". Catania: Casa del libro, 1952.
Partendo dalla distinzione tra ordinamenti originari e ordinamenti derivati, lo
storico del diritto padovano, Aldo Checchini, allievo di Biagio Brugi e Nino
Tamassia, si è spinto, invece, oltre le riflessioni del Calasso: «deve’essere
anche esclusa la "diversità" – affermata dal Calasso – della "condizione
giuridica dei Comuni dell’Italia superiore da quella in cui si trovan le città
del Mezzogiorno". L’indagine svolta sopra dimostra che la "condizione giuridica" delle "città del Mezzogiorno" comprese nel Regnum
Siciliae, deve considerarsi sostanzialmente
eguale a quella dei Comuni dell’Italia superiore compresi nell’unità
dell’Impero... interessa qui rilevare: a) che l’essenza, non del concetto medievale, ma del generale concetto giuridico di sovranità emerge
con certezza dalle "condizioni politico-giuridiche del Regno di Sicilia", "in
perfetta coerenza" con le quali "nasceva il ragionamento... del glossatore
meridionale Marino da Caramanico"; b) che dalle condizioni politico-giuridiche
del Regnum Siciliae si differenziano sostanzialmente quelle, non soltanto
degli ordinamenti particolari "delle altre parti d’Italia", ma delle stesse Universitates terrarum Regni Siciliae»
(CHECCHINI, A. Pressupposti giuridici dell’evoluzione storica dalla
«bartoliana» teoria degli statuti al moderno diritto internazionale. In:
SEGOLONI, D. (cur.), Bartolo da
Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario, vol. II. Milano:
Giuffrè, 1962, pp. 90 e 70).
[11] Cfr.
CALASSO, F. La legislazione statutaria
dell’Italia meridionale, parte prima. Roma: Signorelli, 1929, rist. an.
Centro librario, Multigrafica, Bari-Roma 1971. Cfr. anche CALASSO, F. La città nell’Italia meridionale dal sec. IX
al XI [1959]. In: Annali di storia del diritto, 9. S.l:
s.n., 1965, pp. 235-260; CALASSO, F. La città nell’Italia meridionale durante
l’età normanna [1959], in Annali di
storia del diritto, 9. S.l.: s.n., 1965, pp. 263-279. Questa
«caratteristica, della spontaneità dell’evoluzione, è l’indice di un
orientamento della vita pubblica che il mondo del diritto con la sua
particolare sensibilità, e quasi attuando una sintesi a priori di futuri svolgimenti, registra con precocità. E, come già
altre volte osservammo, il campo delle fonti normative ne è lo specchio fedele.
Mentre nell’età normanna e, ancora più rigidamente, nella sveva le consuetudini
e leggi locali avevano potuto serbarsi in vita solo in quanto non
contrastassero con le leggi dello Stato, che avevano comunque il primo posto,
già nei primi decenni del governo angioino appaiono manifestamente i segni del
rapido sviluppo dei diritti locali e troviamo l’esplicita dichiarazione che
tali diritti sono validi «capitulis et legibus Regni non obstantibus in
contrarium disponentibus»: dove è evidente che l’antico rapporto fra diritto
locale e diritto statuale è del tutto rovesciato» (CALASSO, F. Gli ordinamenti giuridici del rinascimento
medievale. Milano: Giuffrè, 1949², rist. an. 1965, p. 185).
[12] CARAVALE, M. La legislazione statutaria dell’Italia meridionale e della
Sicilia. In: CARAVALE, M. La monarchia
meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni.
Roma-Bari: s.n, 1998, p. 200. Accanto
alla storiografia calassiana cfr. le pionieristiche iniziative di ALIANELLI, N.
Delle antiche consuetudini e leggi
marittime delle provincie napoletane. Napoli: De Angelis, 1871; ALIANELLI,
N. Delle consuetudini e degli statuti
municipali delle provincie napoletane. Napoli: Rocco, 1873; FARAGLIA, N.F. Il comune nell’Italia meridionale (1110-1806).
Napoli: Tip. della Regia Università, 1883; CARABELLESE, F. L’Apulia e il suo Comune nell’alto Medio Evo. Bari: Vecchi, 1905;
CARABELLESE, F. Il Comune pugliese
durante la monarchia normanno-sveva. Bari: Vecchi, 1924. Per un bilancio sulle riflessioni storiografiche
successive cfr., almeno, GALASSO, G. Dal comune medievale all’unità. Linee di
storia meridionale. Bari: Laterza, 1969; GALASSO, G. Sovrani e città nel Mezzogiorno
tardo-medievale. In: GENSINI, S. (cur.).
Principi e città alla fine del Medioevo. Pisa: Pacini, 1996, pp. 225-247;
CASSANDRO, G. Il Comune meridionale
nell’età aragonese. In CASSANDRO, G. Lex cum moribus. Saggi di metodo e di Storia
giuridica meridionale, pref. di M. Caravale, pres. di A. Campitelli, vol.
I. Bari: Cacucci, 1994, p. 643-662; VALLONE, G. Riflessioni sull’ordinamento
cittadino del Mezzogiorno continentale. In Rivista
internazionale di diritto comune, 2. S.l.: s.n., 1991, pp. 153-174; CORRAO,
P. Città e normativa cittadina nell’Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo:
un problema storiografico da riformulare. In: DONDARINI, R. (cur.). La libertà di decidere. Realtà e parvenze
di autonomia nella normativa locale del Medioevo, Atti del Convegno (Cento,
6-7 maggio 1993). Cento: Deputazione provinciale
ferrarese di storia patria, 1995, pp. 35-60; ROMANO, A. Consuetudini,
statuti e privilegi cittadini nella realtà giuridico-istituzionale del Regno di
Sicilia. In DÖLEMEYER,
B. (cur.). Das Privileg im europäischen
Vergleich. vol. 2. Frankfurt am Main: Heinz Mohnhaupt, 1999, p. 117-142; ROMANO, A. Definizione e
codificazione dello ius commune siculum. In: BIROCCHI, I., MATTONE, A. (curr.). Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione
(secoli XVI-XIX). Atti del convegno internazionale (Alghero, 4-6 novembre
2004). Roma: Viella, 2006, p. 483-506; MILETTI, M.N. Peregrini in patria.
Percezioni del ius regni nella giurisprudenza napoletana d’eta moderna. In I.
BIROCCHI, I., MATTONE, A. (curr.). Il
diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX). Atti
del convegno internazionale (Alghero, 4-6 novembre 2004). Roma: Viella, 2006,
p. 401-482; VITOLO,G. (cur.), Città e
contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna. Salerno: Laveglia,
2005.
[13] Per
un profilo dello studioso cfr. PINTO, G. Ricordo di Antonio Ivan Pini. In: Bullettino storico pistoiese. CV. S.l.:
s.n., 2003, p. 3-8.
[14] PINI, A.I. Dal comune città-stato al comune
ente amministrativo. In: PINI, A.I. Città,
comuni e corporazioni nel medioevo italiano. Bologna: Clueb, 1986, pp.
61-62: «Quando il margine di autonomia è assoluto si ha la piena sovranità e
quindi la vera e propria città-stato
(come nella Grecia antica o nell’Italia preromana). Quando l’autonomia, pur
molto ampia in senso amministrativo, non si esplica nel settore
giurisdizionale, legislativo e coercitivo, si ha un ente amministrativo tipo il municipio romano, l’università
dell’Italia meridionale, il comune odierno. Quando invece si hanno contemporaneamente
le due cose, cioè un’autonomia di tale ampiezza di attribuzioni
giurisdizionali, legislative, finanziarie e amministrative, da ridurre la
potestà sull’ente territoriale dello stato sovrano ad una sovranità più che
altro nominale, ma non appunto la piena sovranità, si ha un tipo di comune che potremmo definire "politico", che è la forma di autonomia
locale che caratterizza la storia di buona parte dell’Italia
centro-settentrionale tra l’XI e il XV secolo, ma che in certe zone (Genova,
Venezia, Lucca) giunge sino alla fine del XVIII secolo». Corsivo aggiunto.
Recentemente, riguardo alla realtà centro-settentrionale, Mario Ascheri si è
soffermato per l’epoca medievale sul concetto di «città-Stato», come species del genus Comune (ASCHERI, M. Siena
e la città-stato del Medioevo italiano. Siena: Betti, 2003; ASCHERI, M. Le città-Stato. Bologna: Il Mulino,
2006). Luca Mannori ha, invece, evidenziato la presenza, tra basso-medioevo ed
età moderna, di uno «Stato» cittadino, come «piccolo Stato» in un «grande
Stato», tra «pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo» (MANNORI,
L. Il «piccolo Stato» nel «grande Stato». Archetipi classici e processi di
territorializzazione nell’Italia tardo medievale e proto moderna. In: GABBA,
E., SCHIAVONE, A. (curr.). Polis e
piccolo Stato tra riflessione antica e pensiero moderno. Atti delle Giornate di studio (Firenze,
21-22 febbraio 1997). Como: New press, 1999, pp. 48-66. Sui profili dell’"auto
amministrazione" e del "legicentrismo" tra Sette e Ottocento, cfr. anche
MANNORI, L. Dall’autonomia all’autoamministrazione: legicentrismo e comunità
locali tra Sette e Ottocento, in Diritto
generale e diritti particolari nell’esperienza storica. Atti del Congresso
internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21
novembre 1998). Roma: Fondazione Sergio Mochi Onory, 2001, p. 389-420.
[15] GALASSO, G. Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494). In: GALASSO, G. (cur.), Storia d’Italia. vol. XV/1. Torino:
s.n., 1992, p. 439
[16] M.
Caravale, La legislazione statutaria,
cit., p. 200. «In effetti, nell’Italia meridionale come in ogni altra regione
europea l’assetto sociale cittadino esprimeva una gerarchia di poteri che
vedeva al vertice della comunità un ristretto gruppo di famiglie. Tra queste e
la monarchia si venne per lo più ad instaurare uno stretto rapporto d’intesa,
dato che le prime avevano bisogno della protezione – militare, politica,
giurisdizionale – della seconda e costei si fondava sul loro controllo
territoriale per assicurare pace interna alle popolazioni e per ottenere
l’indispensabile consenso. Tale intesa implicava necessariamente uno stabile
equilibrio tra le tendenze unitarie della monarchia e le libertà necessarie
all’ordinamento cittadino. Perciò, come si è detto prima, le consuetudini non
potevano contrastare con le disposizioni regie. Per il medesimo motivo
l’autonomia cittadina doveva armonizzarsi con gli altri ordinamenti locali che
componevano il Regno» (CARAVALE, M. Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale.
Bologna: Il Mulino, 1994, p. 281).
[17] Mi
sia consentito, per ragioni di spazio, rinviare alle riflessioni contenute
nelle mie due monografie e alla relativa bibliografia citata (Scipione de Augustinis, L’«Amor’ infinito,
ch’alla Patria si deve». La "Descrittione d’Ariano" di un notaio del XVI secolo,
edizione critica a cura di G. Stanco, pref. di G. Galasso, Elio Sellino,
Avellino 2008; STANCO, G. Gli statuti di
Ariano. Diritto municipale e identità urbana tra Campania e Puglia. Ariano
Irpino: Centro Europeo di Studi Normanni, 2012).
[18] Cfr.
MUSI, A. Né anomalia né analogia: le città del Mezzogiorno in età moderna. In:
VITOLO, G. (cur.). VITOLO,G. (cur.), Città
e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna. Salerno: Laveglia,
2005, p. 307-312.
[19] MUSI, A. Il Regno di Napoli dagli Spagnoli all’Unità. In: MUSI, A., VITOLO, G.
(curr.). Il Mezzogiorno prima della
questione meridionale. Firenze: Le Monnier, 2004, pp. 109-211, p. 204. Cfr.
anche MUSI, A. (cur.). Le città del
Mezzogiorno nell’Età moderna. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2000.
«Per il Mezzogiorno d’Italia la ‘via napoletana allo Stato moderno’ ha
continuato a segnare uno degli assi centrali della ricerca. Anche questa,
tuttavia, è stata per lo più considerata come una via disseminata di
compromessi. Si è insistito sui processi di accentramento e l’erosione degli
spazi politici lasciati in periferia alle forze feudali, ma anche sulla non
linearità di questi processi, segnati da colpi d’arresto, riprese, crisi. Si è
parlato del disciplinamento dei ceti dominanti, da ‘potenze’ che erano ridotte
a ‘poteri’, ma anche del mancato assorbimento dei ‘ceti’ da parte dello Stato,
a lungo disposto a riconoscerli e garantirli come ordini privilegiati. E nella
loro ‘dialettica’ – che è parsa anche come dialettica tra la capitale, luogo di
elezione del ‘ceto civile’, della ‘Respublica dei togati’, e la periferia, a
lungo feudale – si è continuato a vedere la chiave della storia del Regno tra
Cinque e Seicento. A partire dalle periferie si è d’altra parte sviluppata in
anni recenti un’attenzione nuova alla storia dei centri urbani. Così anche nel
caso del Regno, alcuni studiosi vedono oggi nelle città dei poli aggregativi
territoriali di qualche consistenza, benché soggetti a processi di rapida
marginalizzazione: sede, nel tardo Quattrocento, di poteri capaci di
interloquire con il governo centrale, prima di diventare nelle sue mani, tra
Cinque e Seicento, strumento di disciplinamento dei particolarismi e dei gruppi
sociali periferici» (GUARINI, E. Fasano. Centro e periferia, accentramento e
particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna? In:
CHITTOLINI, G., MOLHO, A., SCHIERA, P. (curr.), Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra
medioevo ed età moderna. Convegno storico (University of Chicago, 26-29
aprile 1993). Bologna: il Mulino, 1994, pp. 164-165).
[20] ROMANO, A. Le due Italie degli statuti: tra regno, signorie e comuni. Spunti
comparativi. In: DONDARINI, R., VARANINI, G.M., VENTICELLI, M. (curr.). .). Signori
regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo. VII Convegno del Comitato
Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative (Ferrara, 5-7
ottobre 2000). Bologna: Pàtron, 2003, p. 49.
[21] CORRAO, P. La difficile identità delle città siciliane. In: CHITTOLINI, G.,
JOHANEK, P. (curr.), Aspetti e componenti
dell’identità urbana in Italia e in Germania (secoli XIV-XVI). Bologna: il
Mulino, 2003, pp. 97-122. «Il fatto che la storia del Mezzogiorno sia stata a
lungo prigioniera di una separatezza dal resto della storia italiana, e in
particolare dal problema della costruzione di assetti statali quali quelli dei
secoli XV-XVI, deriva infatti essenzialmente... dall’isterilimento del
dibattito storiografico sui regni meridionali attorno alle categorie indiscusse
di monarchia e feudalità, largamente insufficienti. Si è supposta la storia
sociale e istituzionale meridionale determinata dal confronto fra una
monarchia, sempre uguale a se stessa, e una feudalità, anch’essa con
caratteristiche analoghe sul lungo periodo. Non cogliere la portata della
trasformazione che interessò sia le strutture istituzionali della monarchia,
sia l’assetto e le caratteristiche delle classi aristocratiche, sia i rapporti
fra le une e le altre; sottovalutrare o trascurare del tutto l’esistenza di
altri soggetti che agivano nello spazio politico e sociale del regno; non
rilevare quanto le due realtà che si suppone contrapposte fossero in realtà
compenetrate e intrecciate comporta inevitabilmente l’impossibilità di
attingere alle reali dinamiche della storia meridionale e di leggerne le
vicende rispettandone la complessità. Il paradigma delle ‘due Italie’ è
d’altronde profondamente radicato nella storiografia italiana e di argomento
italiano... E tuttavia si tratta di un paradigma relativamente superficiale,
che è stato alla radice di una lettura retrodatata della cosiddetta ‘questione
meridionale’, che ha causato una reciproca estraneità fra gli orientamenti
storiografici del Sud e del Centro-Nord, e che ha determinato, dal punto di
vista dell’osservatore ‘esterno’, una sbrigativa identificazione della storia
italiana con quella della parte centro-settentrionale della penisola, più
fortemente caratterizzata in senso originale dal fenomeno cittadino e dai suoi
sviluppi, cui si è sempre attribuito carattere progressivo, in contrapposizione
a una vicenda tendenzialmente immobile del Mezzogiorno. Ciò ha generato una
visione inevitabilmente distorta, che ha ignorato le strettissime relazioni
esistenti fra le due aree della penisola e ha isolato la storia del Mezzogiorno
dallo stesso contesto europeo, in cui invece, pur con le sue particolarità, si
colloca allo stesso titolo di quella dell’area centro-settentrionale (CORRAO,
P. Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo. Note sul
caso siciliano. In: CHITTOLINI, G., MOLHO, A., SCHIERA, P. (curr.), Origini dello Stato. Processi di formazione
statale in Italia fra medioevo ed età moderna. Convegno storico (University
of Chicago, 26-29 aprile 1993). Bologna: il Mulino, 1994, p. 189-191).
[22] VITOLO, G. Tra Napoli e Salerno. La
costruzione dell’identità cittadina nel Mezzogiorno medievale. Salerno:
Carlone, 2001, pp. 8-9. Secondo Francesco Senatore, «L’università non è affatto
una "forma", magari percepita come imperfetta, del comune dell’Italia
centro-settentrionale. È vero esattamente il contrario: nella dottrina universitas è il termine utilizzato per
connotare qualsiasi ente corporativo dotato di personalità giuridica e di
autonomia: associazioni professionali, comunità religiose, comunità
territoriali. Dal punto di vista giuridico, ma anche da quello storiografico,
potremmo dire insomma che l’universitas è
il genere e che il comune è la specie. Assumere i comuni italiani
centro-settentrionali – esperienza storica e politica di straordinaria portata
– come modello implicito nella storia delle città e persino delle comunità
minori è infatti pericoloso, e impedisce un’ampia considerazione del fenomeno
cittadino e comunitario su scala italiana ed europea. In quanto stati cittadini
sovrani ("autocefali", per dirla con Weber) i comuni del Centro e del Nord
d’Italia furono un’eccezione nel panorama europeo (e dunque anche in quello
dell’Italia, data la limitatezza geografica dell’area di "civiltà comunale"),
dove i centri urbani e rurali furono tutti, o quasi, semplicemente "autonomi",
ma non "autocefali"» (SENATORE, F. Gli
archivi delle universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune
considerazioni generali. In LANGELI, A. B., GIORGI, A., MOSCADELLI, S. (curr.).
Archivi e comunità tra Medioevo ed Età
Moderna. Siena: Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione
generale per gli archivi, 2009, p. 450-451).
[23] Il
«problema delle città nel Regno riacquista importanza, orientandosi adesso
verso il superamento della polemica sulla natura giuridica della normativa
cittadina e dell’inevitabile confronto – per analogia o per differenza – con le
realtà comunali sul modello dell’Italia centro-settentrionale e punta
l’attenzione sulle caratteristiche dell’identità cittadina, nel quadro
complesso di un sistema politico policentrico, nel quale viene a cadere la
tradizionale subordinazione gerarchica città-corona, ed emerge invece un
rapporto dialettico fra le varie componenti del Regno. In questa ottica lo
studio sulle normative locali riprende vigore: lo ius proprium delle città assume una diversa caratterizzazione,
essendo indagato come il prodotto di una identità cittadina che tuttavia non si
afferma ‘contro’ o ‘grazie’ al favore regio, ma che è dotata per sua stessa
natura di una iurisdictio sua propria
della quale sono garanzia ed insieme espressione le magistrature locali che ne
assicurano il rispetto e la vigenza» (PASCIUTA, B. Due falsi privilegi
fredericiani su Corleone: la normativa cittadina e il paradigma della falsificazione.
In: Annali del Seminario giuridico
dell’Università di Palermo. 48. n.
2. Palermo: Università di Palermo, 2003, p. 202).
[24] Il
riferimento riguarda soprattutto gli effetti fuorvianti delle incrostazioni
statualistiche della categoria autonomia assimilata spesso a quella di
indipendenza. Circa l’autonomia nel Medioevo come «nozione relativa» cfr.
GROSSI, Paolo. L’ordine giuridico
medievale. Roma-Bari: Laterza, 1997, p. 51: «Autonomia qui significa dunque
storicità autentica del diritto, capacità di interpretare e rappresentare il
gioco delle linee propulsive presenti nella società, insuscettibile a essere
ridotta a voce di un principe, di un ceto ristretto, di una classe. Autonomia
significa disincagliamento da forze specifiche e particolari, ma significa
immersione completa senza preclusioni nel profondo strutturale d’una età e d’un
luogo e, al tempo stesso, sensibilità a quanto in quel profondo si muove e
preme».
[25] Sulle problematiche relative all’appartenenza
civica cfr. ASCHERI, M. Lo straniero nella legislazione e nella letteratura
giuridica del Tre-Quattrocento: un primo approccio. In: Rivista di Storia del diritto italiano. 60. S.l.: s.n., 1987, pp.
179-194; QUAGLIONI, D. Le radici teoriche della dottrina bartoliana della
cittadinanza. In: QUAGLIONI, D. ‘Civilis
sapientia’. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età
moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno. Rimini:
Maggioli, 1989, pp. 127-144; STORCHI, C. Storti. Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo
diritto comune all’età preunitaria. Aspetti civilistici. Milano: Giuffrè,
1990; ASCHERI, M. Lo straniero: aspetti della problematica giuridica. In
ROSSETTI, G. (cur.). Dentro la città.
Stranieri e realtà urbane nell’Europa dei secoli XII-XVI. Napoli: Liguori,
1999², pp. 37-50; TREPPO, M. Del. Stranieri nel regno di Napoli. Le élites
finanziarie e la strutturazione dello spazio economico e politico. In:
ROSSETTI, G. (cur.). Dentro la città.
Stranieri e realtà urbane nell’Europa dei secoli XII-XVI. Napoli: Liguori,
1999, p. 193-251; COSTA, Pietro. Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 1. Dalla
civiltà comunale al Settecento. Roma-Bari : Laterza, 1999; CHITTOLINI, G., JOHANEK, P. (curr.), Aspetti e componenti dell’identità urbana
in Italia e in Germania (secoli XIV-XVI). Bologna: il Mulino, 2003;
ASCHERI, M. Un’altra cittadinanza: nei privilegi e nella fedeltà pre-comunali.
In: PRODI, P. (cur.). La fiducia secondo
i linguaggi del potere. Bologna: Il Mulino, 2007, pp. 311-323; VENTURA, P.
Il linguaggio della cittadinanza a Napoli tra ritualità civica, amministrazione
e pratica politica (secoli XV-XVII).
In BALBI, G. Petti, Vitolo, G. (curr.). Linguaggi
e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed Età moderna.
Salerno: Laveglia, 2007, p. 347-375; COSTA, Pietro. Civitas, respublica,
corpus. Immagini dell’ordine e dell’appartenenza fra ‘antico’ e ‘moderno’. In:
CARILLO, G. (cur.). Unità e disunione
della polis. Avellino: Elio Sellino, 2007, p. 559-645; Cittadinanza e disuguaglianze
economiche: le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVI secolo), in «Mélanges de l’École française de Rome.
Moyen-Âge», 125 (2013), n. 2; VARANINI, G.M. (cur.). Storiografia e identità dei centri minori
italiani tra la fine del Medioevo e l’Ottocento. Atti del XIII Convegno di
studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo (San
Miniato, 24-26 settembre 2010). Firenze : Firenze University Press, 2013;
CASSI, A. (cur.). Ai margini della civitas:
figure giuridiche dell’altro fra Medioevo e futuro. Soveria
Mannelli: Rubbettino, 2013. Circa l’identità del ius Regni cfr. MILETTI, M.N. Ermeneutica del Ius Municipale nella giurisprudenza
napoletana d’età moderna. In : STORTI, C. (cur.). Il ragionamento analogico. Profili
storico-giuridici. Napoli : Jovene, 2010, p. 299 ss.
[26] CERNIGLIARO, A. Civitas et insula de Yscla. Un centro marinaro tra Aragonesi e
Asburgo. In: Studi Veneziani, 52.
S.l.: s.n., 2006, p. 20.
[27] «CORO:
Viva l’Italia! un sacro patto / Tutti stringe i figli suoi: / Esso alfin di
tanti ha fatto / Un sol popolo d’eroi! / Le bandiere in campo spiega, / O
Lombarda invitta Lega, / E discorra un gel per l’ossa / Al feroce Barbarossa. /
Viva l’Italia forte ed una / Colla spada e col pensier / Questo suol che a noi
fu cuna, / Tomba sia dello stranier!» (La
battaglia di Legnano. Tragedia lirica in quattro atti di Salvatore Cammarano
posta in musica da Giuseppe Verdi, G. Ricordi, Milano s.d., p. 33).
[28] Cfr.
MIGLIO, G. Per un’Italia federale.
Milano: Il Sole 24 ore, 1990; MIGLIO, G. Federalismo
e secessione. Un dialogo (con A. Barbera). Milano: Mondadori, 1997;
BUCHANAN, A. Secessione. Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi,
presentazione di G. Miglio, A. Milano: Mondadori, 1994. Sul pensiero dello studioso cfr. BUSSOLETTI, A. Autonomia e federalismo tra diritto e scienza
politica: il pensiero di Gianfranco Miglio. In: Quaderni Fiorentini,. vol. I 43. Firenze: s.n., 2014, p. 393-414.
[29] Cfr.
NAJEMY, J.M. Stato, comune e «universitas. In: CHITTOLINI, G., MOLHO, A.,
SCHIERA, P. (curr.), Origini dello Stato.
Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna. Convegno
storico (University of Chicago, 26-29 aprile 1993). Bologna: il Mulino, 1994,
p. 651-652.
[30] SBRICCOLI, M. L’interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione
dei giuristi nell’età comunale. Milano: Giuffrè, 1969
[31] L.
Lacchè, Sbriccoli, Mario, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani
(XII-XX secolo), diretto da I. Birocchi- E. Cortese-A. Mattone-M.N.
Miletti, vol. II, il Mulino, Bologna 2013, p. 1810.
[32] ASCHERI, M. Introduzione. Gli statuti: un
nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia, cit. Cfr. anche
ASCHERI, M. Législation et coutumes dans les villes italiennes et leur
‘contado’ (XIIe-XIVe siècles). In: MOUSNIER, M., POUMARÈDE, J. (cur.). La coutume au village dans l’Europe
médiévale et modern. Toulouse: Presses
Universitaires du Mirail, 2001, pp. 73-92.
[33] SBRICCOLI, M. Conclusioni. In: MENESTÒ, E. (cur.), Gli statuti delle città, cit., p. 167-168; 171; 172; 174.
[34] Cfr.
SALA, G. Sui caratteri
dell’amministrazione comunale e provinciale dopo la riforma del Titolo V della
Costituzione, in Studi in onore di
Giorgio Berti. vol. III. Napoli: Jovene, 2005, p. 2241-2242: «Non a caso il
riconoscimento, con la legge 142 del 1990, di una autonomia statutaria era
dapprima parso il segno più forte di rottura con l’esperienza passata, per
divenire ben presto uno dei punti di maggior delusione. La legislazione
successiva, da quella elettorale alle riforme della dirigenza pubblica, hanno
compresso l’autonomia statutaria non solo quanto alla forma di governo
dell’ente ma anche per la distribuzione delle competenze interne, tra organi e
uffici. Che ciò sia avvenuto per fini anche condivisibili, come l’assegnazione
dei compiti di gestione a soggetti legittimati non da una rappresentanza
elettorale ma da una capacità professionale, non fa venir meno la constatazione
che, di fatto, lo statuto, nel testo unico del 2000, è ridotto a poco più di un
regolamento di organizzazione».
[35] «Nel
corso della XIII legislatura (maggio 1996-maggio 2001) si possono individuare
in proposito tre fasi. Un primo periodo (che ha termine nel maggio 1998)
contrassegnato dal tentativo di "grande riforma" costituzionale avviato con la
commissione bicamerale per le riforme costituzionali e dalla parallela
approvazione della legge Bassanini (la legge n. 59/1997) con la quale si è dato
avvio al cosiddetto "federalismo amministrativo"; un secondo periodo che
attraversa il 1999 – la breve ma molto produttiva stagione delle "riforme
parziali"; un’ultima fase, quella che comprende l’anno 2000 e gli ultimi mesi
della legislatura, nel corso della quale ha luogo propriamente la formazione
del testo successivamente divenuto la legge cost. n. 3/2201» (RIZZONI, G. La
riforma del sistema delle autonomie nella XIII legislatura. In: GROPPI, T.,
OLIVETTI, M. (curr.). La Repubblica delle
autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V. Torino: Giappichelli,
2003, p. 23).
[36] Cfr.
T. Groppi-M. Olivetti (curr.), La
Repubblica delle autonomie, cit.; PIOGGIA, A., VANDELLI, L. (curr.). La repubblica delle autonomie nella
giurisprudenza costituzionale: regioni ed enti locali dopo la riforma del
titolo V. Bologna: il Mulino, 2006.
[37] «In
verità, le riforme degli assetti territoriali dei pubblici poteri non hanno
costituito tanto lo sviluppo ‘armonico’ di un modello chiaramente precostituito
quanto piuttosto la risultante di interventi riformatori parziali e settoriali.
Come è stato osservato da più parti, infatti, tali interventi, nel corso degli
anni ’90, hanno avuto ciascuno una "storia abbastanza autonoma" e sono stati
prodotti dall’interazione di diversi attori politici ed istituzionali coinvolti
nella formazione delle politiche istituzionali, "senza attribuire grande
risalto alla razionalità a priori di
un dato modello"» (GAMBINO, S Regioni e autonomie locali nella riforma del
Titolo V della Costituzione. In: Scritti
in memoria di Livio Paladin, vol. II. Napoli: Jovene, 2004, p. 933-934).
[38] ROMANELLI, R. Centralismo e autonomie. In: ROMANELLI, R. (cur.). Storia dello Stato italiano dall’Unità a
oggi. Roma: Donzelli, 1995, p. 186.
[39] Cfr.
art. 114, co. 2, Cost. «È chiaro – e sul punto non vi sono incertezze – che gli
statuti degli enti locali sono una tipica espressione di autonomia, ma anche
che essi sono comunque subordinati alla legge ordinaria, della quale devono
rispettare i principi... Va, invece, escluso che principi-limite dell’autonomia
statutaria possano essere contenuti in leggi regionali. Circa la natura dello
statuto, si ritiene esatta la qualificazione di esso come fonte sub primaria, per evidenziarne la
diretta legittimazione costituzionale... ed il suo potere di deroga anche a
determinate norme primarie (ossia, come accennato, alle norme non di
principio)» (STADERINI, F. Diritto degli
enti locali,. Padova: Cedam, 2006, pp. 76-78).
[40] Cfr.
art. 117, co. 6, Cost.
[41] Secondo F. Staderini, Diritto degli enti
locali, cit., pp. 91-93, tuttavia, «È difficile, anche per l’insufficienza
delle fonti documentali disponibili, dare giudizi sulla c.d. fase costituente
degli enti locali, seguita alla legge 142; ma la prima impressione è di un uso
assai limitato e prudente del nuovo strumento a disposizione. Insomma non
sembra proprio che l’esercizio dell’autonomia statutaria abbia consentito di
realizzare l’auspicato superamento dell’uniformità degli ordinamenti locali...
Se le forze politiche locali di fronte al nuovo strumento statutario hanno
mostrato scarsa propensione a sfruttare le molteplici potenzialità che esso
consentiva, il parlamento nazionale nello stesso tempo ne ha addirittura
ignorato l’esistenza, continuando a legiferare come se nulla fosse cambiato nei
contenuti dell’autonomia locale. Per il futuro, peraltro – secondo il nuovo
criterio stabilito dalla L. 265/99 e ripetuto nell’art. 1.3 del T.U. – soltanto
le innovazioni in materia statutaria dichiarate espressamente inderogabili dal
legislatore vincoleranno le autonomie locali».
[42] Cfr.
CASSESE, S. Lo Stato introvabile.
Modernità e arretratezza delle istituzioni italiane. Roma: Donzelli, 1998;
FERRARESE, M.R. Le istituzioni della
globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale. Bologna:
il Mulino, 2000; DI GENIO, G. Ordinamento europeo e fonti di autonomia
locale. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2000; CHIEFFI, L. (cur.). Regioni e dinamiche di integrazione europea.
Torino: Giappichelli, 2003; Grossi, P. Globalizzazione,
diritto, scienza giuridica. In: Il Foro Italiano. 127. S.l.: s.n., 2002, p.
151-164; CASSESE, S. La crisi dello
Stato. Roma-Bari: Laterza, 2002; CASSESE, S. Lo spazio giuridico globale. Roma-Bari: Laterza, 2003; CASSESE, S.,
CONTICELLI, M. (curr.), Diritto e amministrazioni nello spazio giuridico globale. Milano: Giuffrè, 2006.
[43] OLIVETTI, M. Lo Stato policentrico delle autonomie (art. 114, 1° comma). In:
GROPPI, T., OLIVETTI, M. (curr.). La
Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V.
Torino: Giappichelli, 2003, p. 45. La « nuova formulazione dell’art. 114 Cost.
sostituisce un modello di relazioni di tipo gerarchico e piramidale ("La
Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni") con un altro di natura
policentrica (o "a rete"), ispirata alle moderne realtà del multilevel constitutionalism. Ciò che
emerge dagli artt. 114, 117 e 118 Cost. è un sistema istituzionale a più
livelli, costituito da una pluralità di ordinamenti giuridici integrati, che
interagiscono reciprocamente: riprendendo quanto la Corte costituzionale ha
affermato a proposito delle relazioni tra l’ordinamento comunitario e quello
italiano, si potrebbe dire che la Repubblica italiana risulta composta da una
pluralità di "ordinamenti reciprocamente autonomi, ma tra loro coordinati e
comunicanti". Con la nuova disciplina costituzionale dei comuni e delle
province si assiste contemporaneamente al tramonto delle teorie monistiche e ad
una evoluzione delle teorie fondate sul riconoscimento della necessità
pluralistica degli ordinamenti giuridici. Integrazione ed autonomia,
salvaguardia di esigenze unitarie e valorizzazione delle discipline locali
sembrano essere gli orientamenti principali che contrassegnano il sistema
istituzionale repubblicano» (ROLLA, G. L’autonomia dei comuni e delle province.
In: GROPPI, T., OLIVETTI, M. (curr.). La
Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V.
Torino: Giappichelli, 2003, p. 212-213).
[44] Cfr.
MONACO, F. Roversi (cur.). Sussidiarietà
e Pubbliche Amministrazioni. Atti del Convegno (Bologna, 25-26 settembre
1995). Rimini: Maggioli, 1997; RINELLA, A., COEN, L., SCARCIGLIA, R. Sussidarietà e ordinamenti costituzionali.
Esperienze a confronto. Padova: Cedam, 1999; DE PASQUALE, P. Il principio di sussidiarietà
nell’ordinamento comunitario. Napoli: Editoriale Scientifica, 1996. «Il criterio costituzionale d’origine è
stato quello dell’interesse
esclusivamente locale, il criterio della Costituzione riformata è quello
della sussidiarietà, integrato dalla differenziazione e dall’adeguatezza» (MARENGHI, E.M. Lo statuto
comunale: l’altro modo di essere dell’autonomia. In: SALA, G. Sui caratteri dell’amministrazione comunale
e provinciale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Studi in onore di Giorgio Berti. vol.
II. Napoli: Jovene, 2005, p. 1452).
[45] Prendo in prestito alcune riflessioni di Patrizia Laquidara, cantante d’origine
siciliana ma vicentina d’adozione, in occasione del suo lavoro, «Il canto dell’anguana»,
tra recupero delle radici e tentativi di sperimentazione nella musica popolare
italiana («Jam», XVIII (2011), n. 179, p. 15).
[46] CERNIGLIARO, A. Dall’età dei diritti all’età dei doveri: la dissoluzione della
soggettività nelle ragioni complessive dell’umanità. In: LORUSSO, S. (cur.). Costituzione e ordinamento giuridico.
Convegno per il decennale della Facoltà di Giurisprudenza (Foggia, 24-25
novembre 2006). Milano: Giuffrè, 2009, pp. 43-44; 46.
[47] Cfr. Tar Puglia, Sede di Bari, 20 luglio
2002, sez. II, n. 3518.
[48] Secondo GAMBINO, S. Regioni e autonomie locali, cit., p. 935: «Lo statuto degli enti locali conserva la sua natura giuridica di atto amministrativo generale; tuttavia, esso non trova più la sua fonte di legittimazione in una legge generale della Repubblica, che ne fissa i principi, bensì direttamente nella Costituzione». Cfr. Q. Camerlengo, Statuti comunali e provinciali, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, vol. VI, Giuffrè, Milano 2006, pp. 5744-5746: «La novella costituzionale del 2001 parrebbe testualmente assoggettare gli statuti in parola ai soli "principi fissati dalla Costituzione", suscitando così aspettative circa una promozione di tali fonti al rango primario proprio degli atti legislativi ... Ebbene lo statuto è un atto normativo confezionato dagli organi di governo degli enti locali... compete al legislatore statale disciplinare la potestà statutaria, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Stando così le cose, lo statuto locale è una fonte subordinata alla legge, secondo il criterio gerarchico. Da questo punto di vista, perciò, la riforma del 2001 non ha introdotto alcuna soluzione di continuità rispetto alla pregressa disciplina legislativa, che aveva senza esitazione plasmato lo statuto quale fonte secondaria del diritto. Minoritaria appare la tesi volta a dimostrare la natura primaria della fonte statutaria... L’autonomia, nel cui intangibile nucleo essenziale risulta inclusa la potestà statutaria, non può essere svilita da disposizioni così puntuali e mirate da lasciare agli enti locali soltanto lo spazio per la produzione di norme di mero dettaglio. Ebbene, questo modello trova riscontro nell’art. 4, co. 2, l. 5 giugno 2003, n. 131... Pertanto, l’assetto organizzativo dell’ente locale è rimesso alla disciplina statutaria, entro la cornice abbozzata dal legislatore... Un atteggiamento realisticamente disincantato consiglia una certa dose di cautela quanto alla concreta dinamica di questo assetto di rapporti tra le fonti considerate. La labilità di confine tra norme di principio e norme di svolgimento è una condizione ampiamente confermata... Lo stesso testo unico reca non poche disposizioni estremamente puntuali, tali da concedere scarsi margini di manovra agli statuti locali... Non è difficile immaginare che la futura legge statale ex art. 117, lett. p, nel definire soprattutto la disciplina elettorale, finirà col discostarsi dal modello, ponendo così norme di principio e regole di dettaglio». Circa la garanzia costituzionale del potere normativo locale cfr. DI FOLCO, M. La garanzia costituzionale del potere normativo locale. Statuti e regolamenti locali nel sistema delle fonti tra tradizione e innovazione costituzionale. Padova: Cedam, 2007.
[49] «Si
tratta, dunque, di partire – per dare coerenza e razionalità al processo di
adeguamento e di implementazione della riforma costituzionale – da un lato
dalla determinazione delle funzioni fondamentali degli Enti locali e dall’altro
dalla chiarificazione dei livelli essenziali delle prestazioni connesse a
diritti civili e sociali: il tutto nell’ambito di una prospettiva di riassetto
della finanza pubblica in sintonia con il nuovo orizzonte. Il che è certo assai
complesso sul piano tecnico, ma è comunque condizionato dalla volontà politica
di andare in tale direzione» (DE MARTIN, G.C. Il processo di riassetto dei
ruoli istituzionali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in Studi in onore di Giorgio Berti, cit.,
vol. II, p. 975). Cfr. GAMBINO, Regioni e
autonomie locali, cit., p. 944: «Ne discende che la determinazione dei "livelli essenziali" su tutto il territorio nazionale e la relativa garanzia
sono condizionati, da una parte, dall’entità dei fondi destinati a fini
perequativi e, dall’altra, dalla concreta possibilità da parte degli enti
autonomi di poter incidere collaborativamente con il Parlamento sui criteri
della perequazione medesima. Cosicché, se ne deve concludere che l’attribuzione
in capo al legislatore nazionale di una potestà legislativa esclusiva in
materia di perequazione acquista significato effettivo (solo ed) in quanto essa
persegue le finalità poste dalla prima parte della Costituzione – e tra queste,
in particolare, la garanzia dei princìpi e dei diritti fondamentali – piuttosto
che una mera ed astratta ‘eguaglianza’ fra le autonomie territoriali». Cfr. DE
CHIARA, A. La funzione normativa della Regione e degli enti locali. In: SAN
LUCA, G. Clemente di. (cur.). Comuni e
funzione amministrativa. Torino: Giappichelli, 2007, p. 150-152: «non pare
dubitabile che l’art. 114, co. 1, Cost., nella sua attuale formazione, esprima
la "configurazione equiordinata degli elementi costitutivi della Repubblica" e
la presenza tra questi, a pieno titolo, di Comuni, Province e Città
metropolitane, oltre che Regioni e Stato... Anche in considerazione di ciò,
dunque, stanti l’espresso radicamento della funzione normativa statutaria
direttamente nella Costituzione e l’implicito rifiuto della legge dello Stato
come fonte di disciplina generale in materia di ordinamento degli enti locali,
non sembra possibile che la legislazione statale si spinga oltre la competenza
espressamente riconosciuta dall’art. 117, co. 2, lett. p), Cost., in materia di "legislazione elettorale, organi di
governo e funzioni fondamentali"».
[50] MARINO, I. M. Sulla funzione statutaria e
regolamentare degli enti locali, in Id., Aspetti della recente evoluzione del diritto degli enti locali. Palermo:
Quattrosoli, 2002, p. 88-89. Secondo G. Sala, Sui caratteri dell’amministrazione comunale, cit., pp. 2267-2270:
«L’impressione è dunque che il processo di riordino dei livelli di
amministrazione resti ancora alla ricerca di un assetto da consolidare...
L’evoluzione finora dell’ordinamento rafforza la consapevolezza che, in una
società complessa e in un’organizzazione dei pubblici poteri, di conseguenza,
necessariamente articolata su diversi livelli di governo, non è proponibile un
modello di amministrazione imperniato per ambiti di competenze riservate, e
tendenzialmente separate; l’autonomia si realizza nella creazione di un sistema
integrato non come una sommatoria di una pluralità di enti, ma piuttosto di
responsabilità attribuite a soggetti diversi necessariamente partecipi al
processo di soddisfazione delle attese dei cittadini... l’amministrazione
locale non è strumento dell’amministrazione dello Stato, secondo il modello
dell’autarchia, ma è la parte a diretto contatto con i cittadini, di cui
rappresenta gli specifici interessi quali membri della collettività locale,
dell’amministrazione della Repubblica».
[51] Cfr.
FERRARESE, M.R. La governance tra
politica e diritto. Bologna: il Mulino, 2010.
[52] «Nonostante la novella costituzionale ridisegni dalle fondamenta il rapporto
tra i soggetti che costituiscono la Repubblica, individuando nel Comune il
‘centro motore’ di un sistema dinamico di governo della cosa pubblica, Stato e
Regioni continuano a ‘tenere’ numerose e rilevanti funzioni anche laddove non
sembrano sussistere necessità di esercizio unitario tali da giustificare – ex art. 118, co. 2 Cost. – la
sottrazione al livello comunale» (SAN LUCA, G. Clemente di. Introduzione.
Titolarità ed esercizio della funzione amministrativa nel nuovo assetto del
sistema autonomistico locale. In: SAN LUCA, G. Clemente di. (cur.). Comuni e funzione amministrativa.
Torino: Giappichelli, 2007, p. 15-16).
[53] Cfr.
SIANO, A. De. La funzione amministrativa
degli enti locali. Attuazione del principio di sussidiarietà e adeguatezza
delle risorse finanziarie allo svolgimento dei compiti. In: SAN LUCA, G.
Clemente di. (cur.). Comuni e funzione
amministrativa. Torino: Giappichelli, 2007, p. 237-292.
[54] «In
effetti, essendo le istituzioni locali degli enti non burocratici ma
comunitari, esponenziali degli interessi propri della società civile alla quale
forniscono delle prestazioni di tipo assistenziale e culturale, tali soggetti
non possono non porre al centro della loro considerazione la persona umana,
considerata nella sua storica concretezza. Ne deriva allora la necessità per
gli statuti locali di presupporre, ai fini dell’attribuzione di pretese
partecipative nei confronti degli organi amministrativi, un collegamento effettivo
tra l’interesse di chi partecipa ed il territorio locale, la cui individuazione
non può avvenire mediante il ricorso ad una nozione formale di cittadinanza,
richiedendo invece criteri sostanziali quali appunto la residenza nel
territorio oppure lo svolgimento in esso di attività di studio o di lavoro»
(PAOLA, I. Pluricittadinanza, cittadinanza amministrativa e partecipazione
all’attività dell’amministrazione. In: MANGANARO, F., TASSONE, A. Romano.
(curr.), Persona ed amministrazione.
Privato, cittadino, utente e pubbliche amministrazioni. Torino:
Giappichelli, 2004, p. 269).
[55] Cfr.
POGGI, A. Introduzione. In: Il Piemonte
delle Autonomie. N. 1. S.l.: s.n., 2014, p. 3-7; CIARLO, P., PITRUZZELLA,
G. Monocameralismo: unificare le due camere in un unico Parlamento della
Repubblica. In: Il Piemonte delle
Autonomie. N. 1. S.l.: s.n., 2014, p. 8-10; DOGLIANI, M. Appunto sulla
possibile riforma del Senato: una seconda Camera, non una Camera secondaria.
In: Il Piemonte delle Autonomie. N.
1. S.l.: s.n., 2014, p. 11-13; VIOLINI, L. Le
prospettive di riforma del bicameralismo italiano. In: Il Piemonte delle Autonomie. N. 1. S.l.: s.n., 2014, p. 14-21; Dossier di documentazione e approfondimento.
Le province e la riforma del sistema bicamerale, In: Il Piemonte delle Autonomie. N. 1. S.l.: s.n., 2014, p. 81-84;
LUTHER, J. Il bicameralismo si supera se
si reinventa (ma anche se si rottama). In: Il Piemonte delle Autonomie. N. 1. S.l.: s.n., 2014, p. 22-36.
[56] Cfr.
ALLEGRETTI, U. La pubblica amministrazione e il sistema delle autonomie. In:
FIORAVANTI, M. (cur.). Il valore della
Costituzione. L’esperienza della democrazia repubblicana. Roma-Bari:
Laterza 2009, p. 157-158, che argomenta le sue tesi anche in merito agli spunti
forniti dall’urbanista Alberto Magnaghi.
[57] Per qualche esempio sulle diverse direzioni
intraprese dalla storiografia giuridica negli ultimi anni, cfr. ASCHERI, M. Famiglia, potere e legislazione nelle città-Stato
‘popolari’ (secc. XIII.-XIV). In: PAGLIANTINI, S., QUADRI, E., SINESIO, D.
(curr.). Scritti in onore di Marco
Comporti. vol. I. Milano: Giuffrè, 2008, p. 71-86; ASCHERI, M. La
pace negli statuti dei Comuni toscani: una introduzione. In: COLLI, V., CONTE,
E. (curr.). Iuris Historia. Liber
Amicorum Gero Dolezalek. Berkeley: Robbins Collection, 2008, p. 73-87; ASCHERI,
M. Statutory Law of Italian Cities from Middle Ages to Early Modern. In:
DROSSBACH, G. (cur.). Von der Ordnung zur
Norm: Statuten in Mittelalter und Früher Neuzeit. Paderborn: F. Schöningh, 2010, p. 201-216; ASCHERI, M.
Agli albori della primavera statutaria. In: CONTE, E., MIGLIO,
M. (curr.), Il diritto per la storia: gli studi storico giuridici nella
ricerca medievistica. Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo,
2010, pp. 19-23; ASCHERI, M.
Siena nel 1310: la giustitia s’offende et la verità si cela. Mélanges de
l’École française de Rome - Moyen Âge [Online], 126-2|2014, Messo online
il 06 agosto 2014, consultato il 26 gennaio 2015. URL:
http://mefrm.revues.org/2122; BAMBI, F. «Alle origini del
volgare del diritto. La lingua degli statuti di Toscana tra XII e XIV secolo», Mélanges
de l’École française de Rome - Moyen Âge [Online], 126-2|2014, Messo
online il 06 agosto 2014, consultato il 26 gennaio 2015. URL:
http://mefrm.revues.org/2112; STORTI, C. Gli
statuti tra autonomie e centralizzazioni nel medioevo. In: CONTE,
E., MIGLIO, M. (curr.), Il diritto per la storia: gli studi storico
giuridici nella ricerca medievistica. Roma: Istituto Storico Italiano per
il Medio Evo, 2010, pp. 35-52; ASCHERI, M., DANI, A. La mezzadria nelle terre di Siena e Grosseto:
dal medioevo all’età contemporanea. Siena:
Pascal, 2011; DANI, A. Le risorse
naturali come beni comuni. Arcidosso: Effigi, 2013; DANI, A. Il concetto
giuridico di "beni comuni" tra passato e presente. In: Historia
et ius [www.historiaetius.eu], 6 (2014), paper 7, pp. 1-48; DANI, A.,
RONDONI, A. (curr.). Chianciano e i suoi statuti in età moderna: una comunità
federata dello Stato di Siena,
introduzione di M. Ascheri. Monteriggioni: Il Leccio, 2014; FIORAVANTI,
M. Costituzionalismo dei beni comuni. In: Storica, 19, 2013, pp. 103-137; FIORAVANTI, M. Diritto alla città e azione popolare, (a
proposito di Paolo Maddalena, Il
territorio bene comune degli Italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata
e interesse pubblico, Introduzione di Salvatore Settis, Roma, Donzelli,
2014). In: Historia et ius [www.historiaetius.eu], 5 (2014), paper 18, pp. 1-5; ANNICHINI, A.
Legnani. Il paradigma della giustizia locale in una terra emiliana: gli statuti di
San Felice sul Panaro del 1464. In: Historia et ius [www.historiaetius.eu], 2 (2012), paper 3, pp. 1-28;
MAZZANTI, G. Rileggendo gli Statuti di Gemona nel Friuli. In: Historia et ius [www.historiaetius.eu],
1 (2012), paper 6, pp. 1-16; STANCO, G. Gli statuti di Ariano. Diritto municipale e identità urbana tra
Campania e Puglia, cit.; GAMBA, C. Comunità e statuti della provincia romana.
Roma: Aracne, 2012; EDIGATI, D., TANZINI, L. Ad statutum florentinum. Esegesi statutaria e cultura giuridica nella
Toscana medievale e moderna. Pisa: Ets, 2009.
[58] Cfr. FIORILLO, F., ROBOTTI, L.
(curr.). L’unione dei comuni. Teoria
economica ed esperienze concrete. Milano: F. Angeli, 2006; Dall’unione alla fusione dei comuni.
Rimini: Maggioli, 2012; COMINI, I., MOI, F. Le città metropolitane nella
riforma "Delrio". In: Il Piemonte delle Autonomie, 1 (2014), n. 3, pp. 57-70.
[59] CAZZETTA, G. Pagina introduttiva. Autonomia: per un’archeologia del sapere
giuridico fra Otto e Novecento. In: Quaderni
Fiorentini, 43, vol I, 2014, pp. 1-2; Cfr. anche SORDI, B. Selfgovernment, Selbstverwaltung, autarchia: fondali inglesi per scenografie
continentali, in «Quaderni Fiorentini», 43 (2014), vol. I,
pp. 135-163; OLIVETTI, M. L’autonomia statutaria tra omogeneità e differenziazione,
in L’affermazione dell’autonomia-Federalismo, Unità, Regioni. Atti del convegno
(Torino, 13 maggio 2011). In: Il Piemonte
delle Autonomie, 1 (2014), n. 1, pp. 38-51; PASTORI, G. Le autonomie territoriali nell’ordinamento
repubblicano, in L’affermazione
dell’autonomia, cit., pp. 52-60. Per una storia semantica di ‘autonomia’
cfr. MANNORI, L. Autonomia. Tracciato di un lemma nel vocabolario
amministrativo italiano dal Settecento alla Costituente. In: L’affermazione dell’autonomia, cit., pp.
26-37; MANNORI, L. ‘Autonomia’ Fortuna di un lemma nel vocabolario delle
libertà locali tra Francia ed Italia. In:
Quaderni Fiorentini, 43 (2014), vol.
I, pp. 65-134; COSTA, Pietro. Così lontano, così vicino: il Comune medievale e la sua 'autonomia'.
In: Quaderni Fiorentini, 43 (2014), vol. II, pp. 689-782. «Nel momento
in cui ‘allontaniamo’ il Comune medievale per sottrarlo dal cono d’ombra della
moderna statualità, non possiamo comunque evitare di interrogarlo a partire dal
nostro orizzonte ermeneutico (post statuale e, se si vuole, post moderno) e
rendiamo quindi, di nuovo, problematica la sua ‘alterità’. Lo ‘allontaniamo’
per cogliere la sua originale forma di vita e assumiamo al contempo la
lontananza ad esso restituita come l’orizzonte entro il quale la rappresentazione
del passato diviene un momento della nostra autocomprensione» (Ivi, p. 782).
Per qualche breve riflessione mi permetto di rinviare a STANCO, G. Le
prospettive del policentrismo in Italia ‒ Radici e costruzioni identitarie tra
storiografia e dottrina giuridica. In: A&C Revista de Direito
Administrativo e Constitucional, n. 49, 2012, pp. 67-108.
[60] Cfr.
TREMONTI, G., VITALETTI, G. Il
federalismo fiscale. Autonomia municipale e solidarietà sociale. Roma-Bari:
Laterza, 1994; GIARDA, P. Regioni e
federalismo fiscale. Bologna: il Mulino, 1995; BORDIGNON, M. (cur.). Federalismo fiscale. Proposta per un modello
italiano, Milano: F. Angeli, 1996; JANZ, O., SCHIERA P., SIEGRIST, H. (curr.).
Centralismo e federalismo tra Ottocento e
Novecento. Italia e Germania a confronto. Bologna: il Mulino, 1997; PICA,
F. Del federalismo fiscale in Italia.
Scritti sul tema dal 1994 al 2003. Napoli: Grimaldi, 2004; ANTONINI, L.
(cur.). Verso un nuovo federalismo
fiscale. Milano: Giuffrè, 2005; AMATUCCI, F., SAN LUCA, G. Clemente di.
(curr.). I principi costituzionali e
comunitari del federalismo fiscale. Torino: Giappichelli, 2008; GIARDA, P. La favola del federalismo fiscale.
Milano: Università cattolica del Sacro Cuore, 2009; FERRARI, G.F. (cur). Federalismo, sistema fiscale, autonomie.
Modelli giuridici comparati. Roma: Donzelli, 2010; RUFFINI, E.M. Federalismo fiscale: la grande illusione.
Milano: pref. di V. Visco, Novecento media, 2010; PEZZANI, F., PREITE, D. L’attuazione del federalismo fiscale: quale
autonomia finanziaria? Milano: Egea, 2011; URICCHIO, A. (cur.). I percorsi del federalismo fiscale. Bari:
Cacucci, 2012; GAMBINO, S. (cur.). Il
federalismo fiscale in Europa. Milano: Giuffrè, 2014.
[61] SALVEMINI,
G. Federalismo, regionalismo, autonomismo [1945], In: SALVEMINI, G. Scritti sulla questione meridionale
(1896-1955). Torino: Einaudi, 1955, doc. LVII, p. 595.
Author notes
Assistant Professor in History of
Medieval and Modern Law at Università LUM "Jean
Monnet" (Casamassima, Italy). In 2006 he became
researcher fellow in History of Medieval and Modern Law at the same university.
Degree in Law at the Università
degli studi di Salerno (Fisciano, Italy). He had different
scholarships financed by: the Università degli studi di Salern; the Second University of Naples; the European
Centre for Norman Studies (Ariano Irpino,
Italy), the University of Naples "Frederick II"; the University of Naples "Suor Orsola Benincasa".
He is fellow in the following academic institutions: the Italian Society for
the History of Law; the Neapolitan Society of National History; the European
Centre of Norman Studies.